
Autore: editore
Catechesi in tutti i sensi Riflessioni e indicazioni per una catechesi “sensibile”
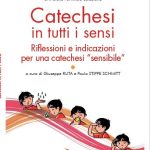
a cura di
Giuseppe Ruta* – Paulo Stippe Schmitt**
* Salesiano, professore ordinario di Catechetica e Direttore dell’ICa, Facoltà di Scienze dell’Educazione, Università Pontificia Salesiana di Roma.
** Presbitero dell’Arcidiocesi di Florianópolis (Brasile) e dottorando in Scienze dell’Educazione presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.
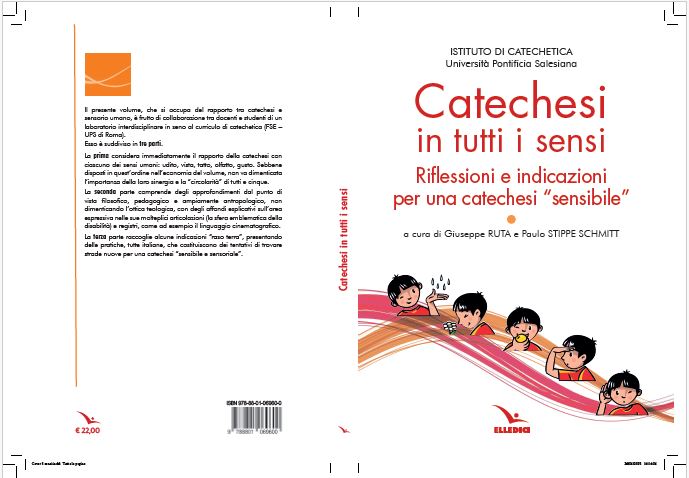
il volume sarà disponibile nelle librerie a fine agosto
ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
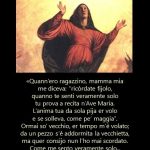
Lectio – Anno C
Prima lettura: Apocalisse 11,19;12,1-6.10
| Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». |
- Il brano fa parte di una sezione dell’Apocalisse, ricca di immagini, simboli e segni (il settenario delle coppe, la donna vestita di sole, il drago, le due bestie ecc.), di difficile interpretazione. Ma, come si rileva oggi nello studio di questo particolare libro neotestamentario, il messaggio che viene trasmesso alla comunità che lo legge e lo ascolta, è un messaggio di consolazione e di salvezza, di vittoria e di vita (al contrario di quell’uso improprio che fa del termine «apocalisse» un sinonimo di catastrofe e di distruzione).
«Apparve nel tempio l’arca della sua alleanza»: secondo la tradizione, l’arca dell’alleanza conteneva un’urna d’oro con un po’ di manna, il bastone fiorito di Aronne e frammenti delle tavole della legge (vedi Dt 10,1-2;Es 16,33-34; Nm 17,16-26). Ma soprattutto l’arca dell’alleanza era venerata come il segno visibile della presenza e della dimora di Dio in mezzo al suo popolo. Con la caduta di Gerusalemme e del tempio (nel 586 a.C. sotto gli eserciti babilonesi) l’arca era però andata perduta e di essa non si era saputo più nulla. Questa sua apparizione nel libro dell’Apocalisse vuole evocare la storia della salvezza e allude al compimento di essa nella persona di Gesù. Non va però neppure dimenticato che nel Nuovo Testamento (specialmente in Luca) è Maria la nuova dimora di Dio, la nuova arca dell’alleanza (questo sarà decisivo nell’interpretare in chiave mariana la figura della «donna vestita di sole»). «Una donna vestita di sole»: questa figura è stata interpretata ora in chiave ecclesiologica (è il nuovo popolo di Dio, la Chiesa, in lotta con le forze del male che la vogliono distruggere), ora in chiave mariana (è la madre del Messia, la Vergine Maria, che nella tradizione giovannea è presentata come la «donna», con evidente allusione a Gn 3,15: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa»).
«Il drago rosso»: il «drago» richiama il serpente di Gn 3, ma è anche l’immagine di Satana, il nemico di Dio e dell’uomo. È il simbolo delle forze del male che combattono il bene, ma che non avranno il sopravvento. «Sette teste… sette diademi»: sono immagini di un potere illimitato e di una potenza difficile da abbattere dall’uomo (ma non da Dio). «Il figlio maschio»: probabilmente è un’allusione al Messia, capo del nuovo popolo che Dio si è scelto e che non può rimanere in balìa delle forze del male. Da lui verranno la salvezza e la vittoria per tutta l’umanità.
Come si vede, il brano risente di un particolare genere letterario, che è quello dell’apocalittica (dal greco apokalypto, «rivelo»), molto in voga ai tempi del Nuovo Testamento. Ricorrendo alle immagini, ai segni e ai simboli (dei colori, degli animali, dei numeri, delle caratteristiche fisiche, degli astri e dei fenomeni atmosferici ecc.), questo genere letterario era particolarmente usato per descrivere la fine del tempo e del mondo o avvenimenti straordinari e decisivi per la salvezza dell’uomo.
Seconda lettura: 1Corinzi 15,20-27a
| Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. |
- La risurrezione è il tema del capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. Il nostro brano (assai simile a Rm 5,12-15) si sofferma sulla riflessione biblico-teologica di questo straordinario evento, partendo dal parallelismo Adamo-Cristo. Il primo è immagine dell’uomo vecchio, ancora sotto il peccato, e che ha in sé la morte. Cristo invece è l’uomo nuovo, il primo dei risorti (la risurrezione indica una nuova condizione dell’uomo, quella definitiva), l’inizio di una umanità non più dominata dalla morte. Paolo non si sofferma sul «come» della risurrezione, ma sulla sua certezza. Ispirandosi alla letteratura apocalittica, egli descrive gli ultimi avvenimenti dell’uomo e del mondo secondo un particolare ordine, che a noi sfugge (è il significato dei vv. 23-24: «Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre»).
Come avviene spesso nelle lettere di Paolo, il peccato e la morte vengono personificati. Per questo si dice che la morte «regna» (Rm 5,14), è «l’ultima nemica» (1Cor 15,26), il suo «pungiglione» è il peccato (1Cor 15,26). Vincendo la morte con la sua risurrezione, Cristo ha offerto all’uomo un nuovo destino e una nuova dimensione, che lo aiutano a vivere ogni evento con un nuovo sguardo, una nuova luce, una nuova attitudine (quella del bene da compiere e della fede da vivere).
Vangelo: Luca 1,39-56
| In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. |
Esegesi
Il rovesciamento delle sorti cantato nel Magnificat (Lc 1,46-55), visibile anche nelle vite della sterile resa feconda e della vergine resa madre (Lc 1,39-45), è un riflesso del rovesciamento radicale della sorte della storia dell’umanità verificatosi nell’evento pasquale, nella morte e resurrezione di Cristo (seconda lettura). Evento che ha ripercussioni su Israele, sulla chiesa, sull’umanità, di cui è simbolo «la donna» che partorisce il Messia (prima lettura). In una lettura simbolica, Maria appare figura dell’umanità, rappresentante dell’Israele fedele, «figlia di Sion», e figura della chiesa e dei credenti in Gesù Messia.
Maria viene salutata da Elisabetta come donna di fede: «Beata colei che ha creduto che vi sarebbe stato un compimento alle parole dette a lei dal Signore» (Lc 1,45). La fede di Maria è un atto preciso, storico, e personalissimo. Non è un’adesione a generici valori, ma ferma convinzione che la parola che il Signore ha pronunciato riguardo a lei diventerà storia, realtà, la sua storia personale e la sua realtà personale. O meglio, che è già sua realtà e sua storia che plasma il suo corpo e la sua psiche, guida i suoi atti, muove i suoi passi, ispira i suoi pensieri. La fede rende operante l’efficacia della parola grazie alla disponibilità all’apertura e al cambiamento del credente. Maria è già madre, e come tale è salutata da Elisabetta. È madre a partire dalla sua accoglienza della parola del Signore. Se la preghiera efficace crede che ciò che domanda è già stato ottenuto (Mc 11,24), la fede manifesta la sua efficacia e la sua potenza nella convinzione che ciò che il Signore dice è realtà, anche se si scontra con ogni razionale evidenza, come nel caso della vergine a cui è promesso di concepire senza conoscere uomo.
Il Magnificat, preghiera in bocca a Maria e costituita da reminiscenze bibliche, mostra come dalla preghiera nasca la preghiera.
La preghiera, soprattutto comunitaria e liturgica, è capace di generare altra preghiera, soprattutto personale. La liturgia svolge un magistero eucologico indirizzando e suscitando la preghiera dei singoli e delle comunità. Abbiamo qui un bell’esempio di fedeltà e creatività nella preghiera, di continuità e innovazione all’interno di una tradizione di preghiera. Il carattere composito del Magnificat non inficia la sua originalità che risiede nel modo con cui i versetti citati sono accostati e nell’intenzione della persona che li ha ‘tessuti’ insieme e li prega in quella forma.
Se la fede di Maria si esprime nella preghiera, la sua preghiera manifesta anzitutto il riconoscimento di ciò che Dio ha compiuto. Lei che si riconosce vista, guardata da Dio nella sua piccolezza (Lc 1,48), sa vedere l’azione di Dio.
Il Magnificat è un canto che sale dal basso, dalla situazione di piccolezza in cui si trova Maria. Parla di Dio come del Signore, del Salvatore, del Potente, del Santo, del Misericordioso, di Colui che ha operato cose potenti. E parla dei superbi che sono stati dispersi e dei potenti che sono stati deposti dai troni, mentre sono stati innalzati gli umili. E nel Magnificat Maria, parla di sé come «serva», in linea con l’Israele servo che il Signore ha soccorso. Il Magnificat è una pedagogia di umiltà. La parola di Dio che ha reso madre Maria, l’ha anche resa figlia facendola rinascere, operando in lei un mutamento radicale: «A quanti accolgono la parola, ha dato potere di diventare figli di Dio».
Il Magnificat consente a Maria di cogliere come elemento unificante dell’agire di Dio nei confronti suoi e nei confronti dell’intera storia di Israele, la misericordia. La preghiera è anche discernimento dell’agire di Dio colto nel suo nucleo essenziale e imprescindibile. Ma leggendo la storia di Dio con Israele alla luce della misericordia, Maria fa della sua preghiera anche una profezia: i verbi potrebbero anche essere declinati al futuro e riguardare ogni uomo, tutta l’umanità. Maria, che ha creduto al compimento della parola di Dio nella sua vita, crede anche al compimento della parola di Dio e della sua azione nella storia umana: crede che il Regno sarà il compimento della storia. E impegna chiunque prega quotidianamente il Magnificat a entrare nella stessa fede.
Meditazione
La solennità odierna dell’Assunzione al cielo di santa Maria, la prima e la più grande dei credenti in Cristo, ci invita a spingere il nostro sguardo, la nostra riflessione e la nostra preghiera verso il nucleo della nostra fede – il mistero di morte e risurrezione del Signore Gesù – per sostenere il nostro cammino di discepoli del vangelo. La interminabile lotta tra bene e male (cfr. prima lettura), che da sempre mette in pericolo la nostra esistenza, riceve un decisivo impulso verso la vita, verso la pienezza della vita, la vita di Dio e con Dio, la vita nell’amore, che solo riesce a resistere all’assalto del Maligno.
Una volta ricevuta notizia di una non prevista e impegnativa maternità, accolta peraltro con disponibilità e umiltà (cfr. Lc 1,26-38), Maria cerca il confronto, qualcuno che possa ascoltare e comprendere la sua vicenda e la sua situazione. Ma bisogna uscire dal solito giro del vicinato, subito pronto a facili e chiacchierate interpretazioni. Chi meglio di una parente maggiore in età ed esperienza, accomunata dalla medesima avventura della gravidanza – da lei pure ricevuta in modo inatteso – e che risiede sui monti della Giudea? Moltissimi e contrastanti i sentimenti che si affollano nel cuore di Maria ma questi producono un’accelerazione dei suoi passi, che si muovono rapidi verso la casa di Elisabetta. La giovane, probabilmente, credeva di dover a lungo spiegare e motivare il suo viaggio e la sua gravidanza: le due donne si ritrovano, invece, immediatamente in perfetta sintonia, accomunate dalla gratitudine verso la benevolenza di Dio e in una perfetta reciprocità femminile. Ne scaturisce una festa canora, di lodi al Signore che fa «grandi cose» (1,49), «innalza gli umili» (1,52), soccorre i suoi servi (cfr. 1,54). Elisabetta ha un sussulto interiore, ha come la percezione che il figlio che porta in grembo cerchi di comunicare con il suo ‘omologo’ rac-chiuso nel ventre di Maria – i bambini sempre si cercano e creano condivisione – e si scopre ricolma di gioia. La comune fiducia verso il Signore, che si ricorda delle promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza (cfr. 1,55), dona reciproca solidità e forza al proprio cammino!
Maria avrebbe potuto innalzare il suo Magnificat appena Gabriele l’aveva lasciata: il contenuto della promessa di grazia c’era già tutto! Invece la condivisione delle proprie esperienze con Elisabetta – c’è chi ha definito quest’incontro la festa della lectio divina, in cui ognuna offre all’altra la propria lettura spirituale della vita a partire dalla testimonianza della fede dei padri – porta a compimento la maturazione della fede, che è sempre comunitaria e non può rivolgersi a Dio in modo solipsistico. Maria ascolta, crede, agisce, condivide, loda e ringrazia: ci sono tutte le componenti fondamentali di una fede matura! Ecco perché allora Maria può divenire – ancora una volta per grazia ricevuta – modello di ogni credente anche a riguardo della vita oltre la morte: diviene la prima creatura che partecipa della vita divina, della risurrezione in Cristo, come ci ricorda bene la seconda lettura: «Tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo» (1Cor 15,22-23). E Maria ‘è di Cristo’ non tanto perché ne è stata la madre naturale, in un rapporto assolutamente unico e singolare, ma perché è stata la prima dei credenti nel Figlio suo, discepola del vangelo in modo pieno e senza ripensamenti: questa è la sua vera grandezza!
Eppure il male continua ad attraversare e sconvolgere il mondo e la vita di ognuno di noi, nonostante la vittoria che Cristo ha riportato sul nostro desiderio di trattenere egoisticamente il bene di cui facciamo esperienza. Questo «enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna» (Ap 12,3) continua a seminare morte e dolore, non senso e violenza. Maria è la prima che accetta di combattere fino in fondo contro di lui, cercando di portare a compimento quella gravidanza che può generare nella storia il Solo che può vincerlo (cfr. Ap 12,2.4-6). Accogliamo l’invito alla condivisione che ci giunge dall’esperienza di Maria e disponiamoci a combattere in noi e attorno a noi la «buona battaglia della fede» (2Tim 4,7) per cantare con lei: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». L’invito è a ritrovarci tutti m cielo…
Don Bosco commenta il Vangelo
Assunzione della B. V. Maria
Il Magnificat canta il trionfo dell’umiltà
Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore” (Lc 11,46). Leggiamo nella Vita di S. Giovanni Battista questa definizione del Magnificat, cantico dell’umiltà:
Maria per rispondere ad Elisabetta e per celebrare le grandezze di Dio, pronunziò il cantico del Magnificat che ormai da diciannove secoli fa risuonare le volte dei templi cristiani, e che noi teniamo come il trionfo dell’umiltà sulla superbia del secolo. È un atto ben autentico della riconoscenza che essa aveva per tutti i favori di cui Iddio l’aveva ricolmata, ed una gloriosa confessione della bassezza, dalla quale era stata tratta, per essere elevata alla dignità di Madre di Dio […]. Ecco come l’umile Maria nulla vuole per sé, ma tutto riferisce a Dio. Impariamo da questo a conoscere e ad imitare l’umiltà di Maria (OE20 390s).
Maria aggiunge: «D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48). Nell’introduzione al mese di Maria nel Cattolico provveduto per le pratiche di pietà, si legge:
Sono diciotto secoli da che la SS. Vergine inspirata da Dio esclamava: Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Queste sue parole profetiche nel corso di tanti secoli sempre si avverarono, e vanno tuttora avverandosi. Le nazioni della terra la proclamano beata e gareggiano fra loro nell’onorare la madre del comun Salvatore, nel predicarne le lodi, nel farne risuonare per tutto il nome potente, nel venerarla, nell’invocarla, e cercare nuovi modi, nuove forme, onde sfogare verso di lei l’affetto del loro cuore (OE19 371).
Per dimostrare che Maria è il nostro aiuto, don Bosco scrive nel suo opuscolo intitolato Maraviglie della Madre di Dio invocata sotto il titolo di Maria Ausiliatrice:
Perché l’avrebbero chiamata beata tutte le generazioni? Questa parola non abbraccia solo tutti gli uomini che vivevano a quel tempo, ma quelli ancora che sarebbero venuti dopo sino alla fine del mondo. Ora affinché la gloria di Maria potesse estendersi a tutte le generazioni e avessero a chiamarla beata, bisognava che qualche benefizio straordinario e perenne venisse da Maria a tutte queste generazioni; cosicché essendo perpetuo in esse il motivo di loro gratitudine fosse ragionevole la perpetuità della lode. Ora questo benefizio continuo e mirabile non può esser altro che l’aiuto che Maria presta agli uomini. Aiuto che doveva abbracciare tutti i tempi, estendersi a tutti i luoghi, ad ogni genere di persone. […] In tutte le generazioni si trovarono dei convertiti alla fede di Cristo che benedissero alla Vergine; e nello stesso Alcorano, che è il libro scritto da Maometto, si trovano parecchie lodi a Maria. Per questo appunto Maria è proclamata beata presso tutte le generazioni (OE20 219ss).
Poi don Bosco cita nello stesso libro questo commento pieno di “unzione ed abbondanza di sentimenti” del cardinale Ugone:
Mi chiameranno beata tutte le generazioni, cioè dei Giudei, dei gentili, oppure degli uomini e delle donne, dei ricchi e dei poveri, degli angeli e degli uomini, giacché tutti per essa ricevettero il benefizio della salute. Furono gli uomini riconciliati, gli angeli riparati, imperocché Cristo Figliuolo di Dio operò la salute in mezzo alla terra, cioè nel seno di Maria, la quale in certo modo può chiamarsi il centro della terra. Poiché ad essa rivolgono lo sguardo quei che godono in cielo, e quei che abitano nell’inferno, cioè nel limbo, e quei che militano nel mondo. I primi per essere risarciti, i secondi per essere espiati, i terzi per essere riconciliati. Dunque beata diranno Maria tutte le generazioni (OE20 221s).
Maria continua: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente» (Lc 1,49). Commentando il grande dipinto che sovrasta l’altare maggiore della nuova chiesa in onore di Maria Ausiliatrice, don Bosco scrive nelle sue Maraviglie della Madre di Dio:
La Vergine campeggia in un mare di luce e di maestà, assisa sopra di un trono di nubi. La copre un manto che è sostenuto da una schiera di angeli, i quali facendole corona le porgono ossequio come loro regina. Colla destra tiene lo scettro che è simbolo della sua potenza, quasi alludendo alle parole da lei proferite nel santo Vangelo: Fecit mihi magna qui potens est. Colui, Dio, che è potente, fece a me cose grandi (OE20 319).
(Morand Wirth)
Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.
Santa Maria
Santa Maria, Madre tenera e forte, nostra compagna di viaggio sulle strade della vita, ogni volta che contempliamo le cose grandi che l’Onnipotente ha fatto in te, proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze, che sentiamo il bisogno di allungare il passo per camminarti vicino.
Asseconda, pertanto, il nostro desiderio di prenderti per mano, e accelera le nostre cadenze di camminatori un po’ stanchi.
Divenuti anche noi pellegrini nella fede, non solo cercheremo il volto del Signore, ma, contemplandoti quale icona della sollecitudine umana verso coloro che si trovano nel bisogno, raggiungeremo in fretta la «città»…
(don Tonino Bello)
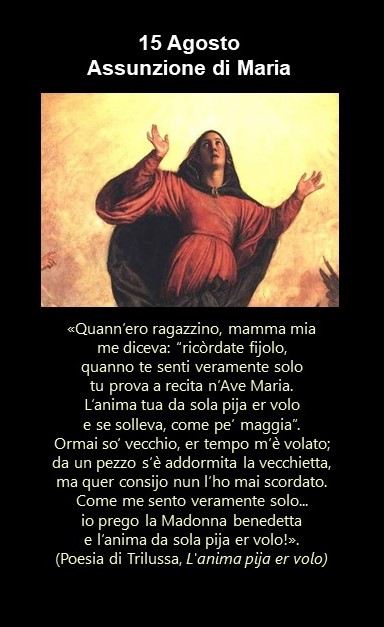
| Festa di Maggio a Moral de Hornuez – 2010 |
Preghiere e racconti
Maria, il futuro che noi aspettiamo
Maria ha detto a Dio il sì più bello e più grande; nessuno, più di lei, ha aperto a Dio la porta del cuore; nessuno più di Maria continua a spendersi totalmente per la realizzazione dei disegno di salvezza, che è la passione di Dio verso l’umanità. Per questo Maria continua a parlarci per orientarci a Gesù.
La Madonna nel corso dei secoli ha fatto sentire la sua “maternità attiva”. E’ un fatto commovente! Ed è in perfetta linea con lo stile di Dio, che gioisce quando qualcuno si sintonizza sui suoi sentimenti e collabora con il suo progetto di recupero dell’umanità: un progetto che è ancora in pieno svolgimento.
Maria ricorda bene che Gesù le ha affidato il discepolo Giovanni e, in lui, tutta l’umanità: Maria passa il suo cielo facendo la Madre! Per questo tutte le apparizioni di Maria non aggiungono nulla al Vangelo, ma soltanto lo richiamano: Maria, come una buona mamma, prende la penna del cuore e sottolinea alcune frasi di Gesù per imprimerle nuovamente nella nostra memoria. Maria non fa altro che ripeterci quanto disse alle nozze di Cana: “Fate quello che Gesù vi dirà” (Gv 2,5).
E qual è il criterio con cui Maria continua a parlarci? Lo svela nel suo Magnificat. Rispondendo alle parole di saluto di Elisabetta, Maria esclama con disarmante lealtà: “Elisabetta, io sono felice nel Signore e lodo con tutta l’anima Dio, mio Salvatore. Perché lui ha rivolto il suo sguardo sulla piccolezza della sua serva. Lui ha fatto tutto, mentre io mi sono abbandonata alle sue mani. Per questo Maria può cantare ancora: “Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” (Lc 1,51-52). Maria fa suo lo stile di Dio: anch’ella posa lo sguardo sulle persone umili e ripete: ” Ricordatevi quanto è scritto nel Vangelo, perché vi rivela quali sono le scelte e le preferenze di Dio. Ricordatevi le parole di Gesù: “Beati sono i poveri nel cuore, perché di essi è il regno dei cieli” (Mt 5,3). La Madonna ci ricorda che Dio sta spingendo la storia verso il trionfo finale degli umili e dei poveri. E continua a parlarci tra le lacrime del dolore, tra le gioie degli affetti veri e puliti, tra le fatiche del lavoro quotidiano; Maria continua a parlarci per orientarci a Gesù. Ella infatti ha un solo nome da dire: Gesù! Ella ha una sola certezza da proporre: Gesù! Ella ha un solo segreto da svelarci: Gesù! Gesù è la strada da percorrere ed è anche la meta da raggiungere. Gesù è Dio che si è fatto vicino, ma è anche Dio da cercare ogni giorno.
E Maria cammina tra le onde delle Ave Maria che si rincorrono da un capo all’altro della terra e spinge le nostre fragili vele verso l’approdo della pace, al di là delle guerre, al di là delle lacrime e al di là della morte. Sì, perché l’ultima parola sarà la Vita: la Vita eterna condivisa con Dio, oceano inesauribile e instancabile della gioia vera, la gioia che tutti cerchiamo! E Maria ci sarà accanto: accenderà tutte le lampade della festa, assicurandoci che non ci sarà mai più una carestia di felicità, ci presenterà i santi del cielo e tutto sembrerà un sogno a occhi aperti: un sogno diventato vita, una vita diventata sogno!
Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l’affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Prega per noi il Padre delle misericordie, perché tocchi i nostri cuori induriti, pieghi le volontà ribelli, ci scuota dal torpore spirituale, ci converta al suo amore fedele.
Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire, perché la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi: un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Libera il mondo intero dal flagello della guerra, ottieni all’umanità la sospirata pace e l’universale fraternità.
Maria, assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo! La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio.
Donna del nostro futuro, inizia il futuro quaggiù! Amen.
(Angelo COMASTRI, L’angelo mi disse. Autobiografia di Maria, Milano, San Paolo, 2007).
Assunzione di Maria
Oggi la Chiesa celebra una delle feste più importanti dedicate alla Beata Vergine Maria: la festa della sua Assunzione. Al termine della sua vita terrena, la Madre di Cristo è salita in anima e corpo al Cielo, cioè nella gloria della vita eterna, nella piena comunione con Dio.
L’odierna pagina del Vangelo (Lc 1,39-56) ci presenta Maria che, subito dopo aver concepito Gesù per opera dello Spirito Santo, si reca dall’anziana parente Elisabetta, anch’essa miracolosamente in attesa di un figlio. In questo incontro pieno di Spirito Santo, Maria esprime la sua gioia con il cantico del Magnificat, perché ha preso piena coscienza del significato delle grandi cose che si stanno realizzando nella sua vita: per mezzo di lei giunge a compimento tutta l’attesa del suo popolo.
Ma il Vangelo ci mostra anche qual è il motivo più vero della grandezza di Maria e della sua beatitudine: il motivo è la fede. Infatti Elisabetta la saluta con queste parole: «Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto» (Lc 1,45). La fede è il cuore di tutta la storia di Maria; lei è la credente, la grande credente; lei sa – e lo dice – che nella storia pesa la violenza dei prepotenti, l’orgoglio dei ricchi, la tracotanza dei superbi.
Tuttavia, Maria crede e proclama che Dio non lascia soli i suoi figli, umili e poveri, ma li soccorre con misericordia, con premura, rovesciando i potenti dai loro troni, disperdendo gli orgogliosi nelle trame del loro cuore. Questa è la fede della nostra Madre, questa è la fede di Maria!
Il Cantico della Madonna ci lascia anche intuire il senso compiuto della vicenda di Maria: se la misericordia del Signore è il motore della storia, allora non poteva «conoscere la corruzione del sepolcro colei che ha generato il Signore della vita» (Prefazio). Tutto questo non riguarda solo Maria. Le “grandi cose” fatte in lei dall’Onnipotente ci toccano profondamente, ci parlano del nostro viaggio nella vita, ci ricordano la meta che ci attende: la casa del Padre.
La nostra vita, vista alla luce di Maria assunta in Cielo, non è un vagabondare senza senso, ma è un pellegrinaggio che, pur con tutte le sue incertezze e sofferenze, ha una meta sicura: la casa di nostro Padre, che ci aspetta con amore. E’ bello pensare questo: che noi abbiamo un Padre che ci aspetta con amore, e che anche la nostra Madre Maria è lassù e ci aspetta con amore.
Intanto, mentre trascorre la vita, Dio fa risplendere «per il suo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza» (ibid.). Quel segno ha un volto, quel segno ha un nome: il volto luminoso della Madre del Signore, il nome benedetto di Maria, la piena di grazia, perché ha creduto nella parola del Signore: la grande credente! Come membri della Chiesa, siamo destinati a condividere la gloria della nostra Madre, perché, grazie a Dio, anche noi crediamo nel sacrificio di Cristo sulla croce e, mediante il Battesimo, siamo inseriti in tale mistero di salvezza.
Oggi tutti insieme la preghiamo, perché, mentre si snoda il nostro cammino su questa terra, lei rivolga a noi i suoi occhi misericordiosi, ci rischiari la strada, ci indichi la meta, e ci mostri dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del suo seno. E diciamo insieme: O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
(Angelus di Papa Francesco nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria – piazza San Pietro, sabato 15 agosto 2015).
Parti per il cielo, ma non abbandoni la terra
Noi ti rendiamo grazie, Signore, che provvedi a tutto il creato, per questi misteri e, soprattutto, perché hai scelto Maria quale ministra dei tuoi misteri. Ti rendiamo grazie per la tua ineffabile sapienza, per la tua potenza e il tuo amore per gli uomini, perché non solo hai voluto unire a te la nostra natura e in te glorificarla e divinizzarla, ma soprattutto perché non hai ritenuto indegno di prenderti per madre una di noi e di farne la regina dell’universo, del cielo e della terra.
Ti rendiamo grazie, Padre di tutti, perché hai voluto che tua madre diventasse anche nostra madre […] Noi ti rendiamo grazie! Tu hai molto sofferto per noi e hai disposto che anche tua madre patisse tali cose per te e per noi, perché l’onore di essere partecipe della tua passione le preparasse la comunione nella gloria e anche perché, ricordando le sofferenze patite per noi, si dedicasse con ancor più sollecitudine alla nostra salvezza e mantenesse integro il suo amore verso di noi non solo a motivo della partecipazione alla nostra natura, ma anche a ricordo di tutto quello che nella sua vita ha fatto per noi. […]
Noi rendiamo grazie anche a te, Signora, per le tribolazioni e le sofferenze che hai patito per noi. Per te non cantiamo inni funebri, ma canti nuziali; non facciamo il lamento per la tua partenza, ma cantiamo di gioia perché entri nel cielo. Parti per il cielo, ma non abbandoni la terra; liberata dalle miserie di questa terra e assunta nella felicità ineffabile e infinita, non dimentichi la miseria della nostra condizione, ma ancor più ti ricordi di noi e ti mostri sollecita per le nostre tribolazioni. Non ci hai reso doppiamente orfani, ma hai dissolto il nostro stato di orfani e, insieme a te, ci hai reso propizio il figlio tuo e il Padre nostro e con lui ci riconcili.
Ora sei costituita regina della destra del Re, circondata da altre splendide regine (cfr. 5 45,10.15), cioè dalle anime vergini e regali, con una veste tessuta d’oro dallo Spirito, avvolta dal manto regale della tua dignità, delle tue molteplici virtù e dei tuoi carismi. Ora tu ricevi dalle mani del figlio tuo e Dio tuo il diadema della grazia, lo scettro del regno, la cintura e la porpora, cioè un potere universale e una luce che rifulge da tutta la persona e dalla tua divinizzazione.
(GIOVANNI GEOMETRA, Omelia sulla Dormizione 59-61, in A. WENGER, L’Assomption de la Très Sainte Vierge dans la tradition byzantine du VI au X siecle, Paris, 1955, pp. 391-394).
La festa dell’Assunta è un giorno di gioia
Dio ha vinto. L’amore ha vinto. Ha vinto la vita. Si è mostrato che l’amore è più forte della morte. Che Dio ha la vera forza e la sua forza è bontà e amore. Maria è assunta in cielo in corpo e anima: anche per il corpo c’è posto in Dio. Il cielo non è più per noi una sfera molto lontana e sconosciuta. Nel cielo abbiamo una madre. E la Madre di Dio, la Madre del Figlio di Dio, è la nostra Madre. Egli stesso lo ha detto. Ne ha fatto la nostra Madre, quando ha detto al discepolo e a tutti noi: “Ecco la tua Madre!” Nel cielo abbiamo una Madre. Il cielo è aperto, il cielo ha un cuore. Nel Vangelo abbiamo sentito il Magnificat, questa grande poesia venuta dalle labbra, anzi dal cuore di Maria, ispirata dallo Spirito Santo. In questo canto meraviglioso si riflette tutta l’anima, tutta la personalità di Maria. Possiamo dire che questo suo canto è un ritratto, una vera icona di Maria, nella quale possiamo vederla proprio così com’è. Vorrei rilevare solo due punti di questo grande canto. Esso comincia con la parola “Magnificat”: la mia anima “magnifica” il Signore, cioè “proclama grande” il Signore. Maria desidera che Dio sia grande nel mondo, sia grande nella sua vita, sia presente tra tutti noi. Non ha paura che Dio possa essere un “concorrente” nella nostra vita, che possa toglierci qualcosa della nostra libertà, del nostro spazio vitale con la sua grandezza. Ella sa che, se Dio è grande, anche noi siamo grandi. La nostra vita non viene oppressa, ma viene elevata e allargata: proprio allora diventa grande nello splendore di Dio. Il fatto che i nostri progenitori pensassero il contrario fu il nucleo del peccato originale. Temevano che, se Dio fosse stato troppo grande, avrebbe tolto qualcosa alla loro vita. Pensavano di dover accantonare Dio per avere spazio per loro stessi. Questa è stata anche la grande tentazione dell’epoca moderna, degli ultimi tre-quattro secoli. Sempre più si è pensato ed anche si è detto: “Ma questo Dio non ci lascia la nostra libertà, rende stretto lo spazio della nostra vita con tutti i suoi comandamenti. Dio deve dunque scomparire; vogliamo essere autonomi, indipendenti. Senza questo Dio noi stessi saremo dei, facendo quel che vogliamo noi”. Era questo il pensiero anche del figlio prodigo, il quale non capì che, proprio per il fatto di essere nella casa del padre, era “libero”. Andò via in paesi lontani e consumò la sostanza della sua vita. Alla fine capì che, proprio per essersi allontanato dal padre, invece che libero, era divenuto schiavo; capì che solo ritornando alla casa del padre avrebbe potuto essere libero davvero, in tutta la bellezza della vita. E’ così anche nell’epoca moderna. Prima si pensava e si credeva che, accantonando Dio ed essendo noi autonomi, seguendo solo le nostre idee, la nostra volontà, saremmo divenuti realmente liberi, potendo fare quanto volevamo senza che nessun altro potesse darci alcun ordine. Ma dove scompare Dio, l’uomo non diventa più grande; perde anzi la dignità divina, perde lo splendore di Dio sul suo volto. Alla fine risulta solo il prodotto di un’evoluzione cieca e, come tale, può essere usato e abusato. E’ proprio quanto l’esperienza di questa nostra epoca ha confermato. Solo se Dio è grande, anche l’uomo è grande. Con Maria dobbiamo cominciare a capire che è così. Non dobbiamo allontanarci da Dio, ma rendere presente Dio; far sì che Egli sia grande nella nostra vita; così anche noi diventiamo divini; tutto lo splendore della dignità divina è allora nostro. Applichiamo questo alla nostra vita. E’ importante che Dio sia grande tra di noi, nella vita pubblica e nella vita privata. Nella vita pubblica, è importante che Dio sia presente, ad esempio, mediante la Croce negli edifici pubblici, che Dio sia presente nella nostra vita comune, perché solo se Dio è presente abbiamo un orientamento, una strada comune; altrimenti i contrasti diventano inconciliabili, non essendoci più il riconoscimento della comune dignità. Rendiamo Dio grande nella vita pubblica e nella vita privata. Ciò vuol dire fare spazio ogni giorno a Dio nella nostra vita, cominciando dal mattino con la preghiera, e poi dando tempo a Dio, dando la domenica a Dio. Non perdiamo il nostro tempo libero se lo offriamo a Dio. Se Dio entra nel nostro tempo, tutto il tempo diventa più grande, più ampio, più ricco. Una seconda osservazione. Questa poesia di Maria – il Magnificat – è tutta originale; tuttavia è, nello stesso tempo, un “tessuto” fatto totalmente di “fili” dell’Antico Testamento, fatto di parola di Dio. E così vediamo che Maria era, per così dire, “a casa” nella parola di Dio, viveva della parola di Dio, era penetrata dalla parola di Dio. Nella misura in cui parlava con le parole di Dio, pensava con le parole di Dio, i suoi pensieri erano i pensieri di Dio, le sue parole le parole di Dio. Era penetrata dalla luce divina e perciò era così splendida, così buona, così raggiante di amore e di bontà. Maria vive della parola di Dio, è pervasa dalla parola di Dio. E questo essere immersa nella parola di Dio, questo essere totalmente familiare con la parola di Dio le dà poi anche la luce interiore della sapienza. Chi pensa con Dio pensa bene, e chi parla con Dio parla bene. Ha criteri di giudizio validi per tutte le cose del mondo. Diventa sapiente, saggio e, nello stesso tempo, buono; diventa anche forte e coraggioso, con la forza di Dio che resiste al male e promuove il bene nel mondo. E, così, Maria parla con noi, parla a noi, ci invita a conoscere la parola di Dio, ad amare la parola di Dio, a vivere con la parola di Dio, a pensare con la parola di Dio. E possiamo farlo in diversissimi modi: leggendo la Sacra Scrittura, soprattutto partecipando alla Liturgia, nella quale nel corso dell’anno la Santa Chiesa ci apre dinanzi tutto il libro della Sacra Scrittura. Lo apre alla nostra vita e lo rende presente nella nostra vita. Ma penso anche al “Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica”, che recentemente abbiamo pubblicato, nel quale la parola di Dio è applicata alla nostra vita, interpreta la realtà della nostra vita, ci aiuta ad entrare nel grande “tempio” della parola di Dio, ad imparare ad amarla e ad essere, come Maria, penetrati da questa parola. Così la vita diventa luminosa e abbiamo il criterio in base al quale giudicare, riceviamo bontà e forza nello stesso momento. Maria è assunta in corpo e anima nella gloria del cielo e con Dio e in Dio è regina del cielo e della terra. E’ forse così lontana da noi? E’ vero il contrario. Proprio perché è con Dio e in Dio, è vicinissima ad ognuno di noi. Quando era in terra poteva essere vicina solo ad alcune persone. Essendo in Dio, che è vicino a noi, anzi che è “interiore” a noi tutti, Maria partecipa a questa vicinanza di Dio. Essendo in Dio e con Dio, è vicina ad ognuno di noi, conosce il nostro cuore, può sentire le nostre preghiere, può aiutarci con la sua bontà materna e ci è data – come è detto dal Signore – proprio come “madre”, alla quale possiamo rivolgerci in ogni momento. Ella ci ascolta sempre, ci è sempre vicina, ed essendo Madre del Figlio, partecipa del potere del Figlio, della sua bontà. Possiamo sempre affidare tutta la nostra vita a questa Madre, che non è lontana da nessuno di noi. Ringraziamo, in questo giorno di festa, il Signore per il dono della Madre e preghiamo Maria, perché ci aiuti a trovare la giusta strada ogni giorno. Amen.
(Omelia del Santo Padre Benedetto XVI, lunedì 15 agosto 2005, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia,Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.
PER L’APPROFONDIMENTO:
XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
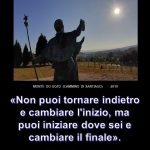
Lectio – Anno C
Prima lettura: Sapienza 18,6-9
| La notte [della liberazione] fu preannunciata ai nostri padri, perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. Difatti come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa legge divina: di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. |
Ai discepoli, come abbiamo visto, Gesù richiede fedeltà e saggezza, affinché possano camminare nella storia incontro al Signore e guidare responsabilmente coloro che sono stati loro affidati. Non è un caso, allora, che la liturgia odierna ci proponga alcuni versetti del Libro della sapienza, il quale, nei capitoli dal 10 al 19, riprende la storia dell’esodo con lo scopo di farne un commento. L’autore di questo libro (scritto verso la fine del I secolo a.C.) si rivolge continuamente alla sapienza, lodandone la preveggenza e la perfezione del suo operare nella natura, nella politica, nella storia e, ancor più, nella rivelazione dell’unico Dio.
Nel cercare un momento nella storia d’Israele, in cui magnificare l’azione della sapienza, quale occasione migliore poteva esserci della liberazione dall’Egitto? In quel frangente, la guida della sapienza si è rivelata esemplare, perché Dio non si accontentò di dare al popolo soltanto Mosè, il mediatore, bensì volle che la sapienza stessa facesse come da schiavo lampadarius, ossia da servo che precede reggendo la lanterna, per illuminare la strada al popolo che doveva percorrerla: «Invece delle tenebre desti loro una colonna di fuoco, come guida in un viaggio sconosciuto e come un sole innocuo per il glorioso emigrare» (v. 3).
Sostenuti dalla sapienza, fu possibile affrontare quella notte oscura, durante la quale gli ebrei uscirono dall’Egitto per andare incontro alla libertà tanto agognata (cf. Es 12): «La notte [della liberazione] fu preannunciata ai nostri padri, perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici» (vv. 6-7). L’evento della Pasqua viene così rivisto alla luce della gloria, cioè della rivelazione del piano di Dio, che porta salvezza a chi crede in lui, ma diventa elemento di giudizio per chi lo rifiuta: «Difatti come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa legge divina: di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri» (vv. 8-9).
L’autore del Libro della Sapienza, quindi, sottolinea la necessità di ripresentare (ossia di fare il memoriale) la Pasqua per far ricordare alle generazioni future che Dio non abbandona e che le sue promesse sono eterne. Ma la celebrazione della Pasqua conferma pure che «i santi avrebbero partecipato ugualmente ai beni e ai pericoli», ossia al bene e al male della storia. Infatti, la storia, come non ha in sé il suo inizio, non può avere in sé il proprio compimento. Perciò siamo in attesa di Dio, mentre ci viene chiesto di amministrare fedelmente e saggiamente quanti egli ci ha affidato.
Seconda lettura: Ebrei 11,1-2.8-19
| Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo. |
Il brano della lettera agli Ebrei, in qualche modo, presenta l’opportunità di riflettere sulla figura di un servo fedele e saggio come il patriarca Abramo. Infatti, tra i vari personaggi dell’Antico Testamento citati dall’autore, spicca per ampiezza proprio il riferimento al capostipite d’Israele. D’altra parte, parlando della fede, non si può trascurare colui che ne è un vero campione, specialmente se si considera la definizione che la Lettera agli Ebrei ne dà: «La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio» (vv. 1-2).
Della vita di Abramo si riprendono tutte le tappe più importanti, a partire dalla vocazione, per mezzo della quale cambiò anche patria. La sua vita, tutta riposta nella fede in Dio, divenne modello pure per Isacco e Giacobbe, nonché per Sara: «Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare» (vv. 11-12). Inoltre, la stessa nascita d’Isacco e il sacrificio di quest’unico figlio (cf. Gen 22) fanno ancora giganteggiare Abramo, al cui confronto la fede di tanti altri impallidisce: «Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo» (vv. 17-19).
Per ritrovare dei testimoni autentici, che sappiano insegnare che cosa sia la fede, pur vivendo nelle difficoltà quotidiane, la Lettera agli Ebrei volge lo sguardo al passato remoto d’Israele: lì vengono identificati questi uomini che hanno ancora molto da insegnare. Così possiamo spiegarci le parole dei vv. 13-16, che suonano come una lode ai patriarchi, i quali, pur non avendo a disposizione ciò che noi abbiamo (la rivelazione piena in Gesù Cristo, la Chiesa, i sacramenti…), hanno saputo capire che ciò che Dio prometteva loro era più certo di quello che vedevano: «Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città».
Tale città celeste è stata preparata anche per noi: in essa incontreremo tutti coloro la cui fede ci è stata di conforto e stimolo mentre muoviamo i nostri incerti passi su questa terra.
Vangelo: Luca 12,32-48
| In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». |
Esegesi
Il brano evangelico di questa domenica comincia con un versetto che vale come una rassicurazione per coloro che, essendo piccoli e poveri, riceveranno in eredità ciò che più conta in assoluto: il regno di Dio. Infatti, dopo aver invitato a non imitare i farisei (12,1), a non accumulare tesori sulla terra (12,13-21) e ad avere fiducia nella provvidenza (12,22-31), Gesù afferma: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno» (12,32). Nel piccolo gregge egli vede coloro che cercano in primo luogo il regno di Dio (12,31) e sanno che il cuore, se vuole essere sinceramente libero, non può attaccarsi ai beni di questa terra. Da qui l’esortazione a disfarsi delle ricchezze, che nell’opera lucana costituisce un tratto caratteristico, basti pensare al celebre racconto che ha per protagonisti Anania e Saffira negli Atti degli apostoli.
Le ricchezze sono percepite da Luca come un pericolo: a causa loro, la coscienza dell’uomo in generale, e persino del credente, si assopisce e si stordisce, al punto di non saper capire che non è in esse che si trova la salvezza e la riuscita. Fidarsi dei beni terreni vuol dire vivere una vera e propria ubriacatura, come quella consumistica che sperimentiamo tutti i giorni, per cui l’ideale da perseguire è soddisfare il desiderio di avere, un desiderio che si autoalimenta perché siamo avvolti in una spirale nella quale non si può mai dire basta, se si vuole “stare al passo con i tempi”. Perciò, Gesù narra due brevi parabole (vv. 36-38 e v. 39), il cui scopo è di spingere alla prontezza, secondo quanto i versetti 35 e 40 sottolineano: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese […] Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo ».
Al versetto 41, Pietro rivolge a Gesù una strana domanda: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». L’apostolo vorrebbe sapere che ruolo devono svolgere i discepoli: devono rinchiudersi in un’attesa del tempo in cui Gesù ritornerà o devono fare come Giona, che avvertì gli abitanti di Ninive a riguardo della catastrofe imminente. Gesù preferisce, a sua volta, rispondere con un’altra parabola, in cui il personaggio è un servo, ma questa volta investito di un’autorità particolare: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito?» (v. 42). L’allusione è trasparente: poiché Pietro vuol sapere qual è il compito suo e degli altri apostoli fino al tempo della parusia, gli viene risposto che lui con gli altri apostoli sono come degli amministratori, che agiscono per conto di Gesù.
Perciò, egli avverte i suoi discepoli. Nei confronti del gregge loro affidato, essi devono essere coscienziosi e irreprensibili. Gesù adopera gli aggettivi «fedele e saggio», perché, in primo luogo, essi amministrano un patrimonio che non appartiene a loro e, inoltre, devono usarlo con oculatezza, prudenza e, soprattutto, con tanto amore, per dispensare il «cibo» necessario agli altri servi e, così, permettere loro di giungere al momento nel quale il Signore ritornerà.
Meditazione
Le letture di questa domenica mettono a fuoco un aspetto fondamentale dell’esistenza cristiana: l’attesa della venuta del Signore. Un’attesa che, soprattutto nella pagina evangelica, prende la forma concreta di una continua vigilanza. Come osservava il card. C.M. Martini nella sua Lettera pastorale Sto alla porta: «Vigilare non è un atteggiamento marginale della vita cristiana, ma ne riassume la tensione caratteristica verso il futuro di Dio congiungendola con l’attenzione e la cura per il momento presente». Se proprio del cristiano è vigilare «ogni giorno e ogni ora» (come ci ammonisce il grande padre della Chiesa Basilio), il suo esercizio si fa ancora più urgente di notte, quando il sonno e la stanchezza possono prendere il sopravvento e l’oscurità può far smarrire il sentiero che conduce all’incontro con Dio. I primi cristiani sapevano che l’avvento del Signore sarebbe giunto all’improvviso, «come un ladro di notte» (1Ts 5,2), per questo cercavano di vivere in modo tale da non lasciarsi trovare impreparati a questo evento. Così la Chiesa, anche oggi, vive il tempo del suo pellegrinaggio terreno come una lunga e interminabile notte, durante la quale attende insonne lo spuntare del giorno nuovo (cfr. Rm 13,12).
Il testo della prima lettura, tratto da libro della Sapienza, ci parla dell’attesa di Israele («Il tuo popolo era in attesa della salvezza dei giusti»: v. 7) che trova compimento nella «notte della liberazione». È la notte in cui Dio stesso veglia sul suo popolo per farlo uscire dal paese d’Egitto (cfr. Es 12,42), realizzando così le promesse già annunciate ai patriarchi (cfr. Sap 18,6). Allo stesso modo, il passo della Lettera agli Ebrei (seconda lettura) ci ricorda l’attesa di Abramo, maturata nella notte della fede (culminata nella prova dell”offerta’ di Isacco: cfr. v. 17) e nella ricerca di «una patria migliore» di quella da cui era uscito (cfr.vv. 14-16).
Nel brano evangelico ci vengono presentate tre brevi parabole (Lc 12,35-48) – precedute da un’esortazione a disfarsi dei beni di questo mondo per farsi un tesoro nei cieli (vv. 33-34) – che potremmo definire un piccolo ‘vangelo dell’attesa’. In esse, infatti, troviamo declinati i diversi aspetti dell’attesa cristiana e le molteplici sfumature che, di volta in volta, può assumere la vigilanza. In quei servi che aspettano il ritorno del loro padrone pronti ad aprirgli subito la porta (vv. 36-38), in quel padrone che scruta (o meglio, che dovrebbe scrutare) con attenzione l’ora in cui arriva il ladro per non lasciarsi scassinare la casa (vv. 39-40), in quel maggiordomo (o amministratore) che durante l’assenza prolungata del padrone è chiamato a prendersi cura responsabilmente dei servi a lui affidati (vv. 41-48), ci viene illustrata la multiforme ricchezza di significati della vigilanza evangelica. Essa comporta prontezza e attenzione (perché in ogni momento può giungere il padrone o il ladro); pazienza e perseveranza (la capacità di attendere anche tutta la notte); fedeltà e responsabilità nel compiere il proprio dovere; disponibilità al servizio, sempre e comunque. Tutto questo può essere bene sintetizzato nelle due immagini che compaiono nell’esortazione iniziale: ««Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi (lett.: siano cinti i vostri fianchi) e le e lampade accese» (v. 35). I «fianchi cinti» è immagine comune nella Bibbia per indicare l’atteggiamento di chi si predispone a compiere qualche lavoro o a intraprendere un viaggio (cfr. Lc 17,8; At 12,8). Ma, soprattutto, evoca l’atteggiamento di Israele mentre si prepara a celebrare la Pasqua nella notte in cui il Signore passa a liberarlo: «Ecco in qual modo mangerete l’agnello: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore! In quella notte io passerò…» (Es 12,11-12). Il Signore «passa», perciò bisogna farsi trovare pronti per intraprendere con lui il cammino dell’esodo dall’Egitto. L’altra immagine, delle «lampade accese», è piuttosto metafora del vegliare durante l’oscurità della notte (cfr. la parabola delle vergini sagge e stolte in Mt 25,1-13). Il credente che attende il suo Signore deve essere dunque come un viandante, continuamente in cammino – mai pago di ciò che ha raggiunto -, e deve essere sempre pronto ad attendere al proprio servizio – sino alla fine -. Nella certezza che, comunque, anche attraverso la notte più oscura, ha sempre una luce, una piccola lucerna che lo guida: la parola che il Signore gli ha donato (cfr. Sal 118/119,105; nella prima lettura è la «colonna di fuoco» che funge da guida nel viaggio della notte pasquale, cfr. Sap 18,3).
«Non temere, piccolo gregge…» (Lc 12,32). Con questa parola di consolazione e incoraggiamento si apre il vangelo odierno. Pur nella sua piccolezza e insignificanza, nella sua fragilità costantemente minacciata, il piccolo gregge dei discepoli può avanzare con fiducia perché ha già ricevuto in dono tutto quello che da Dio può sperare e desiderare: il suo Regno. Con il cuore in questo «tesoro» (vv. 33-34), allora, aspetta con speranza incrollabile il Signore che ritorna, consapevole che meno si attaccherà ai propri beni e più sarà capace di attendere il grande bene del Regno. Perché tra povertà e attesa c’è un intimo e imprescindibile legame: un cuore ingombro e distratto da troppe cose, infatti, non ha più quella libertà e quella forza di attendere da Dio solo il compimento di ogni suo bene.
«Beati coloro che aspettano (trad. CEI: sperano in) lui», dice il profeta Isaia (30,18). In se stessa, l’attesa è già fonte di beatitudine e di autentica felicità. Perché mantiene il cuore aperto nella direzione del suo desiderio più vero, facendogli in qualche modo già pregustare la gioia dell’incontro. E anche nel nostro passo evangelico, per ben tre volte, risuona la formula: «Beati…» (vv. 37.38.43). E in tutti i tre i casi la beatitudine è scandita da quell’«essere trovati». Trovati «così», ad «agire così». Cioè nientemeno che intenti e attenti al proprio lavoro, al proprio compito, al proprio servizio. Non ci è chiesto altro che di attendere attendendo al compito che ci è stato affidato, con tutta la responsabilità e la fedeltà di cui siamo capaci. E scopriremo allora, con stupore, che per Dio questo semplice fatto è già cosa immensa e stupefacente, tanto da essere ripagata con una risposta che ha dell’eccessivo e dell’inimmaginabile: «In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli» (v. 37). Il Signore che si fa servo dei suoi servi: mirabile capovolgimento divino!
A questo punto, ci si può chiedere se noi aspettiamo un Signore così. Oppure il suo volto conserva per noi ancora i tratti inalterati di un giudice terribile e inquietante, di un ladro temibile e senza scrupoli o di un padrone duro e severo, che non esiterà a punire con rigore chi non avrà agito secondo le sue disposizioni?
Don Bosco commenta il Vangelo
XIX domenica del tempo ordinario
Il tesoro è Gesù stesso
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore (Lc 12,32).
Per un cristiano il tesoro è anzitutto Gesù stesso. Facendo il ringraziamento dopo la comunione il giovane pregherà così:
Io non son degno di sì grande favore, nemmeno so che cosa offrirvi in ringraziamento; ma appoggiato ai vostri meriti vi offro questi meriti medesimi, che sono infiniti. Vi ringrazio di tutto cuore, e protesto che per l’avvenire Voi sarete sempre il mio piacere, il riposo dell’anima mia; Voi solo la mia speranza, il mio conforto; Voi solo la mia ricchezza, il mio bene, il mio possesso, il tesoro del mio cuore (OE35 240s).
Lo stesso pensiero si trova nei suoi Cenni storici intorno alla vita della B. Caterina De-Mattei da Racconigi dove don Bosco scrive:
Caterina vide una volta Gesù Cristo, Maria SS. con molti altri santi, i quali parevano vestiti a duolo, e più di tutti mostravasi addolorato il suo sposo Gesù. Tosto Caterina gli domandò la cagione di sì grande tristezza. Gesù le rispose: “E come non vuoi che io mi mostri così afflitto al vedere che tante anime vanno alla perdizione? E non vedi quanto sia grande l’ingratitudine del mio popolo, che io ho redento col mio sangue? Sono io pure un prezioso tesoro, il sommo ed eterno bene, e tuttavia la maggior parte degli uomini fanno più conto dei beni miserabili di questa terra” (OE14 62s).
L’Eucaristia ricevuto in Viatico prima di morire era il tesoro di Luigi Comollo, come racconto don Bosco nella sua biografia:
Con forti slanci tentava portarsi verso il SS. Sacramento; io mi sforzava onde trattenerlo in letto; mi cadevan le lagrime dagli occhi per tenerezza, e stupore, non sapeva che dire, né che rispondergli; ed egli vieppiù si dibatteva onde portarsi verso il SS. Viatico, né s’acquetò finché non l’ebbe ricevuto. Dopo la Comunione tutto nei più affettuosi sentimenti concentrato verso il suo Gesù, stette alcun tempo immobile, quindi ripieno di meraviglia «oh! portento d’amore, esclamava. Chi mai son io per essere fatto degno di tesoro sì prezioso! (OE1 58).
Parlando del Papa e dell’Eucaristia nei suoi Episodi ameni e contemporanei don Bosco scrive ancora:
La sposa di Cristo conserva il deposito delle verità, il tesoro dell’Eucarestia, la sorgente dei sacramenti, che sono i canali della grazia divina; ella offre a Dio il sacrifizio, che a Lui è gradito, e riposa sopra Pietro come un edificio sopra immobili fondamenta (OE15 206).
Il tesoro più grande su questa terra è la presenza di Gesù nell’Eucaristia. Scrive don Bosco nelle Pratiche divote per l’adorazione del SS. Sacramento:
La presenza di Gesù è un tesoro che avremmo invano cercato sulla terra se Egli non ci fosse rimasto per amor nostro. Ma Esso è là, in mezzo a noi, Egli ci apre le sue braccia, il suo cuore. Dove troveremo noi un amico che intenda le nostre pene e ci compatisca, un orecchio che non si stanchi mai di ascoltarci, una voce che mai si stanchi di dirci quelle parole di consolazione che sono il meglio adattate per fortificarci e sollevarci? Andiamo adunque a Gesù. Ah sì! il pane della Eucaristia dovrebbe essere il pane quotidiano dell’anima che soffre, perché è un pane che fortifica e consola; esso ha la virtù di rendere dolci le più amare lagrime, di rendere facili i maggiori, i più dolorosi sacrifici (OE17 267).
Nella Scelta di laudi sacre un canto al Cuore di Gesù comincia con questa strofa:
O dolce mia speranza,
Mio caro e buon Gesù (OE31 332).
(Morand Wirth)
Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.
L’immagine della domenica
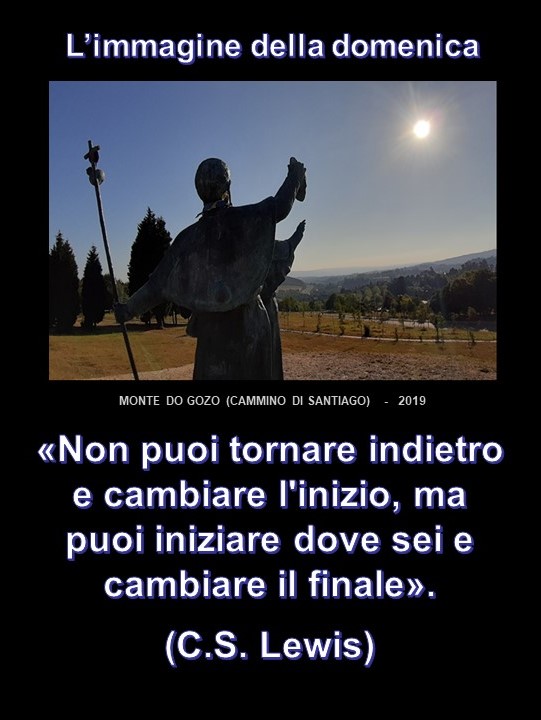
| MONTE DO GOZO (CAMMINO DI SANTIAGO) – 2019 |
«Non puoi tornare indietro
e cambiare l’inizio,
ma puoi iniziare dove sei
e cambiare il finale».
(C.S. Lewis)
| Sapienza 18,6-9Ebrei 11,1-2.8-19Luca 12,32-48 Il cristiano, memore di un’antica promessa mai smarrita, è proteso verso il futuro. Deve dunque vivere l’ora presente con grande vigilanza, cioè con un forte senso di attesa e con scelte sagge e responsabili. Il brano del Vangelo di Luca di questa domenica mette fortemente in risalto la tensione verso il futuro che deve caratterizzare la vita del cristiano. Senza questa tensione, senza questa vigilanza, la fede diventa irriconoscibile e presto svanisce, perché dimentica il Signore e la sua venuta. Solo vivendo il tempo nell’attesa serena, intelligente e attiva, la storia umana diventa storia di salvezza, cessando di essere destino enigmatico e cieco a cui abbandonarsi. Solo nella saggezza delle decisioni prese nel momento presente, l’oggi si apre verso il futuro e il tempo si dischiude verso l’eternità. Con il tipico linguaggio sapienziale, Gesù vuole risvegliare in noi il senso vigilante della nostra libertà: perché la libertà non si disperda in piccole e inutili cose, perché non si addormenti, ma corrisponda con gioia e prontezza all’amore e alla grazia che Dio continuamente ci concede. |
Preghiere e racconti
Il giudizio
Il giudizio di coloro che insegnano sarà più severo, il Salvatore chiederà molto a chi avrà dato molto. Che cos’è questo molto che viene richiesto? La saldezza nella fede, la rettitudine nell’iniziazione al mistero, la costanza nella speranza, la persistenza nella sopportazione, la solidità nella forza spirituale, l’ardore e il vigore in ogni sorta di buone imprese, per essere agli occhi altrui un abbozzo di vita evangelica.
(Cirillo di Alessandria, Sermone 93 sulla parabola dell’amministratore infedele)
L’attesa del Signore
L’attesa del Signore non solo rende senza valore le cose diverse da quelle che noi attendiamo, ma ci sottrae lo stesso istante presente. Infatti, ciò che noi attendiamo non è la presenza dell’istante. Ciò che ci interessa non è ciò che l’istante è in sé. Ciò che noi attendiamo, ciò che ci interessa soprattutto, è colui che l’istante ci porta, è la venuta e il tocco del Signore in questo istante… Per colui che attende Gesù, ogni istante si estende e si illumina. Si estende, perché lo vediamo tendere verso la sua pienezza. Si illumina, perché già la presenza di Gesù vi proietta la luce di una venuta ancor più perfetta. Gesù verrà ancora, verrà sempre, fino alla seconda gloriosa venuta. Gesù è venuto. Viene in noi in ogni minuto. E ognuno dei nostri minuti non ha altro valore se non questa venuta e questa presenza di Gesù che ha potuto portarci.
(Un monaco della Chiesa d’Oriente, Il Volto di luce)
Beato il servo
Beati coloro che esultano
nello Spirito di Gesù
e vegliano per i loro fratelli.
Beato il servo
che vegliava nella notte
nel nome del Figlio di Dio.
Beato il servo
che vegliava nella notte!
Beati coloro che restano nella pace di Gesù
quando vengono le tenebre.
Beato il servo
che vegliava nella notte
nel nome del Figlio di Dio.
Beati coloro che scoprono
nella morte di Gesù
dove vanno le notti umane.
Beato il servo
che vegliava nella notte
spiando il giorno di Dio.
Beati coloro che esultano
nello Spirito di Gesù
e rendono gloria al Padre.
Beato il servo
che vegliava nella notte e vede il giorno di Dio.
(Commissione francofona cistercense, Libro di canti).
Attenzione e vigilanza
Giocando sull’assonanza fra prosoché (attenzione) e proseuché (preghiera) l’antica tradizione cristiana ha affermato lo stretto legame tra queste due realtà: «L’attenzione che cerca la preghiera troverà la preghiera: la preghiera infatti segue all’attenzione ed è a questa che occorre applicarsi» (Evagrio Pontico). In tempi più recenti Simone Weil, riprendendo Malebranche, ha parlato dell’attenzione in termini di preghiera. L’attenzione è la preghiera naturale che l’uomo fa alla verità interiore perché gli si disveli. L’attenzione è faticosa e dolorosa e nell’animo umano vi è qualcosa che vi si oppone con grande veemenza, molto più violentemente di quanto alla carne ripugni la fatica.
All’attenzione si accompagna la vigilanza. Il «vigilante» è l’uomo sveglio, non addormentato, non intontito, è l’uomo lucido e critico, non passivo, è l’uomo responsabile e cosciente. È l’uomo che si lascia colpire e interpellare dagli eventi. Come dimenticare che l’esperienza che ha condotto il Budda allo stato di «svegliato», di «illuminato», è passata attraverso la presa di coscienza della tragica esperienza della malattia, della vecchiaia e della morte? L’homo vigilans è presente a sé e agli altri, alle realtà umane e storiche, ha radici in se stesso e non attende dall’esterno di sé la conferma al proprio agire e alla propria identità. È l’uomo paziente e perseverante, profondo, capace di dare continuità ad una scelta… Non stupisce che un padre del deserto abbia detto: «L’unica cosa di cui abbiamo bisogno è uno spirito vigilante» (Abba Poemen). All’opposto dell’homo vigilans si colloca l’homo dormiens, colui che resta al di qua delle proprie possibilità, che ha paura, che vive orizzontalmente più che in profondità, che si disperde in mille cose da fare o in tante cose da possedere, che è pigro e negligente, che trascina la sua vita come se fosse illimitata considerandola un divertissement.
È colui che non ha passione, è nella sonnolenza, cioè nella morte. Nella mitologia greca Hypnos (Sonno) è gemello di Thanatos (Morte)! Il vigilante è colui che lotta contro il sonno e dunque contro la morte ponendosi come uomo di luce.
(Luciano MANICARDI, La vita interiore oggi. Emergenza di un tema e sue ambiguità, Magnano, Qiqajon, 1999, 20-21).
La vigilanza
Il credente si prepara alla lotta spirituale con la vigilanza: il NT chiede a più riprese di essere sobri e temperanti, di stare in guardia, di vegliare, di stare svegli, di stare attenti, di essere pronti. La vigilanza è atteggiamento umano e spirituale con cui l’uomo è presente a se stesso e a Dio: è attitudine di lucidità e di criticità che lo mantiene perseverante e non distratto, non dissipato. L’uomo vigilante è attento a tutto il reale, lucido nei confronti di se stesso e della realtà, attento agli eventi e agli incontri, sollecito al proprio ministero, responsabile, capace di pazienza e di profondità. Al contrario, chi non vigila è un uomo addormentato, intontito, che vive sotto il segno della paura, della superficialità, della pigrizia e della negligenza. È l’uomo che teme il faccia a faccia con se stesso, che preferisce la tenebra alla luce, che evita di mettersi in discussione e di confrontarsi… In obbedienza al comando del Signore («Vegliate e pregate per non soccombere nella tentazione»: Matteo 26,41), la tradizione spirituale ha associato la vigilanza alla lotta spirituale e alla preghiera, che di tale lotta è l’arma per eccellenza, ed ha fatto della vigilanza l’arte della purificazione dei pensieri, della “custodia del cuore”, il momento fondamentale della lotta contro il peccato. È dunque ovvio che, nella formazione alla lotta spirituale, occorre condurre alla adesione alla realtà (e anzitutto alla realtà propria, personale, riconoscendo e dando il nome alle lacune, alle debolezze e alle negatività che ci abitano) e alla strutturazione dello spazio interiore (educando a leggere, pensare, interpretare gli eventi, dialogare interiormente). E questo, naturalmente, mentre si introduce all’ascolto della Parola di Dio nella Scrittura, dunque alla conoscenza del Signore.
Luciano MANICARDI, La lotta spirituale, in CENTRO REGIONALE VOCAZIONI (PIEMONTE-VALLE D’AOSTA), Corso di avvio all’accompagnamento spirituale. Atti, a cura di Gian Paolo Cassano, Casale Monferrato, Portalupi, 2007, 143-144.
La vigilanza
Se l’inautenticità è una produzione della mente, ne viene che condizione essenziale per l’autenticità è il controllo della mente. Ma come si controlla la mente? Riportandola al reale. Fermandola sul reale. Inchiodandola sul reale. È in questa prospettiva che io interpreto l’invio di Gesù alla vigilanza, la grégorsis evangelica, quando dice “vegliate” (Matteo 24,42), “tenetevi pronti” (Matteo 24,44), “vegliate e pregate per non entrare in tentazione” (Matteo 26,41). Non si tratta tanto di attendere un’improbabile fine del mondo con l’arrivo degli angeli allo squillo di trombe secondo scenari apocalittici che hanno terrorizzato le coscienze nei secoli passati ma che ora per fortuna non fanno più paura a nessuno, quanto piuttosto di aderire al presente, di leggerlo per quello che è, senza mentire mai, né applicandovi categorie improprie né occultandone i fatti che mettono in crisi la propria visione del mondo, perché la prima cosa di cui diffidare, a proposito delle tentazioni da cui metteva in guardia Gesù, è la falsità dei pensieri. Questa è la vigilanza dell’uomo maturo, adeguata alla coscienza contemporanea.
(Vito MANCUSO, La vita autentica, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2009, 82-83).
Vogliamo essere pronti
Vogliamo essere pronti.
Non sappiamo quando verrai a cercarci;
l’ora della nostra morte può essere una sorpresa,
come tu ce l’hai detto, Gesù, nel Vangelo.
Vogliamo essere pronti.
Tu ci hai esortati a non allentare
i nostri sforzi vigilanti, a non lasciarci
vincere dalla pigrizia o dalla noncuranza.
Vogliamo essere pronti,
conservando con te i nostri contatti amichevoli,
cercando di piacerti in tutta la nostra vita,
pregandoti più forte, con un cuore sincero.
Vogliamo essere pronti,
premurosi d’agire con carità,
quella carità di cui hai fatto il grande comandamento:
noi desideriamo amare più generosamente.
Vogliamo essere pronti,
ponendo solo in te la nostra fiducia,
e volgendo verso di te tutta la nostra speranza:
tu tieni nelle tue mani la nostra sorte eterna.
(Jean Galot,da: Apri loro la porta…, Sorrento, Benedettine, 1980).
La Settimana con don Bosco
4-10 agosto 2025
4. (S. Giovanni Maria Vianney) – “Gesù Cristo è là in persona, esclamava il parroco d’Ars; si vada ai piedi del Tabernacolo” (MB9 355).
5. (Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore) – Papa Sisto V “eresse ancora nella Chiesa di Santa Maria Maggiore una magnifica cappella in onore del Presepio del Verbo incarnato” (OE18 3909).
6. (Trasfigurazione del Signore) – “Gesù con questo fatto si manifesta Figliuolo di Dio, Dio eterno egli stesso, e predice nel tempo medesimo che sarebbe di virtù propria risuscitato” (OE27 383).
7. (S. Sisto II e comp.) – “Il mio sacrificio non è fatto con carne di miseri animali, ma con un’ostia pura ed immacolata” (OE12 285). – (S. Gaetano) “Non potendo da solo compiere tutte le opere che formavano incessante oggetto della sua carità, si cercò alcuni zelanti compagni, coi quali cominciò vita comune” (OE24 278s).
8. (S. Domenico) – “A san Domenico è attribuita l’istituzione del Rosario, secondo l’inspirazione avutane dalla stessa Vergine Maria” (OE24 232).
9. (S. Teresa Benedetta della Croce) – “Tutto il Vecchio Testamento deve essere una preparazione continua al Nuovo” (MB7 391).
10. (S. Lorenzo) – “Questa tenera affezione di san Lorenzo verso il Pontefice faceva sì che sebbene sul fiore di sua età, non altro desiderava che vivere o morire col suo maestro, aiutarlo in vita o andare con lui a godere la felicità del cielo” (OE12 281s).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia,Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.
PER L’APPROFONDIMENTO:
«Chiamati a diventare Capolavori». Vocazione e discepolato delle persone con disabilità

il nuovo numero della rivista «Catechetica ed Educazione» è online!
Editoriale
Il Giubileo che stiamo celebrando in questi mesi, con l’invito alla conversione e alla speranza, contiene un forte richiamo alla santità. L’appello a raggiungere (e mantenere) una “misura alta” della vita cristiana ordinaria – di cui san Giovanni Paolo II si è fatto a suo tempo portavoce – rimanda, a sua volta, al tema della vocazione e del discepolato.
L’argomento è strettamente legato a quello del “progetto di vita” delle Persone con Disabilità (PcD), affrontato nelle pagine di “Catechetica ed Educazione” nel primo numero dello scorso anno. La vocazione, cioè la chiamata personale e originale di Dio Padre a partecipare al suo progetto d’amore per l’intero creato, cui corrisponde in spirito di fede la risposta libera e responsabile di ogni persona, diventa criterio discriminante per lo stile di un’esistenza che si configura come un vero e proprio discepolato.
Come tutti, anche le PcD hanno una vocazione, una spiritualità, che le chiama a realizzarsi, in modo cangiante a seconda della condizione e del ciclo di vita, tenendo conto dei propri limiti funzionali. Sono loro stesse che devono rispondere alla proprio vocazione cristiana, testimoniando la loro fede e anche la bellezza della loro condizione umana, lavorando, servendo e interagendo nella comunità cristiana e nella società in ogni età e transizione di vita. In questo modo, insegnano che il limite può essere un “varco” verso Dio, e non solo un deficit. Tutti siamo esseri “limitati” davanti a Dio: la consapevolezza di questa coscienza passa anche attraverso la presenza delle PcD nella Chiesa e nel mondo.
Il rapporto tra santità, vocazione, discepolato e PcD è un tema significativo e per certi aspetti problematico: è possibile per loro, specie per quelle con disabilità intellettiva grave, rispondere con piena libertà e responsabilità all’appello che Dio rivolge a ogni uomo e donna di buona volontà? Come possono essere pure loro autentici “pellegrini di speranza”, come suggerisce il Giubileo?
Per rispondere a queste domande si propone un percorso articolato in tre momenti: uno di tipo fondativo, con tre contributi (pedagogico, filosofico e biblico-teologico); uno di taglio pastorale, che si riferisce rispettivamente alla formazione dei catechisti che operano nel mondo della disabilità, al ruolo dei presbiteri nei percorsi formativi e alla proposta del pellegrinaggio e degli esercizi spirituali; uno di tipo esperienziale, con l’intervista ad alcune persone che testimoniano e agiscono fattivamente nelle comunità cristiane a partire dalla loro situazione di PcD e la presenta-zione della figura di S. Margherita della Metola o di Città di Castello, prima santa disabile grave canonizzata.
La prima sezione vede, anzitutto, il contributo di Roberto Franchini, La voca-zione delle Persone con Disabilità: per una comunità generativa. Il pedagogista, nel considerare ancora una volta l’aporia tra l’aspirazione all’autodeterminazione della PcD e il progetto di vita che la comunità gli propone, individua nella spiritualità – la dimensione più intima dell’esistenza umana – la chiave per il superamento dell’impasse. Rispondendo alla chiamata vocazionale, la PcD realizza compiutamente sé stessa, e tutto ciò si traduce in ruoli e prospettive di operosità che la comunità deve favorire. In tal senso, viene presentato l’itinerario metodologico del PFTW (Putting Faith to Work) che suggerisce dei passi concreti per la “messa in opera” della spiritualità.
Ogni persona è chiamata da Dio a fare della propria vita un “capolavoro”. Il contributo di Cristiano Ciferri, Capolavori di Felicità… anche se non è facile, propone una riflessione filosofica sulla vocazione alla felicità per le PcD. Nel confronto con alcuni esponenti del Personalismo, a partire dal principio della “responsorialità”, viene enfatizzata l’importanza dell’impegno personale verso la “autorealizzazione”. Nell’economia del discorso, due riflessioni risultano particolarmente stimolanti: quella che si riferisce alla “libertà per” e la metafora del “disegno di vita”, preferita a quella di “progetto”. L’autore evidenzia la funzione regolativa della “speranza” e l’importanza di ripartire proprio dalla “fragilità” per raggiungere una pienezza di vita.
L’argomento della disabilità nella Bibbia è ampiamente esplorato; viene indagato, in questo caso, in rapporto alla speranza, che è il tema proprio del Giubileo. Giuseppe De Virgilio, nel suo: La disabilità nella Sacra Scrittura e l’esercizio della speranza. Aspetti biblico-teologici, articola la riflessione in tre momenti: presenta dapprima la concezione biblica della disabilità e la sua relazione con la malattia in generale per soffermarsi, poi, su alcuni elementi peculiari dell’Antico e del Nuovo Testa-mento. Traspare così una “teologia della debolezza”, non solo condizione antropologica della persona umana ma anche elemento qualificante l’identità della Chiesa che lungo la storia condivide la fragilità dell’umanità continuando a “confessare la speranza” (cf. Eb 10,23).
La seconda sezione, di indole pastorale, inizia con l’intervento di Veronica Amata Donatello, Formazione degli accompagnatori al discepolato per le Persone con Disabilità. Si constata la scarsa attenzione alla formazione di queste importanti figure pastorali e, sulla scia della riforma ministeriale promossa da papa Francesco, viene prospettato un ripensamento della disabilità non come barriera ma come profetico luogo teologico e pastorale. Una Chiesa autenticamente sinodale sa riconoscere nelle PcD non solo dei destinatari ma dei protagonisti nell’annuncio del Vangelo. Vengono quindi indicati dei passi concreti per approntare dei percorsi formativi realmente inclusivi.
Segue il contributo di Lawrence Sutton e Philip Kanfush, In pursuit of Master-piece: The role of the priest in helping those with developmental disabilities reach their potential as God defined it. Alla luce della loro esperienza di formatori del clero, i due autori presentano l’attuale prassi formativa in ambito statunitense, evidenziano alcuni elementi di criticità e suggeriscono dei correttivi atti a migliorare la qualità delle pro-poste formative. È un compito molto importante perché dai presbiteri – richiamati qui ad assumere come modello gli interventi inclusivi di Gesù – dipende ancora in gran parte la costituzione e crescita di comunità accoglienti e inclusive.
Nelle comunità cristiane si va sempre più diffondendo la pratica degli esercizi spirituali e ha ripreso forza il fenomeno del pellegrinaggio religioso. A queste manifestazioni religiose sono dedicati, gli altri due contributi. Il primo, di Samuele Ferrari, Siamo tutti pellegrini di Speranza. Le Persone con Disabilità e il pellegrinaggio, descrive i tratti peculiari del pellegrinaggio come esperienza liminale e come uno degli elementi fondamentali della vita cristiana. Si sottolineano i punti di contatto tra le dinamiche del pellegrino e quelle vissute dalle PcD e si offrono indicazioni e attenzioni pastorali da non trascurare per consentire alle PcD di essere, insieme alla comunità tutt’intera, a pieno titolo “pellegrini di speranza”.
Quello successivo, di Annalisa Caputo, titola provocatoriamente: Esercizi spirituali per Persone con Disabilità intellettiva? La studiosa, che vanta una riconosciuta competenza sul tema, attraverso un percorso che prende le mosse da s. Ignazio di Loyola e passa per l’analisi della mediazione profetica realizzata da Luigi Novarese, descrive le metodologie odierne applicate nel “Gruppo Attivo” del Centro Volontari della Sofferenza, fornendo così una risposta affermativa all’interrogativo iniziale.
La terza tappa del percorso vede, anzitutto, la raccolta delle testimonianze di alcune PcD intervistate da Isabella Tarsi, “Chiamati a diventare capolavori”: alcune testimonianze. Le risposte date fanno capire con chiarezza quanto ci sia di bello, di fresco, di entusiasmante, di valido nell’impegno di servizio alla propria comunità, in risposta a una specifica vocazione, di persone che sperimentano diverse forme di disabilità. Chiude poi il fascicolo l’excursus storico di Fabio Bricca, Santa Margherita della Metola o di Città di Castello. Tra le figure dei santi proposti come modello di vita ai battezzati fino a poco tempo fa non erano presenti le PcD, ma semplicemente persone con accentuata fragilità. Recentemente, invece, la canonizzazione della prima PcD grave colma questa lacuna. Nello studio vengono presentati gli elementi più salienti della sua biografia, ancora poco conosciuta.
L’Istituto di Catechetica (=ICa) ha sempre considerato un compito inderogabile l’aggiornamento sistematico della sua proposta formativa accademica, adeguandola ai progressi della ricerca scientifica – segnatamente nell’ambito catechetico – e alle provocazioni che il contesto culturale presenta di continuo. La storia dell’ICa, tratteggiata nei fascicoli di “Catechetica ed Educazione” pubblicati in occasione del suo settantesimo di vita, dà conferma della veridicità di quanto appena affermato.
Il seminario, le cui relazioni sono riportate in questa seconda sezione della rivista, prende in esame l’ultimo periodo di esistenza dell’ICa. Chiusa l’esperienza di collaborazione con l’Istituto di Teologia Pastorale nel Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica (1981-2016) e ritornati nell’ambito della Facoltà di Scienze dell’Educazione, i membri dell’ICa sentono l’esigenza di fissare per iscritto gli elementi di tipo epistemologico e strutturali che rendono originale l’ICa nel panorama catechetico internazionale per farli diventare così il punto di riferimento per organizzare la proposta formativa verso gli studenti che avrebbero frequentato l’università negli anni a seguire. Nasce così “Studiare catechetica oggi.
La proposta dell’Università Pontificia Salesiana” (2018). A questo testo si riferisce il contributo di Ubaldo Montisci, Studiare catechetica oggi. Un volume “interfaccia” per l’ICa. L’autore presenta il contesto in cui è stato ideato e realizzato il progetto, descrive la struttura del libro e si sofferma sulla descrizione delle peculiarità della proposta formativa, mettendone in luce punti di forza e criticità.
Nello sforzo di qualificare sempre più la proposta formativa, a seguito della recente pandemia che ha introdotto modifiche sostanziali nel modo di vivere e di credere di tante persone e della pubblicazione del “Direttorio per la catechesi” (2020), tra il 2022 e il 2024 l’ICa realizza un’indagine conoscitiva a livello mondiale tra i suoi Exallievi a partire dal 2000. Su questa esperienza, puntualmente riportata nel secondo fascicolo di “Catechetica ed Educazione” dello scorso anno, si concentra l’intervento di Benny Joseph: Il curriculum di catechetica come “laboratorio di dialogo”, a partire dalla Ricerca “La competenza riconsiderata (2000-2020). L’autore propone delle piste di riflessione ed evidenzia attenzioni specifiche, privilegiando la prospettiva del “laboratorio di dialogo”, giungendo a proporre il “paradigma del dialogo” quale orientamento per lo studio della catechetica e per il design del curricolo.
A queste prime due relazioni, seguono quelle di tre discussant, cui viene chiesta un’ulteriore riflessione in riferimento ai tre curricoli offerti attualmente dall’ICa: Catechetica, Catechetica e comunicazione ed Educazione religiosa.
Michele Roselli, nel suo Il percorso di Catechetica. Sollecitazioni per i curricula e per il dibattito, offre una riflessione in generale sul rapporto tra catechetica e catechesi e ne esamina le modifiche indotte dal contesto culturale attuale, che genera una “metamorfosi del cristianesimo”; quindi si sofferma sul curricolo proposto dall’ICa, sottolineandone elementi qualificanti e altri bisognosi di attenzione; chiude con alcune stimolanti provocazioni e suggerimenti utili per delle eventuali modifiche migliorative.
Segue il contributo di Vincenzo Corrado, Catechetica e comunicazione. Appunti per un orizzonte di senso. L’autore individua nella consapevolezza del cambio di paradigma culturale in atto e nell’accettazione del principio della realtà e del primato del tempo sullo spazio, gli elementi capaci di imprimere un nuovo dinamismo al percorso di Catechetica e comunicazione. Termina con alcune significative indicazioni specifiche per la riqualificazione del curricolo.
Chiude la serie, la relazione di Lorenzo Voltolin, Rinnovare il percorso di Educazione Religiosa nel contesto culturale. Il denso intervento mette in luce la complessità della tematica. Per rispondere in maniera efficace alla crescente pluralità culturale e religiosa, l’insegnante di religione dovrà maturare la capacità di ascolto delle domande provenienti dagli allievi e, insieme, l’attenzione ai contenuti teologici necessari per organizzare un curricolo formativo adeguato. Per quanto riguarda questi ultimi, è soprattutto sul “come” comunicarli che si dovrà lavorare. La proposta formativa dell’ICa non potrà prescindere dal prendere seriamente in considerazione la didattica interculturale, le tecnologie digitali e l’approccio ermeneutico-esistenziale alla materia.
I membri dell’Istituto di Catechetica
catechetica@unisal.it
ACCEDI ALLA RIVISTA ONLINE nella sezione “CATECHETICA ED EDUCAZIONE”
ALLEGATO:
Conclusioni sul Corso estivo IdR: Il sapere religioso nel tempo del dialogo
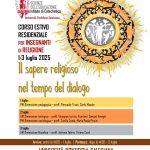
1-3 luglio 2025 presso Università Pontificia Salesiana di Roma – Piazza Ateneo Salesiano, 1
Conclusioni
(a cura di Sergio Cicatelli)
Quali erano i punti di partenza, le domande?
La domanda principale da cui siamo partiti era “che cos’è la religione”? Attenzione: non l’Irc ma la religione, intesa come genere prossimo dell’oggetto dell’Irc. C’è necessità di tornare ai fondamenti.
Le risposte offerte in questi giorni sono state diverse, in coincidenza con i diversi approcci discipli-nari. Ciò conferma che la religione è un oggetto complesso, che ognuno può trattare con le sue cate-gorie preferite, ma che necessita di un approccio come minimo multidisciplinare (non unilaterale).
Per lo specifico dell’Irc è rimasto sullo sfondo l’approccio politico/istituzionale, il Concordato, che molti hanno ripetuto essere una garanzia e una gabbia: finché c’è il Concordato ci sarà l’Irc, ma sempre nei limiti fissati dal Concordato, mentre intorno il mondo cambia.
Cosa ci portiamo a casa? Ognuno si porta a casa un bagaglio diverso. Qualche concetto chiave per ogni area.
Anzitutto, l’ordine delle sessioni di lavoro era del tutto casuale: non c’era alcuna propedeuticità e avremmo potuto adottare una sequenza diversa, proprio perché il principale risultato va cercato nella sintesi più che nella gerarchia o successione corretta dei problemi (e delle risposte).
1.
Proff. Triani e Macale (dim. pedagogica). La domanda poteva essere se la religione fosse inse-gnabile. Triani ha detto che la religione è “insegnanda”: deve far parte del curricolo perché serve alla formazione integrale della persona. Ma la scuola da sola non basta. Dobbiamo fare i conti con gli apprendimenti non formali e informali, che condizionano la percezione della religione.
2.
Prof. Lorizio e Escudero (dim. teologica). La domanda di partenza è stata se la religione possa essere oggetto della teologia. Lorizio ci ha dato una giustificazione teologica per la presenza dell’Irc nella scuola “di tutti”: la religione cattolica è per sua natura inclusiva, laica, aperta al pluralismo. È emersa anche l’irriducibilità della religione all’etica.
3.
Proff. Costa e Piccini (dim. sociologica). La religione non è isolabile dal contesto sociale e culturale. La parola chiave può essere “interdipendenza”. C’è un problema di rappresentazione religiosa nella cultura (giovanile) contemporanea. La domanda religiosa rimane la stessa, cambiano i linguaggi. C’è necessità di una testimonianza.
4.
Proff. Fabris e Conti (dim. filosofica). Religione e fede si sono soggettivizzate; al centro c’è l’individuo. Sta emergendo una nuova mitologia digitale al posto di quella tradizionale. Occorre però recuperare una fede incarnata e una relazione concreta. Dopo la demitizzazione, per la religione
Verifica del Corso
Alcuni scatti del corso:










La formazione per il ministero catechistico: sviluppo e principi di base
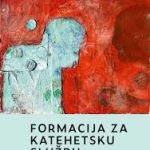
Marijana Mohorić
Dipartimento di Scienze Religiose,
Università di Zara https://orcid.org/0000-0002-8932-0355
Lo sviluppo del ministero catechistico ha inevitabilmente seguito il corso dello sviluppo storico delle comunità ecclesiali, e ciò ha influito sulla diversa concezione dell’identità dei catechisti e sulla loro formazione. In questo libro, il tema centrale è lo sviluppo del concetto di servizio catechistico con particolare enfasi sulla formazione dei catechisti nel periodo che va dal 1965 al 2021. Questo periodo è segnato da due eventi significativi: il Concilio Vaticano II (1965-1965) e l’istituzione da parte di Papa Francesco del ministero dei catechisti con il Motu proprio Antiquum ministerium (2021). L’ultimo evento ha coronato l’evoluzione dinamica delle domande e della ricerca di risposte relative all’impegno dei fedeli laici nell’attività catechetica della Chiesa, a cui è stato dato un impulso particolare da Papa Paolo VI negli anni Settanta del secolo scorso. Dopo l’analisi di questo processo, vengono presentati i fondamenti del ministero catechistico (la vocazione del catechista), gli aspetti teologici ed ecclesiali normativi e i criteri ispiratori per la formazione dei catechisti. Segue una discussione sulle cinque dimensioni della formazione del catechista. Esse non sono considerate competenze, ma ambiti formativi complementari che costituiscono la base per lo sviluppo delle competenze in una prospettiva integrale. Questa scelta è particolarmente elaborata nel quarto capitolo, dove viene elaborato il background concettuale dell’approccio delle competenze nella formazione dei catechisti. Infine, vengono evidenziate alcune possibili scelte metodologiche, e il motivo per proporle è la coerenza con la natura fondamentale non solo della formazione dei catechisti, ma della formazione cristiana in generale. Nelle riflessioni su questi temi è stato seguito un approccio interdisciplinare. Ancorati alla teologia, abbiamo cercato il dialogo con le scienze dell’educazione e quelle della comunicazione. Questo treppiede costituisce la base della catechesi come scienza. Il risultato non sono i piani per la formazione dei catechisti parrocchiali, ma gli orizzonti fondamentali della loro possibile creazione.
Link della pubblicazione in lingua croata: https://morepress.unizd.hr/books/index.php/press/catalog/book/137
UN’EDITRICE SALESIANA PER LA CATECHESI
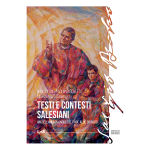
LA ELLEDICI E IL NUOVO CATECHISMO OLANDESE
(1966-1969)
Giuseppe BIANCARDII
[1] Giuseppe Biancardi, Salesiano di don Bosco, sacerdote, professore emerito della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana, Roma.
all’interno del volume:
Testi e contesti salesiani. Miscellanea in onore del prof. Aldo Giraudo
Un omaggio a una delle figure più autorevoli della ricerca storica e spirituale salesiana, questa miscellanea raccoglie contributi di studiosi che esplorano i temi centrali della tradizione salesiana, della pedagogia, della spiritualità e dell’Opera di Don Bosco.
Attraverso saggi che spaziano dall’analisi di testi inediti alla riflessione sul pensiero educativo salesiano, il volume mette in luce il valore del contributo accademico del Prof. Aldo Giraudo, riconosciuto per il suo approccio rigoroso allo studio delle fonti e per la sua capacità di coniugare ricerca storica e divulgazione.
Gli studi raccolti in questa miscellanea approfondiscono la trasmissione del carisma salesiano attraverso la predicazione e l’epistolario di Don Bosco, l’influenza della spiritualità di San Francesco di Sales, il ruolo dei primi salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice nella diffusione dell’opera educativa, e l’educazione dell’impegno salesiano nei diversi contesti storici e geografici. Particolare attenzione è dedicata al dialogo tra tradizione e rinnovamento nell’ambito della catechesi, della formazione e della missione salesiana nel mondo.
Curato dal Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana, questo volume rappresenta un prezioso contributo alla conoscenza della tradizione salesiana e un sentito tributo a un maestro e guida per generazioni di studiosi e ricercatori.
Il volume: https://editricelas.it/studi-e-strume…
Michal Vojtáš – Presentazione della miscellanea in onore del prof. Aldo Giraudo
Global RE© May – June 2025
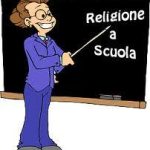
Condividiamo un bollettino che annuncia le novità bibliografiche sugli IR e gli Studi Religiosi dei 5 continenti.
May – June 2025 ● vol. 4, issue 3, pages 1– 44
An International Bibliographic Bulletin on Religious Education & Religious Studies around the World
by Flavio Pajer , ed
SCARICA IL NUMERO PER LA CONSULTAZIONE
Festa dei Partenti dell’Istituto di Catechetica UPS

Con grande gioia e partecipazione, l’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana ha celebrato, il 21 maggio di quest’anno giubilare, la Festa dei Partenti, un momento speciale dedicato agli studenti che stanno per concludere il loro percorso di studi e che ora si preparano a tornare nelle loro terre di missione.
Dopo anni di approfondimento teologico e pastorale, questi catecheti partiranno per le loro rispettive comunità nei quattro continenti di provenienza (manca all’appello solo l’Oceania), dove continueranno il loro impegno nelle proprie diocesi o congregazioni di appartenenza.
Un evento di fede e fraternità
La celebrazione ha avuto il suo momento centrale nella Santa Messa, vissuta con profonda spiritualità e partecipazione da parte di tutti gli studenti e docenti dell’Istituto. Un’occasione per ringraziare Dio per il cammino formativo vissuto e affidare a Lui il nuovo percorso che attende i partenti.
A seguire, il pranzo comunitario ha permesso ai presenti di condividere un clima di gioia e fraternità, rafforzando i legami costruiti nel tempo trascorso insieme.
Un augurio per il futuro
L’ICa esprime il suo affettuoso augurio a questi catecheti, affinché possano continuare a diffondere il Vangelo con passione e dedizione, portando la luce della fede nelle loro comunità. Il direttore dell’Istituto, don Giuseppe Ruta, ha sottolineato l’importanza di mantenere vivi i contatti, promuovendo una formazione continua e favorendo la creazione di reti e comunità di ricerca per un dialogo e un approfondimento sempre più ricco.
Che il loro servizio sia fecondo e che il Signore li accompagni sempre.












