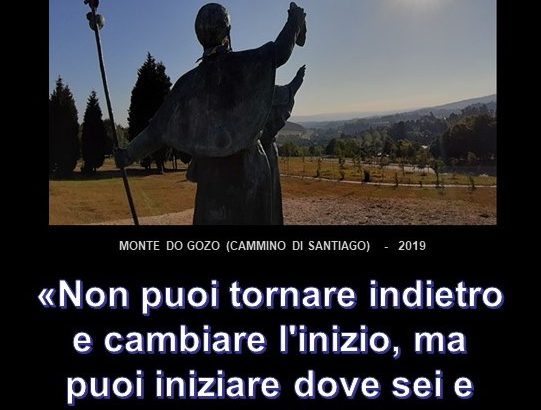Lectio – Anno C
Prima lettura: Sapienza 18,6-9
| La notte [della liberazione] fu preannunciata ai nostri padri, perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici. Difatti come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa legge divina: di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri. |
Ai discepoli, come abbiamo visto, Gesù richiede fedeltà e saggezza, affinché possano camminare nella storia incontro al Signore e guidare responsabilmente coloro che sono stati loro affidati. Non è un caso, allora, che la liturgia odierna ci proponga alcuni versetti del Libro della sapienza, il quale, nei capitoli dal 10 al 19, riprende la storia dell’esodo con lo scopo di farne un commento. L’autore di questo libro (scritto verso la fine del I secolo a.C.) si rivolge continuamente alla sapienza, lodandone la preveggenza e la perfezione del suo operare nella natura, nella politica, nella storia e, ancor più, nella rivelazione dell’unico Dio.
Nel cercare un momento nella storia d’Israele, in cui magnificare l’azione della sapienza, quale occasione migliore poteva esserci della liberazione dall’Egitto? In quel frangente, la guida della sapienza si è rivelata esemplare, perché Dio non si accontentò di dare al popolo soltanto Mosè, il mediatore, bensì volle che la sapienza stessa facesse come da schiavo lampadarius, ossia da servo che precede reggendo la lanterna, per illuminare la strada al popolo che doveva percorrerla: «Invece delle tenebre desti loro una colonna di fuoco, come guida in un viaggio sconosciuto e come un sole innocuo per il glorioso emigrare» (v. 3).
Sostenuti dalla sapienza, fu possibile affrontare quella notte oscura, durante la quale gli ebrei uscirono dall’Egitto per andare incontro alla libertà tanto agognata (cf. Es 12): «La notte [della liberazione] fu preannunciata ai nostri padri, perché avessero coraggio, sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici» (vv. 6-7). L’evento della Pasqua viene così rivisto alla luce della gloria, cioè della rivelazione del piano di Dio, che porta salvezza a chi crede in lui, ma diventa elemento di giudizio per chi lo rifiuta: «Difatti come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa legge divina: di condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri» (vv. 8-9).
L’autore del Libro della Sapienza, quindi, sottolinea la necessità di ripresentare (ossia di fare il memoriale) la Pasqua per far ricordare alle generazioni future che Dio non abbandona e che le sue promesse sono eterne. Ma la celebrazione della Pasqua conferma pure che «i santi avrebbero partecipato ugualmente ai beni e ai pericoli», ossia al bene e al male della storia. Infatti, la storia, come non ha in sé il suo inizio, non può avere in sé il proprio compimento. Perciò siamo in attesa di Dio, mentre ci viene chiesto di amministrare fedelmente e saggiamente quanti egli ci ha affidato.
Seconda lettura: Ebrei 11,1-2.8-19
| Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo. |
Il brano della lettera agli Ebrei, in qualche modo, presenta l’opportunità di riflettere sulla figura di un servo fedele e saggio come il patriarca Abramo. Infatti, tra i vari personaggi dell’Antico Testamento citati dall’autore, spicca per ampiezza proprio il riferimento al capostipite d’Israele. D’altra parte, parlando della fede, non si può trascurare colui che ne è un vero campione, specialmente se si considera la definizione che la Lettera agli Ebrei ne dà: «La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio» (vv. 1-2).
Della vita di Abramo si riprendono tutte le tappe più importanti, a partire dalla vocazione, per mezzo della quale cambiò anche patria. La sua vita, tutta riposta nella fede in Dio, divenne modello pure per Isacco e Giacobbe, nonché per Sara: «Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare» (vv. 11-12). Inoltre, la stessa nascita d’Isacco e il sacrificio di quest’unico figlio (cf. Gen 22) fanno ancora giganteggiare Abramo, al cui confronto la fede di tanti altri impallidisce: «Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo» (vv. 17-19).
Per ritrovare dei testimoni autentici, che sappiano insegnare che cosa sia la fede, pur vivendo nelle difficoltà quotidiane, la Lettera agli Ebrei volge lo sguardo al passato remoto d’Israele: lì vengono identificati questi uomini che hanno ancora molto da insegnare. Così possiamo spiegarci le parole dei vv. 13-16, che suonano come una lode ai patriarchi, i quali, pur non avendo a disposizione ciò che noi abbiamo (la rivelazione piena in Gesù Cristo, la Chiesa, i sacramenti…), hanno saputo capire che ciò che Dio prometteva loro era più certo di quello che vedevano: «Nella fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città».
Tale città celeste è stata preparata anche per noi: in essa incontreremo tutti coloro la cui fede ci è stata di conforto e stimolo mentre muoviamo i nostri incerti passi su questa terra.
Vangelo: Luca 12,32-48
| In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». |
Esegesi
Il brano evangelico di questa domenica comincia con un versetto che vale come una rassicurazione per coloro che, essendo piccoli e poveri, riceveranno in eredità ciò che più conta in assoluto: il regno di Dio. Infatti, dopo aver invitato a non imitare i farisei (12,1), a non accumulare tesori sulla terra (12,13-21) e ad avere fiducia nella provvidenza (12,22-31), Gesù afferma: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno» (12,32). Nel piccolo gregge egli vede coloro che cercano in primo luogo il regno di Dio (12,31) e sanno che il cuore, se vuole essere sinceramente libero, non può attaccarsi ai beni di questa terra. Da qui l’esortazione a disfarsi delle ricchezze, che nell’opera lucana costituisce un tratto caratteristico, basti pensare al celebre racconto che ha per protagonisti Anania e Saffira negli Atti degli apostoli.
Le ricchezze sono percepite da Luca come un pericolo: a causa loro, la coscienza dell’uomo in generale, e persino del credente, si assopisce e si stordisce, al punto di non saper capire che non è in esse che si trova la salvezza e la riuscita. Fidarsi dei beni terreni vuol dire vivere una vera e propria ubriacatura, come quella consumistica che sperimentiamo tutti i giorni, per cui l’ideale da perseguire è soddisfare il desiderio di avere, un desiderio che si autoalimenta perché siamo avvolti in una spirale nella quale non si può mai dire basta, se si vuole “stare al passo con i tempi”. Perciò, Gesù narra due brevi parabole (vv. 36-38 e v. 39), il cui scopo è di spingere alla prontezza, secondo quanto i versetti 35 e 40 sottolineano: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese […] Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo ».
Al versetto 41, Pietro rivolge a Gesù una strana domanda: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». L’apostolo vorrebbe sapere che ruolo devono svolgere i discepoli: devono rinchiudersi in un’attesa del tempo in cui Gesù ritornerà o devono fare come Giona, che avvertì gli abitanti di Ninive a riguardo della catastrofe imminente. Gesù preferisce, a sua volta, rispondere con un’altra parabola, in cui il personaggio è un servo, ma questa volta investito di un’autorità particolare: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito?» (v. 42). L’allusione è trasparente: poiché Pietro vuol sapere qual è il compito suo e degli altri apostoli fino al tempo della parusia, gli viene risposto che lui con gli altri apostoli sono come degli amministratori, che agiscono per conto di Gesù.
Perciò, egli avverte i suoi discepoli. Nei confronti del gregge loro affidato, essi devono essere coscienziosi e irreprensibili. Gesù adopera gli aggettivi «fedele e saggio», perché, in primo luogo, essi amministrano un patrimonio che non appartiene a loro e, inoltre, devono usarlo con oculatezza, prudenza e, soprattutto, con tanto amore, per dispensare il «cibo» necessario agli altri servi e, così, permettere loro di giungere al momento nel quale il Signore ritornerà.
Meditazione
Le letture di questa domenica mettono a fuoco un aspetto fondamentale dell’esistenza cristiana: l’attesa della venuta del Signore. Un’attesa che, soprattutto nella pagina evangelica, prende la forma concreta di una continua vigilanza. Come osservava il card. C.M. Martini nella sua Lettera pastorale Sto alla porta: «Vigilare non è un atteggiamento marginale della vita cristiana, ma ne riassume la tensione caratteristica verso il futuro di Dio congiungendola con l’attenzione e la cura per il momento presente». Se proprio del cristiano è vigilare «ogni giorno e ogni ora» (come ci ammonisce il grande padre della Chiesa Basilio), il suo esercizio si fa ancora più urgente di notte, quando il sonno e la stanchezza possono prendere il sopravvento e l’oscurità può far smarrire il sentiero che conduce all’incontro con Dio. I primi cristiani sapevano che l’avvento del Signore sarebbe giunto all’improvviso, «come un ladro di notte» (1Ts 5,2), per questo cercavano di vivere in modo tale da non lasciarsi trovare impreparati a questo evento. Così la Chiesa, anche oggi, vive il tempo del suo pellegrinaggio terreno come una lunga e interminabile notte, durante la quale attende insonne lo spuntare del giorno nuovo (cfr. Rm 13,12).
Il testo della prima lettura, tratto da libro della Sapienza, ci parla dell’attesa di Israele («Il tuo popolo era in attesa della salvezza dei giusti»: v. 7) che trova compimento nella «notte della liberazione». È la notte in cui Dio stesso veglia sul suo popolo per farlo uscire dal paese d’Egitto (cfr. Es 12,42), realizzando così le promesse già annunciate ai patriarchi (cfr. Sap 18,6). Allo stesso modo, il passo della Lettera agli Ebrei (seconda lettura) ci ricorda l’attesa di Abramo, maturata nella notte della fede (culminata nella prova dell”offerta’ di Isacco: cfr. v. 17) e nella ricerca di «una patria migliore» di quella da cui era uscito (cfr.vv. 14-16).
Nel brano evangelico ci vengono presentate tre brevi parabole (Lc 12,35-48) – precedute da un’esortazione a disfarsi dei beni di questo mondo per farsi un tesoro nei cieli (vv. 33-34) – che potremmo definire un piccolo ‘vangelo dell’attesa’. In esse, infatti, troviamo declinati i diversi aspetti dell’attesa cristiana e le molteplici sfumature che, di volta in volta, può assumere la vigilanza. In quei servi che aspettano il ritorno del loro padrone pronti ad aprirgli subito la porta (vv. 36-38), in quel padrone che scruta (o meglio, che dovrebbe scrutare) con attenzione l’ora in cui arriva il ladro per non lasciarsi scassinare la casa (vv. 39-40), in quel maggiordomo (o amministratore) che durante l’assenza prolungata del padrone è chiamato a prendersi cura responsabilmente dei servi a lui affidati (vv. 41-48), ci viene illustrata la multiforme ricchezza di significati della vigilanza evangelica. Essa comporta prontezza e attenzione (perché in ogni momento può giungere il padrone o il ladro); pazienza e perseveranza (la capacità di attendere anche tutta la notte); fedeltà e responsabilità nel compiere il proprio dovere; disponibilità al servizio, sempre e comunque. Tutto questo può essere bene sintetizzato nelle due immagini che compaiono nell’esortazione iniziale: ««Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi (lett.: siano cinti i vostri fianchi) e le e lampade accese» (v. 35). I «fianchi cinti» è immagine comune nella Bibbia per indicare l’atteggiamento di chi si predispone a compiere qualche lavoro o a intraprendere un viaggio (cfr. Lc 17,8; At 12,8). Ma, soprattutto, evoca l’atteggiamento di Israele mentre si prepara a celebrare la Pasqua nella notte in cui il Signore passa a liberarlo: «Ecco in qual modo mangerete l’agnello: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore! In quella notte io passerò…» (Es 12,11-12). Il Signore «passa», perciò bisogna farsi trovare pronti per intraprendere con lui il cammino dell’esodo dall’Egitto. L’altra immagine, delle «lampade accese», è piuttosto metafora del vegliare durante l’oscurità della notte (cfr. la parabola delle vergini sagge e stolte in Mt 25,1-13). Il credente che attende il suo Signore deve essere dunque come un viandante, continuamente in cammino – mai pago di ciò che ha raggiunto -, e deve essere sempre pronto ad attendere al proprio servizio – sino alla fine -. Nella certezza che, comunque, anche attraverso la notte più oscura, ha sempre una luce, una piccola lucerna che lo guida: la parola che il Signore gli ha donato (cfr. Sal 118/119,105; nella prima lettura è la «colonna di fuoco» che funge da guida nel viaggio della notte pasquale, cfr. Sap 18,3).
«Non temere, piccolo gregge…» (Lc 12,32). Con questa parola di consolazione e incoraggiamento si apre il vangelo odierno. Pur nella sua piccolezza e insignificanza, nella sua fragilità costantemente minacciata, il piccolo gregge dei discepoli può avanzare con fiducia perché ha già ricevuto in dono tutto quello che da Dio può sperare e desiderare: il suo Regno. Con il cuore in questo «tesoro» (vv. 33-34), allora, aspetta con speranza incrollabile il Signore che ritorna, consapevole che meno si attaccherà ai propri beni e più sarà capace di attendere il grande bene del Regno. Perché tra povertà e attesa c’è un intimo e imprescindibile legame: un cuore ingombro e distratto da troppe cose, infatti, non ha più quella libertà e quella forza di attendere da Dio solo il compimento di ogni suo bene.
«Beati coloro che aspettano (trad. CEI: sperano in) lui», dice il profeta Isaia (30,18). In se stessa, l’attesa è già fonte di beatitudine e di autentica felicità. Perché mantiene il cuore aperto nella direzione del suo desiderio più vero, facendogli in qualche modo già pregustare la gioia dell’incontro. E anche nel nostro passo evangelico, per ben tre volte, risuona la formula: «Beati…» (vv. 37.38.43). E in tutti i tre i casi la beatitudine è scandita da quell’«essere trovati». Trovati «così», ad «agire così». Cioè nientemeno che intenti e attenti al proprio lavoro, al proprio compito, al proprio servizio. Non ci è chiesto altro che di attendere attendendo al compito che ci è stato affidato, con tutta la responsabilità e la fedeltà di cui siamo capaci. E scopriremo allora, con stupore, che per Dio questo semplice fatto è già cosa immensa e stupefacente, tanto da essere ripagata con una risposta che ha dell’eccessivo e dell’inimmaginabile: «In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli» (v. 37). Il Signore che si fa servo dei suoi servi: mirabile capovolgimento divino!
A questo punto, ci si può chiedere se noi aspettiamo un Signore così. Oppure il suo volto conserva per noi ancora i tratti inalterati di un giudice terribile e inquietante, di un ladro temibile e senza scrupoli o di un padrone duro e severo, che non esiterà a punire con rigore chi non avrà agito secondo le sue disposizioni?
Don Bosco commenta il Vangelo
XIX domenica del tempo ordinario
Il tesoro è Gesù stesso
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore (Lc 12,32).
Per un cristiano il tesoro è anzitutto Gesù stesso. Facendo il ringraziamento dopo la comunione il giovane pregherà così:
Io non son degno di sì grande favore, nemmeno so che cosa offrirvi in ringraziamento; ma appoggiato ai vostri meriti vi offro questi meriti medesimi, che sono infiniti. Vi ringrazio di tutto cuore, e protesto che per l’avvenire Voi sarete sempre il mio piacere, il riposo dell’anima mia; Voi solo la mia speranza, il mio conforto; Voi solo la mia ricchezza, il mio bene, il mio possesso, il tesoro del mio cuore (OE35 240s).
Lo stesso pensiero si trova nei suoi Cenni storici intorno alla vita della B. Caterina De-Mattei da Racconigi dove don Bosco scrive:
Caterina vide una volta Gesù Cristo, Maria SS. con molti altri santi, i quali parevano vestiti a duolo, e più di tutti mostravasi addolorato il suo sposo Gesù. Tosto Caterina gli domandò la cagione di sì grande tristezza. Gesù le rispose: “E come non vuoi che io mi mostri così afflitto al vedere che tante anime vanno alla perdizione? E non vedi quanto sia grande l’ingratitudine del mio popolo, che io ho redento col mio sangue? Sono io pure un prezioso tesoro, il sommo ed eterno bene, e tuttavia la maggior parte degli uomini fanno più conto dei beni miserabili di questa terra” (OE14 62s).
L’Eucaristia ricevuto in Viatico prima di morire era il tesoro di Luigi Comollo, come racconto don Bosco nella sua biografia:
Con forti slanci tentava portarsi verso il SS. Sacramento; io mi sforzava onde trattenerlo in letto; mi cadevan le lagrime dagli occhi per tenerezza, e stupore, non sapeva che dire, né che rispondergli; ed egli vieppiù si dibatteva onde portarsi verso il SS. Viatico, né s’acquetò finché non l’ebbe ricevuto. Dopo la Comunione tutto nei più affettuosi sentimenti concentrato verso il suo Gesù, stette alcun tempo immobile, quindi ripieno di meraviglia «oh! portento d’amore, esclamava. Chi mai son io per essere fatto degno di tesoro sì prezioso! (OE1 58).
Parlando del Papa e dell’Eucaristia nei suoi Episodi ameni e contemporanei don Bosco scrive ancora:
La sposa di Cristo conserva il deposito delle verità, il tesoro dell’Eucarestia, la sorgente dei sacramenti, che sono i canali della grazia divina; ella offre a Dio il sacrifizio, che a Lui è gradito, e riposa sopra Pietro come un edificio sopra immobili fondamenta (OE15 206).
Il tesoro più grande su questa terra è la presenza di Gesù nell’Eucaristia. Scrive don Bosco nelle Pratiche divote per l’adorazione del SS. Sacramento:
La presenza di Gesù è un tesoro che avremmo invano cercato sulla terra se Egli non ci fosse rimasto per amor nostro. Ma Esso è là, in mezzo a noi, Egli ci apre le sue braccia, il suo cuore. Dove troveremo noi un amico che intenda le nostre pene e ci compatisca, un orecchio che non si stanchi mai di ascoltarci, una voce che mai si stanchi di dirci quelle parole di consolazione che sono il meglio adattate per fortificarci e sollevarci? Andiamo adunque a Gesù. Ah sì! il pane della Eucaristia dovrebbe essere il pane quotidiano dell’anima che soffre, perché è un pane che fortifica e consola; esso ha la virtù di rendere dolci le più amare lagrime, di rendere facili i maggiori, i più dolorosi sacrifici (OE17 267).
Nella Scelta di laudi sacre un canto al Cuore di Gesù comincia con questa strofa:
O dolce mia speranza,
Mio caro e buon Gesù (OE31 332).
(Morand Wirth)
Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.
L’immagine della domenica
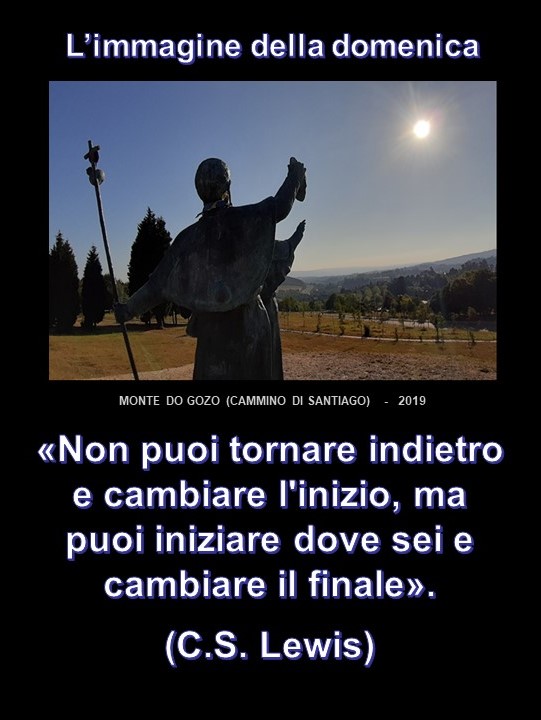
| MONTE DO GOZO (CAMMINO DI SANTIAGO) – 2019 |
«Non puoi tornare indietro
e cambiare l’inizio,
ma puoi iniziare dove sei
e cambiare il finale».
(C.S. Lewis)
| Sapienza 18,6-9Ebrei 11,1-2.8-19Luca 12,32-48 Il cristiano, memore di un’antica promessa mai smarrita, è proteso verso il futuro. Deve dunque vivere l’ora presente con grande vigilanza, cioè con un forte senso di attesa e con scelte sagge e responsabili. Il brano del Vangelo di Luca di questa domenica mette fortemente in risalto la tensione verso il futuro che deve caratterizzare la vita del cristiano. Senza questa tensione, senza questa vigilanza, la fede diventa irriconoscibile e presto svanisce, perché dimentica il Signore e la sua venuta. Solo vivendo il tempo nell’attesa serena, intelligente e attiva, la storia umana diventa storia di salvezza, cessando di essere destino enigmatico e cieco a cui abbandonarsi. Solo nella saggezza delle decisioni prese nel momento presente, l’oggi si apre verso il futuro e il tempo si dischiude verso l’eternità. Con il tipico linguaggio sapienziale, Gesù vuole risvegliare in noi il senso vigilante della nostra libertà: perché la libertà non si disperda in piccole e inutili cose, perché non si addormenti, ma corrisponda con gioia e prontezza all’amore e alla grazia che Dio continuamente ci concede. |
Preghiere e racconti
Il giudizio
Il giudizio di coloro che insegnano sarà più severo, il Salvatore chiederà molto a chi avrà dato molto. Che cos’è questo molto che viene richiesto? La saldezza nella fede, la rettitudine nell’iniziazione al mistero, la costanza nella speranza, la persistenza nella sopportazione, la solidità nella forza spirituale, l’ardore e il vigore in ogni sorta di buone imprese, per essere agli occhi altrui un abbozzo di vita evangelica.
(Cirillo di Alessandria, Sermone 93 sulla parabola dell’amministratore infedele)
L’attesa del Signore
L’attesa del Signore non solo rende senza valore le cose diverse da quelle che noi attendiamo, ma ci sottrae lo stesso istante presente. Infatti, ciò che noi attendiamo non è la presenza dell’istante. Ciò che ci interessa non è ciò che l’istante è in sé. Ciò che noi attendiamo, ciò che ci interessa soprattutto, è colui che l’istante ci porta, è la venuta e il tocco del Signore in questo istante… Per colui che attende Gesù, ogni istante si estende e si illumina. Si estende, perché lo vediamo tendere verso la sua pienezza. Si illumina, perché già la presenza di Gesù vi proietta la luce di una venuta ancor più perfetta. Gesù verrà ancora, verrà sempre, fino alla seconda gloriosa venuta. Gesù è venuto. Viene in noi in ogni minuto. E ognuno dei nostri minuti non ha altro valore se non questa venuta e questa presenza di Gesù che ha potuto portarci.
(Un monaco della Chiesa d’Oriente, Il Volto di luce)
Beato il servo
Beati coloro che esultano
nello Spirito di Gesù
e vegliano per i loro fratelli.
Beato il servo
che vegliava nella notte
nel nome del Figlio di Dio.
Beato il servo
che vegliava nella notte!
Beati coloro che restano nella pace di Gesù
quando vengono le tenebre.
Beato il servo
che vegliava nella notte
nel nome del Figlio di Dio.
Beati coloro che scoprono
nella morte di Gesù
dove vanno le notti umane.
Beato il servo
che vegliava nella notte
spiando il giorno di Dio.
Beati coloro che esultano
nello Spirito di Gesù
e rendono gloria al Padre.
Beato il servo
che vegliava nella notte e vede il giorno di Dio.
(Commissione francofona cistercense, Libro di canti).
Attenzione e vigilanza
Giocando sull’assonanza fra prosoché (attenzione) e proseuché (preghiera) l’antica tradizione cristiana ha affermato lo stretto legame tra queste due realtà: «L’attenzione che cerca la preghiera troverà la preghiera: la preghiera infatti segue all’attenzione ed è a questa che occorre applicarsi» (Evagrio Pontico). In tempi più recenti Simone Weil, riprendendo Malebranche, ha parlato dell’attenzione in termini di preghiera. L’attenzione è la preghiera naturale che l’uomo fa alla verità interiore perché gli si disveli. L’attenzione è faticosa e dolorosa e nell’animo umano vi è qualcosa che vi si oppone con grande veemenza, molto più violentemente di quanto alla carne ripugni la fatica.
All’attenzione si accompagna la vigilanza. Il «vigilante» è l’uomo sveglio, non addormentato, non intontito, è l’uomo lucido e critico, non passivo, è l’uomo responsabile e cosciente. È l’uomo che si lascia colpire e interpellare dagli eventi. Come dimenticare che l’esperienza che ha condotto il Budda allo stato di «svegliato», di «illuminato», è passata attraverso la presa di coscienza della tragica esperienza della malattia, della vecchiaia e della morte? L’homo vigilans è presente a sé e agli altri, alle realtà umane e storiche, ha radici in se stesso e non attende dall’esterno di sé la conferma al proprio agire e alla propria identità. È l’uomo paziente e perseverante, profondo, capace di dare continuità ad una scelta… Non stupisce che un padre del deserto abbia detto: «L’unica cosa di cui abbiamo bisogno è uno spirito vigilante» (Abba Poemen). All’opposto dell’homo vigilans si colloca l’homo dormiens, colui che resta al di qua delle proprie possibilità, che ha paura, che vive orizzontalmente più che in profondità, che si disperde in mille cose da fare o in tante cose da possedere, che è pigro e negligente, che trascina la sua vita come se fosse illimitata considerandola un divertissement.
È colui che non ha passione, è nella sonnolenza, cioè nella morte. Nella mitologia greca Hypnos (Sonno) è gemello di Thanatos (Morte)! Il vigilante è colui che lotta contro il sonno e dunque contro la morte ponendosi come uomo di luce.
(Luciano MANICARDI, La vita interiore oggi. Emergenza di un tema e sue ambiguità, Magnano, Qiqajon, 1999, 20-21).
La vigilanza
Il credente si prepara alla lotta spirituale con la vigilanza: il NT chiede a più riprese di essere sobri e temperanti, di stare in guardia, di vegliare, di stare svegli, di stare attenti, di essere pronti. La vigilanza è atteggiamento umano e spirituale con cui l’uomo è presente a se stesso e a Dio: è attitudine di lucidità e di criticità che lo mantiene perseverante e non distratto, non dissipato. L’uomo vigilante è attento a tutto il reale, lucido nei confronti di se stesso e della realtà, attento agli eventi e agli incontri, sollecito al proprio ministero, responsabile, capace di pazienza e di profondità. Al contrario, chi non vigila è un uomo addormentato, intontito, che vive sotto il segno della paura, della superficialità, della pigrizia e della negligenza. È l’uomo che teme il faccia a faccia con se stesso, che preferisce la tenebra alla luce, che evita di mettersi in discussione e di confrontarsi… In obbedienza al comando del Signore («Vegliate e pregate per non soccombere nella tentazione»: Matteo 26,41), la tradizione spirituale ha associato la vigilanza alla lotta spirituale e alla preghiera, che di tale lotta è l’arma per eccellenza, ed ha fatto della vigilanza l’arte della purificazione dei pensieri, della “custodia del cuore”, il momento fondamentale della lotta contro il peccato. È dunque ovvio che, nella formazione alla lotta spirituale, occorre condurre alla adesione alla realtà (e anzitutto alla realtà propria, personale, riconoscendo e dando il nome alle lacune, alle debolezze e alle negatività che ci abitano) e alla strutturazione dello spazio interiore (educando a leggere, pensare, interpretare gli eventi, dialogare interiormente). E questo, naturalmente, mentre si introduce all’ascolto della Parola di Dio nella Scrittura, dunque alla conoscenza del Signore.
Luciano MANICARDI, La lotta spirituale, in CENTRO REGIONALE VOCAZIONI (PIEMONTE-VALLE D’AOSTA), Corso di avvio all’accompagnamento spirituale. Atti, a cura di Gian Paolo Cassano, Casale Monferrato, Portalupi, 2007, 143-144.
La vigilanza
Se l’inautenticità è una produzione della mente, ne viene che condizione essenziale per l’autenticità è il controllo della mente. Ma come si controlla la mente? Riportandola al reale. Fermandola sul reale. Inchiodandola sul reale. È in questa prospettiva che io interpreto l’invio di Gesù alla vigilanza, la grégorsis evangelica, quando dice “vegliate” (Matteo 24,42), “tenetevi pronti” (Matteo 24,44), “vegliate e pregate per non entrare in tentazione” (Matteo 26,41). Non si tratta tanto di attendere un’improbabile fine del mondo con l’arrivo degli angeli allo squillo di trombe secondo scenari apocalittici che hanno terrorizzato le coscienze nei secoli passati ma che ora per fortuna non fanno più paura a nessuno, quanto piuttosto di aderire al presente, di leggerlo per quello che è, senza mentire mai, né applicandovi categorie improprie né occultandone i fatti che mettono in crisi la propria visione del mondo, perché la prima cosa di cui diffidare, a proposito delle tentazioni da cui metteva in guardia Gesù, è la falsità dei pensieri. Questa è la vigilanza dell’uomo maturo, adeguata alla coscienza contemporanea.
(Vito MANCUSO, La vita autentica, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2009, 82-83).
Vogliamo essere pronti
Vogliamo essere pronti.
Non sappiamo quando verrai a cercarci;
l’ora della nostra morte può essere una sorpresa,
come tu ce l’hai detto, Gesù, nel Vangelo.
Vogliamo essere pronti.
Tu ci hai esortati a non allentare
i nostri sforzi vigilanti, a non lasciarci
vincere dalla pigrizia o dalla noncuranza.
Vogliamo essere pronti,
conservando con te i nostri contatti amichevoli,
cercando di piacerti in tutta la nostra vita,
pregandoti più forte, con un cuore sincero.
Vogliamo essere pronti,
premurosi d’agire con carità,
quella carità di cui hai fatto il grande comandamento:
noi desideriamo amare più generosamente.
Vogliamo essere pronti,
ponendo solo in te la nostra fiducia,
e volgendo verso di te tutta la nostra speranza:
tu tieni nelle tue mani la nostra sorte eterna.
(Jean Galot,da: Apri loro la porta…, Sorrento, Benedettine, 1980).
La Settimana con don Bosco
4-10 agosto 2025
4. (S. Giovanni Maria Vianney) – “Gesù Cristo è là in persona, esclamava il parroco d’Ars; si vada ai piedi del Tabernacolo” (MB9 355).
5. (Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore) – Papa Sisto V “eresse ancora nella Chiesa di Santa Maria Maggiore una magnifica cappella in onore del Presepio del Verbo incarnato” (OE18 3909).
6. (Trasfigurazione del Signore) – “Gesù con questo fatto si manifesta Figliuolo di Dio, Dio eterno egli stesso, e predice nel tempo medesimo che sarebbe di virtù propria risuscitato” (OE27 383).
7. (S. Sisto II e comp.) – “Il mio sacrificio non è fatto con carne di miseri animali, ma con un’ostia pura ed immacolata” (OE12 285). – (S. Gaetano) “Non potendo da solo compiere tutte le opere che formavano incessante oggetto della sua carità, si cercò alcuni zelanti compagni, coi quali cominciò vita comune” (OE24 278s).
8. (S. Domenico) – “A san Domenico è attribuita l’istituzione del Rosario, secondo l’inspirazione avutane dalla stessa Vergine Maria” (OE24 232).
9. (S. Teresa Benedetta della Croce) – “Tutto il Vecchio Testamento deve essere una preparazione continua al Nuovo” (MB7 391).
10. (S. Lorenzo) – “Questa tenera affezione di san Lorenzo verso il Pontefice faceva sì che sebbene sul fiore di sua età, non altro desiderava che vivere o morire col suo maestro, aiutarlo in vita o andare con lui a godere la felicità del cielo” (OE12 281s).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia,Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.