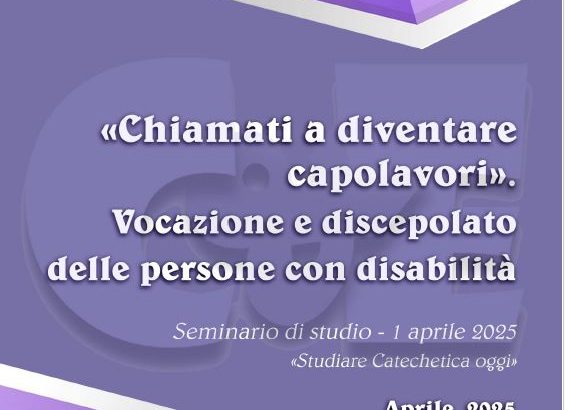il nuovo numero della rivista «Catechetica ed Educazione» è online!
Editoriale
Il Giubileo che stiamo celebrando in questi mesi, con l’invito alla conversione e alla speranza, contiene un forte richiamo alla santità. L’appello a raggiungere (e mantenere) una “misura alta” della vita cristiana ordinaria – di cui san Giovanni Paolo II si è fatto a suo tempo portavoce – rimanda, a sua volta, al tema della vocazione e del discepolato.
L’argomento è strettamente legato a quello del “progetto di vita” delle Persone con Disabilità (PcD), affrontato nelle pagine di “Catechetica ed Educazione” nel primo numero dello scorso anno. La vocazione, cioè la chiamata personale e originale di Dio Padre a partecipare al suo progetto d’amore per l’intero creato, cui corrisponde in spirito di fede la risposta libera e responsabile di ogni persona, diventa criterio discriminante per lo stile di un’esistenza che si configura come un vero e proprio discepolato.
Come tutti, anche le PcD hanno una vocazione, una spiritualità, che le chiama a realizzarsi, in modo cangiante a seconda della condizione e del ciclo di vita, tenendo conto dei propri limiti funzionali. Sono loro stesse che devono rispondere alla proprio vocazione cristiana, testimoniando la loro fede e anche la bellezza della loro condizione umana, lavorando, servendo e interagendo nella comunità cristiana e nella società in ogni età e transizione di vita. In questo modo, insegnano che il limite può essere un “varco” verso Dio, e non solo un deficit. Tutti siamo esseri “limitati” davanti a Dio: la consapevolezza di questa coscienza passa anche attraverso la presenza delle PcD nella Chiesa e nel mondo.
Il rapporto tra santità, vocazione, discepolato e PcD è un tema significativo e per certi aspetti problematico: è possibile per loro, specie per quelle con disabilità intellettiva grave, rispondere con piena libertà e responsabilità all’appello che Dio rivolge a ogni uomo e donna di buona volontà? Come possono essere pure loro autentici “pellegrini di speranza”, come suggerisce il Giubileo?
Per rispondere a queste domande si propone un percorso articolato in tre momenti: uno di tipo fondativo, con tre contributi (pedagogico, filosofico e biblico-teologico); uno di taglio pastorale, che si riferisce rispettivamente alla formazione dei catechisti che operano nel mondo della disabilità, al ruolo dei presbiteri nei percorsi formativi e alla proposta del pellegrinaggio e degli esercizi spirituali; uno di tipo esperienziale, con l’intervista ad alcune persone che testimoniano e agiscono fattivamente nelle comunità cristiane a partire dalla loro situazione di PcD e la presenta-zione della figura di S. Margherita della Metola o di Città di Castello, prima santa disabile grave canonizzata.
La prima sezione vede, anzitutto, il contributo di Roberto Franchini, La voca-zione delle Persone con Disabilità: per una comunità generativa. Il pedagogista, nel considerare ancora una volta l’aporia tra l’aspirazione all’autodeterminazione della PcD e il progetto di vita che la comunità gli propone, individua nella spiritualità – la dimensione più intima dell’esistenza umana – la chiave per il superamento dell’impasse. Rispondendo alla chiamata vocazionale, la PcD realizza compiutamente sé stessa, e tutto ciò si traduce in ruoli e prospettive di operosità che la comunità deve favorire. In tal senso, viene presentato l’itinerario metodologico del PFTW (Putting Faith to Work) che suggerisce dei passi concreti per la “messa in opera” della spiritualità.
Ogni persona è chiamata da Dio a fare della propria vita un “capolavoro”. Il contributo di Cristiano Ciferri, Capolavori di Felicità… anche se non è facile, propone una riflessione filosofica sulla vocazione alla felicità per le PcD. Nel confronto con alcuni esponenti del Personalismo, a partire dal principio della “responsorialità”, viene enfatizzata l’importanza dell’impegno personale verso la “autorealizzazione”. Nell’economia del discorso, due riflessioni risultano particolarmente stimolanti: quella che si riferisce alla “libertà per” e la metafora del “disegno di vita”, preferita a quella di “progetto”. L’autore evidenzia la funzione regolativa della “speranza” e l’importanza di ripartire proprio dalla “fragilità” per raggiungere una pienezza di vita.
L’argomento della disabilità nella Bibbia è ampiamente esplorato; viene indagato, in questo caso, in rapporto alla speranza, che è il tema proprio del Giubileo. Giuseppe De Virgilio, nel suo: La disabilità nella Sacra Scrittura e l’esercizio della speranza. Aspetti biblico-teologici, articola la riflessione in tre momenti: presenta dapprima la concezione biblica della disabilità e la sua relazione con la malattia in generale per soffermarsi, poi, su alcuni elementi peculiari dell’Antico e del Nuovo Testa-mento. Traspare così una “teologia della debolezza”, non solo condizione antropologica della persona umana ma anche elemento qualificante l’identità della Chiesa che lungo la storia condivide la fragilità dell’umanità continuando a “confessare la speranza” (cf. Eb 10,23).
La seconda sezione, di indole pastorale, inizia con l’intervento di Veronica Amata Donatello, Formazione degli accompagnatori al discepolato per le Persone con Disabilità. Si constata la scarsa attenzione alla formazione di queste importanti figure pastorali e, sulla scia della riforma ministeriale promossa da papa Francesco, viene prospettato un ripensamento della disabilità non come barriera ma come profetico luogo teologico e pastorale. Una Chiesa autenticamente sinodale sa riconoscere nelle PcD non solo dei destinatari ma dei protagonisti nell’annuncio del Vangelo. Vengono quindi indicati dei passi concreti per approntare dei percorsi formativi realmente inclusivi.
Segue il contributo di Lawrence Sutton e Philip Kanfush, In pursuit of Master-piece: The role of the priest in helping those with developmental disabilities reach their potential as God defined it. Alla luce della loro esperienza di formatori del clero, i due autori presentano l’attuale prassi formativa in ambito statunitense, evidenziano alcuni elementi di criticità e suggeriscono dei correttivi atti a migliorare la qualità delle pro-poste formative. È un compito molto importante perché dai presbiteri – richiamati qui ad assumere come modello gli interventi inclusivi di Gesù – dipende ancora in gran parte la costituzione e crescita di comunità accoglienti e inclusive.
Nelle comunità cristiane si va sempre più diffondendo la pratica degli esercizi spirituali e ha ripreso forza il fenomeno del pellegrinaggio religioso. A queste manifestazioni religiose sono dedicati, gli altri due contributi. Il primo, di Samuele Ferrari, Siamo tutti pellegrini di Speranza. Le Persone con Disabilità e il pellegrinaggio, descrive i tratti peculiari del pellegrinaggio come esperienza liminale e come uno degli elementi fondamentali della vita cristiana. Si sottolineano i punti di contatto tra le dinamiche del pellegrino e quelle vissute dalle PcD e si offrono indicazioni e attenzioni pastorali da non trascurare per consentire alle PcD di essere, insieme alla comunità tutt’intera, a pieno titolo “pellegrini di speranza”.
Quello successivo, di Annalisa Caputo, titola provocatoriamente: Esercizi spirituali per Persone con Disabilità intellettiva? La studiosa, che vanta una riconosciuta competenza sul tema, attraverso un percorso che prende le mosse da s. Ignazio di Loyola e passa per l’analisi della mediazione profetica realizzata da Luigi Novarese, descrive le metodologie odierne applicate nel “Gruppo Attivo” del Centro Volontari della Sofferenza, fornendo così una risposta affermativa all’interrogativo iniziale.
La terza tappa del percorso vede, anzitutto, la raccolta delle testimonianze di alcune PcD intervistate da Isabella Tarsi, “Chiamati a diventare capolavori”: alcune testimonianze. Le risposte date fanno capire con chiarezza quanto ci sia di bello, di fresco, di entusiasmante, di valido nell’impegno di servizio alla propria comunità, in risposta a una specifica vocazione, di persone che sperimentano diverse forme di disabilità. Chiude poi il fascicolo l’excursus storico di Fabio Bricca, Santa Margherita della Metola o di Città di Castello. Tra le figure dei santi proposti come modello di vita ai battezzati fino a poco tempo fa non erano presenti le PcD, ma semplicemente persone con accentuata fragilità. Recentemente, invece, la canonizzazione della prima PcD grave colma questa lacuna. Nello studio vengono presentati gli elementi più salienti della sua biografia, ancora poco conosciuta.
L’Istituto di Catechetica (=ICa) ha sempre considerato un compito inderogabile l’aggiornamento sistematico della sua proposta formativa accademica, adeguandola ai progressi della ricerca scientifica – segnatamente nell’ambito catechetico – e alle provocazioni che il contesto culturale presenta di continuo. La storia dell’ICa, tratteggiata nei fascicoli di “Catechetica ed Educazione” pubblicati in occasione del suo settantesimo di vita, dà conferma della veridicità di quanto appena affermato.
Il seminario, le cui relazioni sono riportate in questa seconda sezione della rivista, prende in esame l’ultimo periodo di esistenza dell’ICa. Chiusa l’esperienza di collaborazione con l’Istituto di Teologia Pastorale nel Dipartimento di Pastorale giovanile e Catechetica (1981-2016) e ritornati nell’ambito della Facoltà di Scienze dell’Educazione, i membri dell’ICa sentono l’esigenza di fissare per iscritto gli elementi di tipo epistemologico e strutturali che rendono originale l’ICa nel panorama catechetico internazionale per farli diventare così il punto di riferimento per organizzare la proposta formativa verso gli studenti che avrebbero frequentato l’università negli anni a seguire. Nasce così “Studiare catechetica oggi.
La proposta dell’Università Pontificia Salesiana” (2018). A questo testo si riferisce il contributo di Ubaldo Montisci, Studiare catechetica oggi. Un volume “interfaccia” per l’ICa. L’autore presenta il contesto in cui è stato ideato e realizzato il progetto, descrive la struttura del libro e si sofferma sulla descrizione delle peculiarità della proposta formativa, mettendone in luce punti di forza e criticità.
Nello sforzo di qualificare sempre più la proposta formativa, a seguito della recente pandemia che ha introdotto modifiche sostanziali nel modo di vivere e di credere di tante persone e della pubblicazione del “Direttorio per la catechesi” (2020), tra il 2022 e il 2024 l’ICa realizza un’indagine conoscitiva a livello mondiale tra i suoi Exallievi a partire dal 2000. Su questa esperienza, puntualmente riportata nel secondo fascicolo di “Catechetica ed Educazione” dello scorso anno, si concentra l’intervento di Benny Joseph: Il curriculum di catechetica come “laboratorio di dialogo”, a partire dalla Ricerca “La competenza riconsiderata (2000-2020). L’autore propone delle piste di riflessione ed evidenzia attenzioni specifiche, privilegiando la prospettiva del “laboratorio di dialogo”, giungendo a proporre il “paradigma del dialogo” quale orientamento per lo studio della catechetica e per il design del curricolo.
A queste prime due relazioni, seguono quelle di tre discussant, cui viene chiesta un’ulteriore riflessione in riferimento ai tre curricoli offerti attualmente dall’ICa: Catechetica, Catechetica e comunicazione ed Educazione religiosa.
Michele Roselli, nel suo Il percorso di Catechetica. Sollecitazioni per i curricula e per il dibattito, offre una riflessione in generale sul rapporto tra catechetica e catechesi e ne esamina le modifiche indotte dal contesto culturale attuale, che genera una “metamorfosi del cristianesimo”; quindi si sofferma sul curricolo proposto dall’ICa, sottolineandone elementi qualificanti e altri bisognosi di attenzione; chiude con alcune stimolanti provocazioni e suggerimenti utili per delle eventuali modifiche migliorative.
Segue il contributo di Vincenzo Corrado, Catechetica e comunicazione. Appunti per un orizzonte di senso. L’autore individua nella consapevolezza del cambio di paradigma culturale in atto e nell’accettazione del principio della realtà e del primato del tempo sullo spazio, gli elementi capaci di imprimere un nuovo dinamismo al percorso di Catechetica e comunicazione. Termina con alcune significative indicazioni specifiche per la riqualificazione del curricolo.
Chiude la serie, la relazione di Lorenzo Voltolin, Rinnovare il percorso di Educazione Religiosa nel contesto culturale. Il denso intervento mette in luce la complessità della tematica. Per rispondere in maniera efficace alla crescente pluralità culturale e religiosa, l’insegnante di religione dovrà maturare la capacità di ascolto delle domande provenienti dagli allievi e, insieme, l’attenzione ai contenuti teologici necessari per organizzare un curricolo formativo adeguato. Per quanto riguarda questi ultimi, è soprattutto sul “come” comunicarli che si dovrà lavorare. La proposta formativa dell’ICa non potrà prescindere dal prendere seriamente in considerazione la didattica interculturale, le tecnologie digitali e l’approccio ermeneutico-esistenziale alla materia.
I membri dell’Istituto di Catechetica
catechetica@unisal.it
ACCEDI ALLA RIVISTA ONLINE nella sezione “CATECHETICA ED EDUCAZIONE”
ALLEGATO: