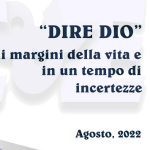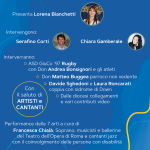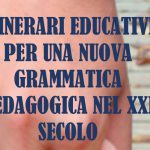Che cosa ha imparato la Chiesa dalla pandemia? O, meglio: abbiamo appreso qualcosa
nel periodo del lockdown?
La seconda puntata del convegno “La Chiesa alla prova della pandemia” tenutasi nel monastero di Camaldoli dal 24 al 28 agosto 2020 non ha voluto eludere tale interrogativo scomodo, anche rileggendo esperienze pastorali, provvedimenti assunti e
fecondità inespresse (per la prima parte si veda SettimanaNews).
Le giornate – dedicate rispettivamente a tematiche ecclesiologiche, liturgiche e comunicative – hanno evidenziato l’importanza di una riflessione critica sul momento pandemico, che ha fatto emergere problematiche e potenzialità che già c’erano, come ha premesso il monaco camaldolese Matteo Ferrari, organizzatore dell’incontro, introdotto dal priore Alessandro Barban e dal vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Riccardo Fontana.
Chiesa
Nella sua prolusione, Giuseppe Angelini – già preside della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale – ha segnalato come in questo periodo si sia riproposta la frattura tra coscienza e società, espressa soprattutto dalla cancellazione dell’interrogativo morale in ambito pubblico, sostituito da soluzioni tecnico-scientifiche che segnerebbero il trionfo di una mentalità clinico-terapeutica.
La presenza della Chiesa, anziché dar voce alle coscienze personali, è stata declinata «in forme molto ripetitive, litaniche, sostanzialmente gregarie rispetto al dibattito pubblico» come se «non avesse nulla di proprio da dire in proposito»; sarebbe invece di estrema importanza una mediazione nelle profondità culturali della società odierna per trasformare la pandemia in occasione di evangelizzazione.
L’ecclesiologo Dario Vitali (Pontificia Università Gregoriana) ha scelto la categoria paolina di “corpo di Cristo” per indagare gli effetti della pandemia sullo stato di salute della Chiesa; un corpo già «debole, debilitato, sfibrato» ha visto ulteriormente compromesse le proprie capacità di rigenerarsi: come un paziente anziano, ora necessita di una lunga convalescenza, nutrendosi di soluzioni condivise che riattivino le connessioni interne e di consapevolezza di ciò che ha diviso il corpo ecclesiale.
È intervenuto anche il pastore Fulvio Ferrario, decano della Facoltà valdese di teologia, a proposito dell’irrilevanza sistemica della Chiesa. Essa, più che inseguire i criteri di legittimazione della sua presenza sociale sul piano laico che la valorizzano solamente in quanto erogatrice di servizi sociali di prima necessità, potrebbe ripensarsi nella categoria del “non necessario”: non in quanto superfluo, bensì nell’ordine del “più che
necessario”, della gratuità che non può essere imposta ma solamente riconosciuta liberamente.
Di fronte alla pandemia, cattolici romani e protestanti hanno fatto ricorso alle rispettive “specialità della casa”: da un lato, la pietà sacramentale senza accesso diretto ai sacramenti, dall’altro, la predicazione della Parola con eventi domenicali su piattaforme digitali. Tuttavia proprio in questa fase si sono posti nuovi interrogativi: in campo riformato inusuali nostalgie del sacramento sino a proposte di consacrare via webcam, in quello cattolico la consapevolezza che il Vangelo può giungere anche attraverso molteplici canali, pure telematici.
Nella mia relazione ho mostrato la convergenza dei sondaggi degli ultimi mesi – uno dei quali, condotto dall’associazione “Nipoti di Maritain” da me diretta e già presentato in sintesi anche su SettimanaNews – su un aumento complessivo di un terzo, tra gennaio e aprile, delle pratiche religiose dei cattolici italiani. Non solamente quindi “messe in streaming” – le cui riprese audio/video necessitano di inedite attenzioni di estetica liturgica – e che comunque persino sommate insieme non riescono a raggiungere gli ascolti di papa Francesco, ma pure meditazioni del vangelo quotidiano e occasioni di riflessione, soprattutto da parte dei più giovani, sul senso della propria vita.
Inoltre, si è notata la divergenza di letture proprio sulle dirette social delle celebrazioni dei presbiteri: criticate come manie di protagonismo clericale da parte di altri preti che non hanno voluto farle, invece generalmente sono state molto apprezzate dal fedele medio che in esse ha trovato un’espressione di vicinanza e di cura pastorale, dato dal quale partire prima di considerazioni di altro tipo.
A partire da questa constatazione di teologia fondamentale – è vero comunque, come aveva studiato Dario Vitali, che il sensus fidei è in larga parte dipendente dall’impostazione ricevuta – è possibile poi educare il cammino dei fedeli ad una consapevolezza più matura della realtà ecclesiale e sacramentale.
Liturgia
Ma tale apprezzamento laicale per le “messe in streaming” può anche denotare, come ha rilevato nella seconda giornata la liturgista sr. Elena Massimi, docente presso gli istituti “Auxilium” di Roma e “S. Giustina” di Padova, la fatica della recezione dell’ecclesiologia del concilio Vaticano II e l’incomprensione dello statuto stesso della
liturgia, opera di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa tutta che fa l’eucaristia, la quale a sua volta costituisce la Chiesa.
L’intervento ha sottolineato alcune criticità dei decreti liturgici adottati in tempo di Covid-19, maggiormente preoccupati per la validità canonica dei sacramenti, e si è interrogata sulla rinnovata attualità di alcune pratiche discutibili come le indulgenze, le messe celebrate dal solo sacerdote e la cosiddetta “comunione spirituale”, nate in ben altri contesti; ad ogni modo si auspica che l’interesse significativo che ha investito recentemente la liturgia non venga sprecato.
Lorenzo Voltolin, presbitero della diocesi di Padova, è partito da un interrogativo: che tipo di comunità si costituisce quando i corpi non possono incontrarsi? Nel suo paradigma interpretativo i new media sono un’estensione del nostro corpo e come esso iniziano a funzionare, attivando anche dal punto di vista chimico gli stessi meccanismi percettivi inter-corporei, con la pompa sodio-potassio e i successivi effetti sulla corteccia cerebrale.
Inoltre funzionano sul corpo e permettono esperienze significative intra-corporee, nella realtà virtuale; sebbene questa non vada confusa con la realtà stessa, si tratta di un ulteriore spazio esistenziale, una realtà a pieno titolo fondata sui sensi corporei, e non sull’immaginazione.
Ciò che permette di verificarne l’autenticità è il collegamento con il proprio referente fisico: in altre parole, se vi è un legame biologicamente reale – per esempio quello tra un parroco e la propria comunità – tale percezione performativa può creare partecipazione comunitaria; se invece non vi è alcun nesso con una realtà conosciuta
fisicamente la celebrazione si fa spettacolo.
Morena Baldacci, responsabile della pastorale battesimale della diocesi di Torino, ha parlato di preghiera “in casa” (anziché di preghiera “in famiglia”, per poter includere un maggiore numero di esperienze anche di single e di conviventi) portando esempi, più che di sussidi, di pratiche concrete. Tali liturgie domestiche hanno permesso a una pur sempre esigua minoranza di fedeli già assidui di riscoprire gesti e parole del quotidiano; non un mero “trasloco” dalle chiese alle case, ma piuttosto una piccolezza scelta in cui sperimentare una pluralità di servizi e di ministeri.
In seguito, è stata proposta l’esperienza della Tenda della Parola animata dal parroco parmense Guido Pasini che, in tempo di pandemia, ha inviato a una mailing list un breve sussidio con tracce audio lette e cantate per pregare il vangelo domenicale.
Linguaggi
Nel terzo giorno dedicato alla comunicazione sono intervenuti due presbiteri della diocesi di Bergamo.
In primis Manuel Belli, che ha rilevato gli sforzi da parte delle Chiese per apprendere come stare su un web abitato da nativi digitali che hanno sempre vissuto in tempo di crisi e che possono essere sensibili, più che a spiegazioni causali o a illusori ottimismi, a una pastorale della prossimità al singolo individuo.
Giuliano Zanchi è entrato nel rapporto tra fede e arte, anche a proposito della riproducibilità tecnica dei sacramenti nell’“infosfera” in cui si è inevitabilmente immersi, dell’eloquenza (quasi sacramentale) di alcune immagini circolate durante la pandemia e dell’esigenza della ritualizzazione della vita, nel momento in cui si inventano nuovi riti alternativi personali perché quelli della liturgia non vengono percepiti più come espressivi, a causa di un sostanziale isolamento della Chiesa dal mondo culturale in cui avvengono novità.
Nel pomeriggio si è avuta l’occasione di ascoltare la testimonianza video del salesiano Alfio Pappalardo, autore di Un minuto per pregare sul social dei giovanissimi TikTok, oltre a quella del 23enne Emmanuele Magli (canale Religione 2.0 su YouTube) docente di IRC a Bologna e di Marco Scandelli, parroco di Borgo Maggiore a San Marino, che quotidianamente offre un video di #2minutiDiVangelo.
Responsabilità e vulnerabilità
La mattinata conclusiva, dopo l’esperienza del “pellegrino rosso” Matteo Bergamelli – che con entusiasmo, creatività e ironia testimonia la sua fede soprattutto su instagram – ha visto l’intervento del filosofo Stefano Biancu, docente alla LUMSA e vicepresidente del MEIC.
In quest’ultima relazione si sono rivissute le domande della filosofia morale in tempo di pandemia: abbiamo una conoscenza più limitata di quanto pensassimo anche delle realtà fisiche, non tutto è sotto il nostro controllo, eppure abbiamo una certa responsabilità – rispondere a qualcuno di qualcosa – su ciò che invece dipende da noi,
senza temere quella vulnerabilità che, esponendoci al rischio di poter essere feriti dagli altri, consente di accedere a esperienze più grandi.
Entra così in gioco una dinamica di beni “supererogatori”, cioè non esigibili (come il perdono, l’amore, l’accoglienza) eppure vissuti con la coscienza che siano tali: è il “massimo necessario”, per esempio, del personale sanitario che ha compiuto come atto dovuto il proprio servizio, definito invece da altri nei termini di “eroismo”.
Insomma, dopo la puntata di giugno più “a caldo”, anche con quella di agosto questo convegno ha voluto, su temi più specifici, offrire un aiuto per comprendere l’attuale delicata fase ecclesiale, senza offrire alcuna ricetta preordinata, ma ripensando alle ricchezze e alle debolezze che questo tempo ha fatto scoprire, al fine di investire energie e lavorare con pazienza sui punti nodali affinché i frutti vengano da cammini condivisi, e non da scorciatoie.
http://www.settimananews.it/chiesa/la-chiesa-linguaggi-della-pandemia/