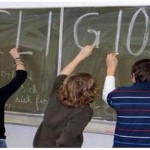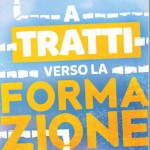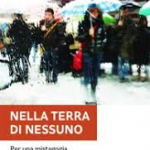“Far partire atteggiamenti nuovi, far maturare dei processi“
Atti 20,7-12
7 Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo conversava con loro; e poiché doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione fino a mezzanotte. 8 C’era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore, dove eravamo riuniti; 9 un ragazzo chiamato Eutico, che stava seduto sulla finestra, fu preso da un sonno profondo mentre Paolo continuava a conversare e, sopraffatto dal sonno, cadde dal terzo piano e venne raccolto morto. 10 Paolo allora scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi turbate; è ancora in vita!». 11 Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino all’alba, partì. 12 Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo, e si sentirono molto consolati.
E’ bello rileggere insieme questo brano degli Atti, sentire come esso illumini quanto abbiamo vissuto nel Convegno di giugno scorso!
L’episodio avviene a Troade, nel “primo giorno della settimana”, quando la comunità si riunisce “nella stanza al piano superiore” per “spezzare il pane” e ascoltare la Parola di Dio annunciata da Paolo. E’ una comunità degli inizi, piccola e piena di entusiasmo, capace di ascoltare la Parola per tutta la notte, finché non spunta l’alba, approfittando fino all’ultimo della presenza dell’Apostolo. Tutta la stanza è illuminata da molte lampade: è un bel simbolo della luce della Parola e della fede di tante persone che si lascia illuminare da essa. Si direbbe che questa comunità è una “vergine saggia”: ha con sé l’olio, ha la lampada accesa. E’ pronta alla partenza dell’Apostolo e a continuare senza di lui il suo cammino
Non si è accorta però di un particolare. I ritmi di questa comunità, la sua fede luminosa e adulta, non vengono retti dal giovane Eutico. Egli sta alla finestra e, mentre Paolo continua senza sosta la sua omelia, preso da profonda sonnolenza, precipita giù. E’ un’immagine vera di quello che stiamo vivendo oggi: mentre la nostra comunità cristiana, in questa ricchissima e faticosa stagione postconciliare, riscopre con gioia la centralità dell’incontro con il Risorto, dell’ascolto della Parola di Dio, la bellezza del celebrare insieme spezzando il pane eucaristico nella fede e nella carità fraterna, proprio la componente giovanile delle nostre comunità si è lentamente spostata alla finestra, sviluppando un senso di estraneità nei confronti della comunità cristiana e si è addormentata. Forse, come Paolo, abbiamo parlato troppo di cose che poco avevano a che fare con la vita del giovane Eutico, per cui non lo abbiamo aiutato a percepire che la luce era anche per lui; forse ci è mancata l’empatia e non ci siamo accorti di quello che Eutico provava, di quanto la sua giornata, magari vissuta in solitudine, fosse stata pesante e faticosa; forse non siamo stati bravi ad accorgerci che anche Eutico aveva qualcosa da dire, delle domande da fare, che lo avrebbero aiutato ad entrare nel Mistero “a modo suo”, a personalizzare l’annuncio che ascoltava (“Dio a modo mio” è il titolo di un lavoro recente sui giovani e la fede in Italia); come al solito, Dio vuole che la sua comunità si converta e questo non avviene finché non mettiamo al centro della nostra attenzione i piccoli e i poveri…
Così Eutico, tra lo sconcerto di tutti, cade giù e muore. E’ con tristezza enorme che vediamo tanti giovani delle nostre città, proprio perché nei loro percorsi di crescita ormai il vangelo è per lo più assente, appiattirsi sulla mediocrità, perdere la capacità di sognare, rinchiudersi nell’individualismo, rimanere soli e senza parole rispetto ai grandi drammi della vita. Senza il Signore la vita dell’uomo non è più la stessa: si può essere giovani ed essere “vecchi dentro”, forse persino “morti dentro”.
Per questo il gesto di Paolo è esattamente quello che noi, comunità cristiana, siamo chiamati ad attualizzare: lasciare tutte le altre occupazioni, scendere al piano terra, lì dove si trova il giovane Eutico esanime, buttarci addosso a lui per abbracciarlo e ridonargli la vita dello Spirito. Il verbo usato dagli Atti e tradotto con “si gettò su di lui” (epèpesen ) è lo stesso che Luca utilizza anche nel vangelo per dire che il Padre della parabola “si gettò al collo” (Lc 15,20) del figlio minore, per baciarlo e alitare così su di lui la sua stessa vita divina. Le viscere di misericordia del Padre, il suo utero materno, si commuovono, e così anche quelle di Paolo di fronte alla morte del giovane. La misericordia si esprime nel gesto di gettarsi addosso al corpo del ragazzo, come Elia sul figlio della vedova, per ridonare la vita, il respiro, la dignità filiale, e aiutarlo a rialzarsi in piedi. Ogni nostro sforzo per la pastorale giovanile non potrà che partire da questa imitazione dell’utero materno del Padre, da questa riscoperta della misericordia che Dio ha verso di noi e che ci chiama ad esercitare verso tutti. Anche verso i genitori il nostro obiettivo è il medesimo: aiutarli a riscoprire la loro vocazione paterna e materna, la bellezza di un amore di donazione che li rende simili a Dio, la luminosità del gesto di chi muore un po’ perché l’altro, il figlio, possa avere vita. Vogliamo aiutare i papà e le mamme a riscoprire che la fede in Gesù e la relazione con Lui sostiene e dà forma anche al proprio modo di essere genitori.
Come Paolo anche noi possiamo esclamare: “Non vi turbate: la sua anima è in lui!” (tradotto dalla traduzione CEI con : “è ancora in vita”). Si, c’è nel cuore di ognuno dei ragazzi di questa città un desiderio profondo di Dio, un’anima che esprime questo desiderio in mille maniere diverse: voglia di raccontarsi, di sperimentare, di provare “la vertigine”; bisogno profondo di stare con gli altri, di superare l’isolamento, di trovare accoglienza e punti di riferimento tra gli adulti; rifiuto dei formalismi, delle relazioni non autentiche, degli spazi rigidi e non vitali, perché si è alla ricerca di un’appartenenza, di un nuovo modo di stare al mondo, di pensarsi, di agire. Una nostalgia di Dio trapela persino in molti di coloro che dicono di non credere in nessun tipo di religione o di filosofia (quasi la metà dei nostri ragazzi): più che di un rifiuto di Dio si tratta di una presa di distanza da un certo modo di vivere la vita cristiana appreso nelle stanze del catechismo parrocchiale e che ora, a questi adolescenti, non dice più niente perché non c’entra quasi nulla con quello che vivono. (Bichi-Bignardi, Dio a modo mio, p.176). Questo ci interpella profondamente: “la sua anima è ancora in lui”. Quali varchi e quali sentieri lo Spirito Santo si sta aprendo nell’interiorità dei nostri ragazzi? Come possiamo intercettare questi varchi, questi movimenti dello Spirito, e metterli in contatto con il Vangelo di Gesù e la vita della comunità cristiana? Come lo Spirito sta preparando nel cuore dei ragazzi la fede e la Chiesa del futuro? A quali conversioni ci sta chiamando, quali esodi ci vuole far compiere il Signore, attraverso le provocazioni che i ragazzi ci fanno e che siamo chiamati ad ascoltare e a prendere seriamente in considerazione?
Si, perché c’è un rischio reale davanti a noi: che non cogliamo fino in fondo la svolta epocale che stiamo vivendo. il Signore ci sta parlando attraverso la voce di questi giovani, nostri figli: trasmettere a loro la fede richiede un ripensamento profondo non solo delle iniziative di pastorale giovanile, ma del nostro essere Chiesa. Prendiamo per slogan o frasi fatte certe espressioni del nostro Vescovo, Papa Francesco, quando parla di un “improrogabile rinnovamento ecclesiale”: “Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione” (EG 27). Sono passati ormai tanti anni da quando il Magistero dei nostri Papi ci ha richiamati alla necessità di una riforma ecclesiale che, recependo ancora più pienamente il Concilio Vaticano II, segni un’autentica svolta missionaria “che non può lasciare le cose come stanno”(EG 25). Il vero rischio è che ad addormentarsi non sia Eutico, ma che sia tutta la comunità cristiana! Non possiamo rimanere a guardare sbigottiti Eutico che cade nel vuoto: bisogna fare come Paolo, che si precipita ad abbracciarlo e a ridare vita alla sua anima.
La Chiesa è “una madre dal cuore aperto” ( primo capitolo di EG): è discepola, figlia generata dalla Parola, e missionaria, madre che genera nuovi figli alla fede (comunità cristiana che evangelizza e si lascia evangelizzare) incarnandosi nei limiti umani e accompagnando il cammino concreto delle persone. Come in ogni sua epoca la Chiesa si rinnova grazie a due “movimenti” profondamente spirituali e tra loro connessi: se ritorna alle sorgenti della Parola e se si lascia provocare dalla carne degli uomini che è chiamata a servire. Anche perché lei stessa è impastata di quella carne e non può far finta di non esserlo! Bloccare la fecondità anche di uno solo dei due movimenti significa realizzare una riforma a metà della vita della Chiesa. Mettiamoci in ascolto della Parola, consegnata nella Scrittura e nella Tradizione ecclesiale, e ascoltiamo la voce dello Spirito che parla nel cuore degli uomini e nella storia umana, operando comunitariamente un sapiente discernimento dei segni dei tempi. E’ questo il cammino che ci aspetta, ed è un’avventura affascinante!
Con questo intervento di oggi non intendo far altro che rilanciare le parole del Papa e proporre alcune tracce per i cammini delle comunità parrocchiali e delle diverse realtà ecclesiali della diocesi di Roma. Fin dall’inizio voglio precisare che la priorità non va data alle “cose da fare”. Per far circolare operativamente nuove idee sono utili esperienze come quella dei laboratori di giugno, perché nei gruppi sono state condivise molte proposte, raccontate molte iniziative ben riuscite. Gli incontri di prefettura, le riunioni di catechisti e animatori di parrocchie diverse, sono occasioni preziose! Ciò che è più importante (e ben più difficile) è maturare atteggiamenti nuovi e far partire dei processi. E’ anche la preoccupazione del nostro Vescovo, Papa Francesco: sono le nostre malattie spirituali quelle che frenano la circolazione della vita dello Spirito, che impediscono alla comunità cristiana di incontrare in maniera feconda i giovani e le loro famiglie; le malattie ci inducono ad avere lo sguardo corto di chi non intuisce le direzioni di marcia da prendere e si appiattisce quindi sul “già fatto e quindi sicuro” quando ormai da tempo “sicuro non è”!
Vi dico allora quello che mi sembra essenziale fare, il prossimo anno pastorale: ogni comunità parrocchiale, ogni realtà ecclesiale, rifletta con franchezza su quale sia la sua malattia spirituale. In occasione di un’assemblea comunitaria, con il consiglio pastorale, con l’equipe dei catechisti, si chieda: in cosa ci siamo ammalati? Cosa frena in noi il dinamismo evangelizzatore? Cosa ci impedisce di essere una madre dal cuore aperto, capace di accogliere e di uscire? Perché i ragazzi che abbiamo accompagnato nell’iniziazione cristiana prendono le distanze dalla nostra comunità (ovviamente, per quello che dipende da noi…)? Il secondo capitolo di EG, “la crisi dell’impegno comunitario”, nella parte che riguarda “le tentazioni degli operatori pastorali” (EG 76-101) ci offrirà il materiale di base per riflettere. Gli uffici diocesani prepareranno delle schede per aiutare questa verifica comunitaria. Attenzione: non è un’operazione semplice individuare la malattia spirituale della nostra comunità! Non va fatta frettolosamente, perché richiede profonda libertà interiore e un discernimento sapiente illuminato dallo Spirito.
1)
Permettete anche a me, ora, di sottolineare tre malattie spirituali (mi ispirerò all’ultimo capitolo di EG: “evangelizzatori con Spirito”) che mi sembrano particolarmente pericolose per la nostra vita ecclesiale. Nella seconda parte di questa relazione proporrò alcune riflessioni sulla pastorale giovanile e sul dialogo e la collaborazione con i genitori, con lo scopo di avviare processi attraverso la realizzazione di alcune iniziative.
a. La comunità cristiana è essenzialmente comunità di fede, che vive della gioia dell’incontro con il Risorto (EG 264-267), che si nutre della sua Parola e dell’amicizia con Lui, che percepisce la bellezza e la responsabilità di essere il suo corpo visibile nel mondo per l’edificazione del regno. Stringiamoci a Cristo e che sia la conoscenza e la sequela di lui il cuore di ogni programma pastorale! Questo vuol dire che la comunità non si costruisce sull’efficienza della sua macchina organizzativa, non si riduce a spazio aggregativo per bambini e per anziani, soprattutto non si appiattisce su logiche mondane di vario tipo: l’autocelebrazione narcisistica, la fedeltà sterile e ideologica a riti e consuetudini, la difesa di uno spazio protetto e rassicurante, al riparo dai problemi del mondo… Questa non è senz’altro la Chiesa di Gesù il Signore! Diciamolo con il linguaggio di Papa Francesco: basta pelagianesimi! Questo significa: basta cammini comunitari nei quali pretendiamo di costruire la Chiesa da soli secondo logiche tutte umane. La Chiesa diventa una donna infeconda quando perde il suo sguardo contemplativo e smette di compiere una lettura realmente spirituale, di fede, di quello che lei vive e di quello che vivono gli uomini del suo tempo. Dobbiamo credere alla logica delle beatitudini: quanto più la comunità cristiana si fa piccola, povera, mite, quanto più si concentra sulle relazioni (una famiglia!) e non sulle strutture, tanto più diventa credibile e lascia passare la luce dello Spirito. Una comunità che non si converte continuamente al Signore rinnovando il discepolato è una comunità che non va molto lontano: alla fine i suoi membri implodono perché ognuno si attaccherà al suo ruolo o alle sue idee. Fin dall’inizio, a partire dall’iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi fino ai gruppi per anziani, bisogna far sì che il Vangelo di Gesù sia il cuore di ogni cammino cristiano, con le modalità adatte a ciascuna età. Questo vale ovviamente anche per gli adolescenti e i giovani: non bisogna aspettare che abbiano un’età diversa per narrare loro la Parola di Dio, ma è necessario coniugare il Vangelo con le loro vite. Ascoltando con profondità i loro vissuti, il modo in cui si interrogano e percepiscono Dio nelle pieghe della loro esistenza, sarà più facile comprendere che il Signore sta già andando loro incontro, quali parole sta loro rivolgendo, attraverso quali esperienze li vuole aiutare a crescere… Qualcosa di simile va detto anche per i genitori dei ragazzi: al cuore di ciò che proponiamo per loro c’è l’annuncio rinnovato del Vangelo, magari sotto l’angolatura ricchissima di ciò che significa essere padri e madri nella Scrittura e nella spiritualità cristiana; sarebbe davvero riduttivo se ci si fermasse a qualche, pur utile, consiglio sulla relazione genitoriale!
b. Oltre a mettere Cristo al centro, le comunità sono invitate a riscoprire “il piacere di essere popolo” (EG 268-274). L’insistenza del Papa è qui estremamente salutare, ci fa bene, perché ci ricorda che in Cristo siamo legati gli uni agli altri e che se ci dividiamo chi ci rimette siamo tutti. Separarci dagli altri, che siano i fratelli della comunità cristiana o gli abitanti del nostro stesso quartiere, ci fa ammalare. E’ dalla contemplazione dell’incarnazione che impariamo a far nostro uno stile diverso, quello con cui Gesù si avvicinava alle persone, condividendone la vita con simpatia autentica, entrando in relazione in profondità, facendosi carico dei dolori e delle fatiche degli altri. E’ quello che il Papa chiama rivoluzione della tenerezza: un modo pienamente evangelico di vivere le relazioni. Basta quindi individualismi e affermazioni identitarie giocate “contro qualcuno”! La storia delle nostre parrocchie e delle nostre comunità ecclesiali, in questi anni, ha su questo punto luci e ombre. Quanto cammino fatto insieme, quanta ricchezza di carismi messa in circolazione, come sono state belle alcune iniziative che ci hanno unito (penso al Giubileo e alla missione cittadina, alla Veglia di Pentecoste celebrata insieme a san Pietro, e a tante altre …). Non a caso ho scelto come simbolo del mio ministero episcopale il melograno, perché rappresenta il servizio alla comunione ecclesiale: i vari acini tenuti insieme dal Signore… Dall’altra parte non sono poche le situazioni in cui si è preferito arroccarsi, difendersi; si è assolutizzata un’esperienza ecclesiale a danno delle altre, ci si è guardati con diffidenza magari per concludere che la coabitazione è impossibile. E’ significativa, ad esempio, la difficoltà a lavorare insieme in prefettura: indica non tanto incapacità organizzativa o mancanza di tempo, ma forse una diffusa malattia spirituale. Quanto al rapporto con chi vive nei nostri quartieri e con cui vorremmo condividere il Vangelo e costruire un dialogo e una collaborazione positiva, ricordiamo i primi due dei tre atteggiamenti di fondo a cui Papa Francesco ci ha richiamati nel Convegno del 2016: togliersi i sandali davanti alle vite degli altri, perché sono luoghi santi; non rinchiudersi nei ghetti delle nostre presunte perfezioni, disprezzando e condannando senza appello le persone. Sul terzo atteggiamento ritorneremo tra poco
c. Una terza considerazione che vorrei condividere con voi riguarda la malattia spirituale di quelle comunità ormai rinunciatarie rispetto al compito evangelizzatore, inteso sia come annunzio del Vangelo sia come collaborazione alla trasformazione del mondo nel regno di Dio. Quante comunità introverse, ripiegate su se stesse, che hanno dimenticato di essere lievito inserito nella storia umana e guardano le vicende del mondo dal balcone delle proprie sicurezze! Con il tempo si inaridiscono e finiscono per dire o fare le cose di sempre: un po’ di catechesi dei bambini, magari qualche pratica devozionale, ma non testimoniano più nulla agli uomini della nostra città! La malattia consiste in fondo nella mancanza di fede nella Pasqua, nel Signore Risorto che agisce anche oggi per mezzo dello Spirito nel mondo e nei cuori delle persone. Basta pessimismo sterile! Non è possibile per la comunità cristiana dimenticare la storia e gli uomini. Smettere di cercare gli uomini, di coinvolgersi nelle loro gioie e speranze, tristezze angosce è una forma di ateismo pratico. Gli uomini infatti hanno già un posto nel cuore di Dio e lì li dobbiamo cercare. Nelle trame delle loro vite entusiasmanti e dolorose, coraggiose e complicate è presente e agisce lo Spirito del Risorto. Il discepolo di Gesù che vedesse negli uomini e nel mondo solo un luogo pagano, privo della presenza di Dio, pieno di tenebre e di nemici, è un discepolo che non crede nella Pasqua che agisce nella storia.
Ci verificheremo quindi sulle malattie spirituali! Anche negli incontri di settore del clero l’argomento verrà approfondito. Ogni comunità parrocchiale, in particolare, condividerà con il proprio Vescovo ausiliare le conclusioni della propria riflessione.
2)
E ora vogliamo ritornare su Eutico, simbolo dei giovani della nostra città. Il prossimo Sinodo dei Vescovi, come sapete, sarà dedicato alla riflessione sulla sfida della pastorale giovanile. L’esortazione apostolica papale che seguirà ci consegnerà contributi preziosi con cui confrontarci. Ma già da adesso (come avete compreso dalla prima parte di questa relazione) vogliamo fare il passo più importante, vogliamo metterci come Chiesa diocesana in un stato di conversione per ascoltare il grido che sale dalle esistenze dei giovani (cfr lettera del Papa che accompagna il documento preparatorio al Sinodo). Ci è sembrato che fosse necessario fin dall’inizio rivolgerci a coloro che hanno la responsabilità principale della loro crescita, i genitori. Il titolo del Convegno: “Non lasciamoli soli”, suggerisce che l’atteggiamento con cui ci avviciniamo a loro sia di collaborazione e di servizio e non, certo, di critica e condanna. Propongo qui alcuni punti che riprendono il discorso del Papa e lancio delle proposte, raccolte attraverso le relazioni dei laboratori e altri contributi che mi sono arrivati nel frattempo, con l’intento, come vi dicevo, di avviare processi.
a. Osserviamo da vicino Eutico. Lo guardiamo, come ci ha detto il Papa, in romanesco e in movimento. E’ l’amore incarnato del Figlio di Dio che ci spinge a guardare non ai giovani in astratto, quello delle pur utili indagini sociologiche, ma ai loro volti concreti, ai giovani che abitano il territorio delle nostra comunità. Una pastorale giovanile in romanesco significa che siamo chiamati ad incontrarli. Non parliamo di loro, ma con loro. Allora ne riconosceremmo il volto bellissimo e fragile, spesso fragilissimo, perché deturpato in mille modi dalla solitudine, dalle dipendenze, dall’arroganza e dalla violenza di chi usa e abusa di loro. Quando stanno insieme forse ci sembrano un “branco” pericoloso e impenetrabile; ma sappiamo che è solo una facciata, la manifestazione di una debolezza profonda. Il Signore vuole che li incontriamo. Credo che questo significhi rilanciare una pastorale coraggiosa della presenza nel territorio e del dialogo. Molti di voi hanno sottolineato il contatto che si può realizzare con gli adolescenti attraverso il mondo della scuola, soprattutto attraverso gli insegnati di religione: pur nel rispetto dei differenti ruoli e approcci (l’insegnante di religione non è un catechista) è ormai evidente a tutti noi quali enormi potenzialità siano contenute nel creare un ponte tra comunità parrocchiale e istituto scolastico. Vi invito a contattare l’ufficio Scuola, don Filippo Morlacchi, perché vi racconti le tante esperienze che sono state già realizzate a Roma, con molto frutto. Sarà anche necessario potenziare un altro canale, quello della presenza negli altri luoghi di vita dei ragazzi, specie in quelli più a rischio per loro. E’ spaventosa la situazione di devianza che vivono molti adolescenti, talvolta nell’assordante silenzio degli adulti e delle istituzioni, anche le nostre. Figli allo sbando, figli di nessuno. Anche in questo settore sono state realizzate molte significative iniziative, penso a don Giovanni Carpentieri e all’equipe che collabora con lui e ad altre realtà presenti nella nostra diocesi. Si tratta quindi di far partire un processo permanente di incontro e di ascolto, e a questo siamo tutti chiamati: renderci conto di come vive Eutico, parlare con lui, farci raccontare qualcosa di ciò che pensa riguardo a sé, alla sua vita, alle sue cadute, a Dio, alla comunità cristiana da cui ha preso le distanze… Vi invito a farlo, a leggere insieme queste narrazioni magari come consiglio pastorale, a rifletterci sopra e far arrivare le vostre riflessioni al Servizio di pastorale giovanile. L’ascolto potrebbe estendersi e comprendere anche alcuni genitori, insegnanti ed educatori, operatori dell’area minori. Gli insegnanti di religione potrebbero, d’intesa con le comunità parrocchiali presenti nel territorio della scuola, provare a raccogliere in classe le riflessioni dei ragazzi e condividerle con i presbiteri e con gli animatori degli adolescenti in incontri di prefettura. Un’iniziativa del genere non va pensata come un sondaggio, non serve per elaborare dati statistici, ma serve unicamente a voi: è un modo con cui la comunità cristiana di quel territorio incontra e si mette in ascolto dei ragazzi che vi abitano e si lascia mettere in crisi e incoraggiare dalle loro attese, dalle critiche o dagli apprezzamenti, dal modo in cui percepiscono Dio e la vita cristiana. Papa Francesco ci ha poi invitato a leggere con gli “occhiali giusti” l’età dei ragazzi, come una realtà in movimento: non è una patologia da medicalizzare ma una stagione della vita preziosa per sé e per tutta la loro famiglia. E’ preziosa anche per noi, comunità cristiana: ci spinge a ringiovanirci, ad accogliere la sfida, a vivere le trasformazioni necessarie per evangelizzare la generazione che viene
b. Il soggetto che è chiamato a convertirsi ed accogliere come una madre i ragazzi e le loro famiglie è tutta la comunità cristiana. Come vorrei che fossimo pienamente convinti di questo e ne comprendessimo fino in fondo le conseguenze! Abitualmente pensiamo che l’evangelizzazione dei giovani richieda tecniche particolari di approccio, offerte formative sofisticate, educatori professionisti o “fuochi d’artificio” pastorali, senza i quali nulla sarebbe efficace: e siccome non sono alla nostra portata, ci scoraggiamo già in partenza. Chi conosce e si fa vicino agli adolescenti sa che hanno bisogno fondamentalmente di adulti di riferimento, di comunità a cui appartenere e che esprimono verso di loro una sensibilità e un’attenzione paterna e materna, senza essere paternalistica. Si trovano bene se vivono una trama di relazioni che li faccia sentire a casa; liberi, perché sono alla ricerca di una loro identità, ma a casa. Guardate come tanti ragazzi si legano ai loro nonni, da cui li separano “anni luce” a livello di mentalità ma da cui si sentono particolarmente amati e lasciati in una sorta di spazio libero (i rimproveri li fanno i genitori!). In effetti nei processi di evangelizzazione e di catechesi dobbiamo tener conto che non tutto è mediato dai contenuti dottrinali comunicati (di cui spesso i ragazzi ricordano pochissimo!) ma che esistono altri fattori educativi importanti: l’accoglienza che fa sentire in famiglia, il senso di appartenenza che può maturare nel gruppo inserito nella comunità cristiana (qui mi piace stare!), la testimonianza ecclesiale alla Parola che suscita la fede e l’identità che scaturisce da questa appartenenza e da questa testimonianza, resa con la vita oltre che con la parola umana; da qui può nascere il giovane cristiano che si impegna nella Chiesa e nel mondo. Affinché questo processo del diventare cristiano possa funzionare, è richiesta l’attenzione di tutta la comunità cristiana (la “compagnia affidabile” di cui ci parlava Papa Benedetto): perché se un ragazzo è accolto da un catechista sorridente ma subito dopo è scansato da una sagrestana “mangia-bambini”, lo sforzo rischia di essere vanificato! In realtà ho la percezione chiara che alle nostre comunità cristiane non manchi nulla per essere pronte a ripartire con una buona pastorale giovanile: devono “solo” (tra virgolette) convertirsi ad un atteggiamento di maggiore attenzione ed apertura. Anche il linguaggio adatto con i giovani non scaturisce da una riunione fatta a tavolino dagli educatori, ma da una comunità appassionata del Vangelo e dei ragazzi: questa comunità, vedrete, sa trovare le parole con cui farsi capire! Per sostenere questo processo di trasformazione della comunità cristiana, vi propongo di dedicare una domenica al mese ad una lectio divina sul tema dell’essere padri e madri nella fede, una Chiesa che genera nuovi figli attraverso la Parola: potete proporre questo itinerario biblico agli adulti della comunità parrocchiale, ai catechisti, ai genitori, alle fraternità di famiglie. Il tema del generare alla fede narrando è molto ricco nella Scrittura. Prepareremo del materiale su questa iniziativa. Il Servizio di pastorale giovanile, guidato come sapete da don Antonio Magnotta, sta puntando a sostenere gli animatori degli adolescenti offrendo loro un cammino formativo di prefettura e degli itinerari sulla riscoperta dell’identità del battezzato (quest’anno sul munus sacerdotale). La pastorale universitaria (Mons. Leuzzi) propone quest’anno un cammino di riscoperta del discepolato missionario sul Vangelo di Marco. Qui vorrei sottolineare un punto importante per il futuro della pastorale giovanile della diocesi: valorizzare la prefettura come il luogo in cui le comunità cristiane e gli educatori degli adolescenti e dei giovani pensano, progettano, verificano le loro attività, si sostengono con incontri di formazione, si raccordano con le scuole del territorio e con le altre agenzie educative, mettono in piedi equipe di operatori di strada, portano avanti la dimensione vocazionale della pastorale giovanile e altro ancora. Non penso che questo sia solo un sogno utopico, ma è un obbiettivo concreto su cui lavorare nei prossimi anni. Per ciò che riguarda l’animazione vocazionale della pastorale giovanile segnalo l’iniziativa di don Fabio Rosini detta “La strada nuova”: si tratta di incontri mensili per giovani, sul tema del discernimento sapienziale, da realizzare con l’aiuto dei rispettivi parroci, in quattro parrocchie, una per ciascuno dei punti cardinali della nostra città: san Lino, Santa Bernardette, SS. Annunziata, SS. Simone e Giuda Taddeo. Inoltre altre iniziative saranno promosse dal Centro Pastorale per la Famiglia, dal Centro Catechistico, da quello Liturgico, dalla Caritas e dal C.O.R.
c. “Solo se i nostri vecchi faranno sogni, allora i giovani avranno visioni”, ci ha detto più volte Papa Francesco citando il profeta Gioele. Solo se le comunità cristiane si risveglieranno dal loro torpore e ricominceranno a sognare, potranno essere capaci di sostenere i ragazzi ed incoraggiarli ad avere “visioni” per l’oggi, per la loro vita e per quella delle realtà in cui abitano. La voglia di essere protagonisti, di rispondere alle sfide, di provare entusiasmo e vertigini, di cui ci ha parlato il Papa, possono davvero oggi esprimersi se sono messi in contatto con una comunità che, seppure un po’ invecchiata, ha ancora voglia di sognare, perché il suo sogno è quello di Dio, una comunità che desidera ancora una volta narrare, alla generazione che viene, la grande storia dell’amore crocifisso del Signore. All’interno della trama positiva delle relazioni comunitarie da cui si sente accolto e valorizzato, il giovane Eutico, messo a contatto con il sogno di Dio sulla sua vita e quella di tutti, non si addormenterà ma sentirà il cuore battergli forte, la testa frullargli, le mani prudergli. Se parliamo a tutta la persona di Eutico, ci dice il Papa, se usiamo tutti i registri educativi (del pensare, dell’amare, del fare), il nostro giovane ritroverà l’unità della sua esistenza e inventerà un “modo suo” di credere, sperare, amare. Le visioni dei giovani infatti, spesso non coincidono con i sogni dei vecchi, non sono la stessa cosa: ma i secondi sono al servizio dei primi. I giovani credenti di oggi vivono la fede in una maniera personale, meno normativa e rigida, più autobiografica e meno istituzionale; questo non è relativismo, ma il normale processo che avviene quando la fede viva passa da una generazione all’altra. Quindi, i vecchi devono sognare e permettere ai giovani di elaborare le loro visioni. Dalla testimonianza credente di chi ha camminato con il Signore possono nascere modalità nuove di vivere la testimonianza oggi. In molti dei laboratori si è sottolineata l’importanza di iniziative intergenerazionali, non solamente tra gruppi di pari, perché possano emergere, al servizio dei ragazzi, le testimonianze di adulti significativi della comunità cristiana. E’ da apprezzare la pastorale degli adolescenti diffusa in molte parrocchie dove è presente il cammino neocatecumenale, dove una famiglia ospita a casa sua e accompagna il percorso di vita e di fede di piccoli gruppi di adolescenti. Noto anche che si diffonde sempre più anche la pratica di affidare un giovane, per il suo accompagnamento spirituale, ad un laico adulto o ad una famiglia, perché possa orientarlo nelle sue scelte fondamentali. Anche qui c’è un processo da avviare con convinzione e una pista di lavoro per i prossimi anni!
d. In ultimo uno sguardo sui genitori dei ragazzi, in realtà il tema centrale del Convegno di quest’anno. Non vogliamo lasciarli soli nel loro compito educativo. Spesso riusciamo a coinvolgere in qualche incontro in parrocchia i genitori dei bambini, ma è molto raro coinvolgere i genitori degli adolescenti. Spesso queste dipende dal fatto che hanno timore di venire criticati, ritenuti responsabili delle intemperanze e delle follie dei loro figli: dobbiamo far loro sentire, invece, tutta la nostra vicinanza, la nostra disponibilità a collaborare. I genitori apprezzano molto la comunità parrocchiale quando a riesce a coinvolgere i loro ragazzi, specie se a casa sperimentano di non essere più presi in considerazione dai loro figli. Tante iniziative indicate nei laboratori sono davvero molto belle e invito a diffonderle e farle circolare. Il Servizio di pastorale giovanile preparerà dei sussidi per l’organizzazione di incontri tra genitori e animatori degli adolescenti, tra genitori e figli. Vorrei però sottolineare due cose: saremo credibili per i genitori se ci sentiranno parlare non soltanto di ciò che vivono i loro figli, ma anche di ciò che vivono loro. Ripeto: devono poter sentire il nostro calore, la nostra empatia e attraverso di essa la tenerezza di Dio. Inoltre, è molto importante che parliamo loro della bellezza del generare e dell’essere padri e madri contenuta nella Scrittura. Lì, nella pagina biblica, c’è un tesoro che stupisce, affascina e motiva al compito educativo. Ho chiesto inoltre al Papa se vorrà regalarci, per il tempo di Avvento e di Quaresima, un sussidio che contenga poche semplici proposte per la preghiera in famiglia. Sarebbe molto bello se ci aiutassimo a recuperare questa capacità di parlare di Dio e di pregarlo in casa che avevano le famiglie fino alla precedente generazione e che si è perduta, contribuendo così alla rottura della trasmissione della fede. La piccola Chiesa domestica, che è la famiglia, riscopre così la sua dignità e la sua vocazione
La Chiesa è una famiglia: l’immagine è quella della mensa domestica, alla quale il Signore invita tutti a sedersi, una tavola dove c’è posto per tutti perché ognuno si senta a casa. Questa casa è la casa della Trinità, che è la Trinità: Dio ha preparato in se stesso un posto per ciascuno di noi (Benedetto XVI). Qui sulla terra è la Chiesa il sacramento dell’amore materno di Dio che invita tutti alla mensa del regno di Dio, al banchetto della Parola e dell’Eucarestia: peccatori, poveri, storpi e ciechi, vecchi e giovani… Gli adolescenti e le loro famiglie, di cui abbiamo parlato nel Convegno di giugno, sono già da sempre nel cuore di Dio: se è così, a noi è chiesto di metterci a servizio del Signore che li cerca, li chiama, li invita a sedersi alla mensa della Parola e dell’Eucarestia, li fa sentire a casa. Quando pensiamo ai ragazzi e le loro famiglie, dobbiamo immaginarli in questo “luogo”: nel cuore di Dio. E’ lì che li dobbiamo cercare.
Preghiera degli educatori e dei genitori per i figli
O Padre,
ci rivolgiamo a Te all’inizio di questo anno nel quale la nostra comunità desidera dedicarsi in maniera rinnovata a servizio della crescita dei ragazzi e dei giovani.
Siamo consapevoli che il futuro passerà dal modo con cui saremo riusciti a rendere sensibili, forti, libere le coscienze di coloro che oggi sono giovani.
Sappiamo che non possiamo lasciare a se stesse le nuove generazioni; né che possiamo lasciare genitori, educatori e insegnanti soli a portare la responsabilità di dare un senso e un orientamento alla loro vita.
Vogliamo tutti insieme, come comunità, assumerci il compito di dare ai ragazzi e ai giovani ragioni di vita e di speranza; vogliamo con loro credere nel futuro. Vorremmo riuscire a fare loro toccare con mano, nelle nostre esistenze, che la vita vale la pena di essere vissuta e che, alla luce del Vangelo e sulla traccia del tuo Figlio Gesù, essa acquista una vastità di orizzonti, una pienezza e un’intensità che va al di là di ogni possibile desiderio.
Siamo coscienti di aver contribuito a preparare per loro una società che ama più le cose che le persone, che esclude i deboli, che non si indigna per l’ingiustizia e non sa più piangere per il dolore dell’altro.
Tu sai, Padre, che anche gli adulti sono spesso sopraffatti dalla stanchezza, spenti dalla disillusione, e che la vita appare loro talvolta più un peso che una benedizione.
Sappiamo quante volte non abbiamo saputo orientare i desideri dei più giovani, non abbiamo saputo trovare le parole giuste per comunicare loro la bellezza della vita e della fede; quante volte non siamo riusciti a riconoscere e ad accogliere le loro spinte al bene o non abbiamo saputo rispettare e decifrare i loro silenzi.
Come discepoli del tuo Figlio, non abbiamo saputo far vedere tutta la bellezza di una vita vissuta secondo il Vangelo.
Padre,
mentre ti chiediamo di avere misericordia per le nostre povertà, invochiamo con ancora più forza il dono del tuo santo Spirito, senza il quale nulla ci è possibile.
Sostenuti da te, sentiamo di poterti presentare il nostro rinnovato impegno.
Desideriamo impegnarci in modo nuovo per l’educazione delle nuove generazioni.
– Ci impegniamo a sentire tutti i nostri ragazzi e giovani come figli nostri, e ad ascoltarli nel loro bisogno di vita, di amore, di pienezza, di gioia;
– Ci impegniamo a fare loro vedere con la nostra vita di ogni giorno quanto sia bella, buona e gioiosa un’esistenza che si svolge sotto il tuo sguardo di Padre e che attinge al Vangelo di Gesù;
– Ci impegniamo ad avere uno sguardo di predilezione per i ragazzi più fragili, quelli che sono stati troppo poco amati e che rischiano di non credere più in nulla;
– Ci impegniamo a far sì che le ragazze e le giovani siano rispettate per la loro dignità ed educate a custodire per tutti quella riserva di tenerezza di cui ha grande bisogno la società;
– Ci impegniamo a sostenere le famiglie, a diventare ogni giorno alleati dei genitori in quel compito educativo che sentiamo anche nostro;
– Ci impegniamo a non pretendere dai giovani che siano migliori di noi, ma insieme con loro vogliamo dar vita ad un mondo pienamente umano;
– Ci impegniamo a far loro posto nella nostra comunità e nella società, consapevoli che la giovinezza della Chiesa ha bisogno della loro presenza, del loro pensiero, del loro cuore, della loro novità.
Ti presentiamo Padre la nostra preghiera per l’intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre di ogni donna e uomo. Lei, che conosce la bellezza e la fatica di accompagnare verso la vita il giovane Gesù, sostenga il nostro cammino.
Amen
SCARICA PDF
Discorso Conclusioni Convegno Diocesano