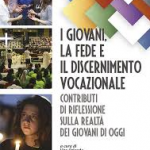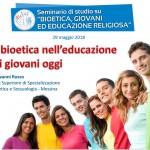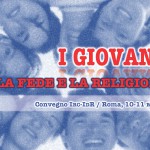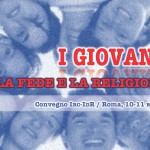Nei cinque capitoli del documento Papa Francesco sgombera così il campo dalle false immagini che si possono avere della santità, da ciò che è nocivo e ideologico e «da tante forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel mercato religioso attuale», e, spiegando che la santità è frutto della grazia di Dio, indica le caratteristiche che ne costituiscono un modello a partire dal Vangelo. Illumina così la vita nell’amore non separabile per Dio e per il prossimo, che è il comandamento centrale della carità e il cuore del Vangelo dalle parole stesse di Gesù: «Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos’è essere santi, e lo ha fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Esse sono come la carta d’identità del cristiano» «Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella quotidianità della nostra vita».
È il capitolo centrale dell’esortazione. Il canovaccio di riferimento di uno stile di vita. E si comprende da qui la forza e l’utilità di questo documento che mette insieme in modo organico ciò su cui Papa Francesco insiste da cinque anni, andando controcorrente rispetto a quanto abitualmente si fa nella società.
«La forza della testimonianza dei santi sta nel vivere le Beatitudini e la regola di comportamento del giudizio finale – scrive – Sono poche parole, semplici, ma pratiche e valide per tutti, perché il cristianesimo è fatto soprattutto per essere praticato».
La santità della porta accanto
«Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità… Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente» scrive Francesco e nel primo capitolo ricordando che i santi non sono solo quelli già beatificati o canonizzati. «Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere… Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio» (7).
Francesco non si ferma pertanto a spiegare i mezzi di santificazione o le varie forme di devozione invita subito a non scoraggiarsi di fronte a «modelli di santità che appaiono irraggiungibili», perché dobbiamo seguire la «via unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi». (11). E spiega e ripete che per essere santi «non è necessario essere vescovi, sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno». (14)
Ribadisce quindi che l’obiettivo di questa esortazione «è soprattutto la chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata personale che rivolge anche a te: «Siate santi, perché io sono santo» (Lv 11,44; 1 Pt 1,16). Il Concilio Vaticano II lo ha messo in risalto con forza», «ognuno per la sua via, dice il Concilio». «Lascia dunque che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità» (15).
E ripete l’invito a non avere paura a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo: «Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché ciò sia possibile, e così la tua preziosa missione non andrà perduta». «La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia. In fondo, come diceva León Bloy, nella vita «non c’è che una tristezza… quella di non essere santi» (34).
I due nemici della santità e il cuore della Legge
Nel secondo capitolo si sofferma su quelle che definisce «due falsificazioni della santità che potrebbero farci sbagliare strada: lo gnosticismo e il pelagianesimo». Ancora una volta, quindi, il Papa fa riferimento a queste due eresie «sorte nei primi secoli cristiani», e che a suo giudizio «continuano ad avere un’allarmante attualità» dentro la Chiesa (35). Si tratta di «due forme di sicurezza dottrinale o disciplinare che danno luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario dove, invece di evangelizzare, si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare» (35). Se infatti la santità è un dono della grazia nella vita della Chiesa, queste due sottili forme di eresia ne sono un ostacolo proprio perché rimuovono la necessità della grazia di Cristo, oppure svuotano la dinamica reale e gratuita del suo agire. Per questo complicano e fermano la Chiesa nel suo cammino verso la santità. I «nuovi pelagiani» ad esempio «per il fatto di pensare che tutto dipende dallo sforzo umano incanalato attraverso norme e strutture ecclesiali – spiega il Papa – complicano il Vangelo e diventando «schiavi di uno schema che lascia pochi spiragli perché la grazia agisca»( 59). Questi s’impegnano nel seguire un’altra strada che è «quella della giustificazione mediante le proprie forze, quella dell’adorazione della volontà umana e della propria capacità, che si traduce in un autocompiacimento egocentrico ed elitario privo del vero amore». E si manifesta in molti atteggiamenti: «L’ossessione per la legge, il fascino di esibire conquiste sociali e politiche, l’ostentazione nella cura della liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa, la vanagloria legata alla gestione di faccende pratiche, l’attrazione per le dinamiche di auto-aiuto e di realizzazione autoreferenziale. In questo alcuni cristiani spendono le loro energie e il loro tempo, invece di lasciarsi condurre dallo Spirito sulla via dell’amore, invece di appassionarsi per comunicare la bellezza e la gioia del Vangelo e di cercare i lontani nelle immense moltitudini assetate di Cristo» (57).
Il Papa ha quindi ricordato che siamo chiamati a curare attentamente la carità che è il centro delle virtù e della Legge. Cristo ci ha consegnato «due volti, quello del Padre e quello del fratello», «o meglio uno solo, quello di Dio che si riflette in molti, perché in ogni fratello è presente l’immagine stessa di Dio» (61). L’amore per Dio e per il prossimo non possono perciò essere separati: «Chi ama l’altro ha adempiuto la Legge» perché pienezza della Legge infatti è la carità». Perché «tutta la Legge trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso» (60).
Le Beatitudini: ritratto di Gesù e stile di vita controcorrente
Nel terzo capitolo, Francesco srotola una per una le beatitudini evangeliche contenute nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo e le rilegge attualizzandole. «Vivere le Beatitudini – spiega – diventa difficile e può essere addirittura una cosa malvista, sospetta, ridicolizzata». Ma queste sono «la carta d’identità del cristiano».
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli»
«Le ricchezze non ti assicurano nulla – ricorda il Papa – Anzi, quando il cuore si sente ricco, è talmente soddisfatto di sé stesso che non ha spazio per la Parola di Dio, per amare i fratelli» (68). «Essere poveri nel cuore, questo è santità».
«Beati i miti, perché avranno in eredità la terra».
«È un’espressione forte, in questo mondo che fin dall’inizio è un luogo di inimicizia dove si litiga ovunque, dove da tutte le parti c’è odio, dove continuamente classifichiamo gli altri per le loro idee, le loro abitudini» (71). Osserva Francesco: «Qualcuno potrebbe obiettare: “Se sono troppo mite, penseranno che sono uno sciocco, che sono stupido o debole”. Forse sarà così, ma lasciamo che gli altri lo pensino. È meglio essere sempre miti, e si realizzeranno le nostre più grandi aspirazioni: i miti «avranno in eredità la terra», ovvero, vedranno compiute nella loro vita le promesse di Dio» (74). La mitezza è propria di Cristo: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29). Il Papa pertanto ricorda che «anche quando si difende la propria fede e le proprie convinzioni, bisogna farlo con mitezza, e persino gli avversari devono essere trattati con mitezza. Nella Chiesa tante volte abbiamo sbagliato per non aver accolto questo appello» (73). «Reagire con mitezza, questo è santità».
«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati»
«La persona che vede le cose come sono realmente – scrive – si lascia trafiggere dal dolore e piange nel suo cuore è capace di raggiungere le profondità della vita e di essere veramente felice» (76). «Saper piangere con gli altri, questo è santità».
«Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati»
«La giustizia che propone Gesù – spiega – non è come quella che cerca il mondo, molte volte macchiata da interessi meschini, manipolata da un lato o dall’altro. La realtà ci mostra quanto sia facile entrare nelle combriccole della corruzione, far parte di quella politica quotidiana del “do perché mi diano”, in cui tutto è commercio» e si resta «ad osservare impotenti come gli altri si danno il cambio a spartirsi la torta della vita» (78). «Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità».
«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia».
«“Tutto quanto vorrete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loroˮ. Il Catechismo ci ricorda che questa legge si deve applicare “in ogni casoˮ,» (80). Gesù, ricorda il Papa, «non dice “Beati quelli che programmano vendetta”, ma chiama beati coloro che perdonano e lo fanno “settanta volte setteˮ». «Guardare e agire e agire con misericordia, questo è santità»
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio»
«Quando il cuore ama Dio e il prossimo, quando questo è la sua vera intenzione e non parole vuote, allora quel cuore è puro e può vedere Dio» (86). «Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità».
«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio».
«Il mondo delle dicerie, fatto da gente che si dedica a criticare e a distruggere, non costruisce la pace», scrive Francesco (87). Mentre i pacifici «costruiscono pace e amicizia sociale» (88). Anche se «non è facile costruire questa pace evangelica che non esclude nessuno, ma che integra anche quelli che sono un po’ strani, le persone difficili e complicate… quelli che sono diversi» (89). «Seminare pace intorno a noi, questo è santità».
«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli».
«Se non vogliamo sprofondare in una oscura mediocrità – avverte il Papa – non pretendiamo una vita comoda» (90). «Non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto intorno a noi sia favorevole» (91). Ma Francesco spiega anche che «un santo non è una persona eccentrica, distaccata, che si rende insopportabile per la sua vanità, la sua negatività e i suoi risentimenti». Non erano così gli apostoli che «godevano della simpatia “di tutto il popoloˮ» (93). Quanto alle persecuzioni, esse «non sono una realtà del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in maniera cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia in un modo più sottile, attraverso calunnie e falsità» (94). «Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è santità».
Il protocollo su cui saremo giudicati
Francesco rievoca le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo (25,31-46) sul dar da mangiare agli affamati e accogliere gli stranieri e ricorda che queste sono la «regola di comportamento in base alla quale saremo giudicati». «Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una notte fredda, posso sentire che questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso… un problema che devono risolvere i politici… Oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa dignità… un fratello redento da Cristo. Questo è essere cristiani!» (98). «In questo richiamo a riconoscerlo nei poveri e nei sofferenti si rivela il cuore stesso di Cristo, i suoi sentimenti e le sue scelte più profonde, alle quali ogni santo cerca di conformarsi – afferma Francesco – pertanto sottolinea con decisione «davanti alla forza di queste richieste di Gesù è mio dovere pregare i cristiani di accettarle e di accoglierle con sincera apertura, “sine glossa”, vale a dire senza commenti, senza elucubrazioni e scuse che tolgano ad esse forza. Il Signore ci ha lasciato ben chiaro che la santità non si può capire né vivere prescindendo da queste sue esigenze» (97).
La nocività delle ideologie
Purtroppo, scrive Francesco, a volte «le ideologie ci portano a due errori nocivi». Da una parte, quello di trasformare «il cristianesimo in una sorta di ONG», privandolo della sua «luminosa spiritualità» (100). Dall’altra parte c’è l’errore di quanti «vivono diffidando dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista». O lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono. «La difesa dell’innocente che non è nato, per esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri che sono già nati, che si dibattono nella miseria, nell’abbandono, nell’esclusione, nella tratta di persone, nell’eutanasia nascosta dei malati e degli anziani privati di cura, nelle nuove forme di schiavitù, e in ogni forma di scarto. Non possiamo proporci un ideale di santità che ignori l’ingiustizia di questo mondo (101). «Spesso si sente dire – riprende il Papa – che, di fronte al relativismo e ai limiti del mondo attuale, sarebbe un tema marginale, per esempio, la situazione dei migranti. Alcuni cattolici affermano che è un tema secondario rispetto ai temi “seri” della bioetica. Che dica cose simili un politico preoccupato per i suoi successi si può comprendere, ma non un cristiano, a cui si addice solo l’atteggiamento di mettersi nei panni di quel fratello che rischia la vita per dare un futuro ai suoi figli. Possiamo riconoscere che è precisamente quello che ci chiede Gesù quando ci dice che accogliamo Lui stesso in ogni forestiero (cfr Mt 25,35)?» (102).
«Chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita, chi realmente anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifichi il Santo, è chiamato a tormentarsi, spendersi e stancarsi cercando di vivere le opere di misericordia» (107).
Il santo e la violenza verbale dei media
All’interno del grande quadro della santità proposte dalle Beatitudini e Matteo 25,31-46, nel quarto capitolo Francesco presenta alcune caratteristiche che, a suo giudizio, sono indispensabili per comprendere lo stile di vita a cui Cristo ci chiama nel contesto attuale e che hanno particolare importanza a motivo di alcuni rischi e limiti della cultura di oggi, «dove si manifestano – afferma – l’ansietà nervosa e violenta che ci disperde e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia comoda, consumista ed egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel mercato religioso attuale».
Le prime sono: la sopportazione, la pazienza e la mitezza. Virtù necessarie. «Anche i cristiani – scrive poi il Papa – possono partecipare a reti di violenza verbale mediante internet… Persino nei media cattolici si possono eccedere i limiti, si tollerano la diffamazione e la calunnia, e sembrano esclusi ogni etica e ogni rispetto per il buon nome altrui». «È significativo che a volte, pretendendo di difendere altri comandamenti, si passi sopra completamente all’ottavo: “Non dire falsa testimonianzaˮ, e si distrugga l’immagine altrui senza pietà» (115). Lì si manifesta senza alcun controllo che la lingua è «il mondo del male» e «incendia tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna (Gc 3,6)». Il santo, ricorda Francesco, «evita la violenza verbale» (116). «La fermezza interiore, che è opera della grazia, ci preserva dal lasciarci trascinare dalla violenza che invade la vita sociale – scrive il Papa – perché la grazia smorza la vanità e rende possibile la mitezza del cuore» (117).
L’umiltà e le umiliazioni
L’umiltà – spiega – può radicarsi nel cuore solamente attraverso le umiliazioni. Senza di esse non c’è umiltà né santità» (118). Non si riferisce solo alle situazioni violente di martirio, «ma alle umiliazioni quotidiane di coloro che sopportano per salvare la propria famiglia, o evitano di parlare bene di sé stessi e preferiscono lodare gli altri invece di gloriarsi, scelgono gli incarichi meno brillanti, e a volte preferiscono addirittura sopportare qualcosa di ingiusto per offrirlo al Signore» (119). «Non dico – afferma – che l’umiliazione sia qualcosa di gradevole, perché questo sarebbe masochismo, ma che si tratta di una via per imitare Gesù e crescere nell’unione con Lui. Questo non è comprensibile sul piano naturale e il mondo ridicolizza una simile proposta» (120). È un atteggiamento che presuppone un cuore pacificato da Cristo, «libero da quell’aggressività che scaturisce da un io troppo grande. La stessa pacificazione, operata dalla grazia – dice papa Bergoglio – ci permette di mantenere una sicurezza interiore e resistere, perseverare nel bene anche “se contro di me si accampa un esercito” (Sal 27,3)» (121).
Senso dell’humor e fervore
Il Papa sottolinea che quanto detto finora «non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, o un basso profilo senza energia. Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza» (122).
Bisogna superare la tentazione di «fuggire in un luogo sicuro che può avere molti nomi: individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli mondi, dipendenza, sistemazione, ripetizione di schemi prefissati, dogmatismo, nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme» (134).
«Dio è sempre novità – scrive Francesco – che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto per andare oltre il conosciuto, verso le periferie e le frontiere… là lo troveremo: Lui sarà già lì» (135). Ci mette in moto, ricorda il Papa, l’esempio di tanti preti, religiose e laici «che si dedicano ad annunciare e servire con grande fedeltà, molte volte rischiando la vita… La loro testimonianza ci ricorda che la Chiesa non ha bisogno di tanti burocrati e funzionari, ma di missionari appassionati, divorati dall’entusiasmo di comunicare la vera vita. I santi sorprendono, spiazzano, perché la loro vita ci chiama a uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante» (138). E Francesco ricorda anche come importante «la vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa», che «è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani» (143): anche Gesù «invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari». «Infine, malgrado sembri ovvio – precisa Francesco – ricordiamo che la santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e nell’adorazione» che non è è evasione dal mondo intorno a noi.
In lotta contro il demonio
Il quinto capitolo avverte che il cammino per la santità è anche «una lotta costante contro il diavolo, che è il principe del male» (159). Il «male» citato nel Padre Nostro è «il Maligno» e «indica un essere personale che ci tormenta» (160). «Non pensiamo dunque che sia un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o un’idea. Tale inganno ci porta ad abbassare la guardia, a trascurarci e a rimanere più esposti. Lui non ha bisogno di possederci. Ci avvelena con l’odio, con la tristezza, con l’invidia, con i vizi» (161). E può portare alla «corruzione spirituale», che «è peggiore della caduta di un peccatore, perché si tratta di una cecità comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito: l’inganno, la calunnia, l’egoismo e tante sottili forme di autoreferenzialità, poiché «anche Satana si maschera da angelo della luce (2 Cor 11,14)» (165).
«Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavolo? L’unico modo – ricorda Francesco – è il discernimento», che «è anche un dono che bisogna chiedere» (166). «Senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento» (167). Pertanto il Papa chiede «a tutti i cristiani di non tralasciare di fare ogni giorno… un sincero esame di coscienza» (169).
Un esistenza disponibile per Dio e per i fratelli
«San Paolo invitava i cristiani di Roma a non rendere «a nessuno male per male» (Rm 12,17), a non voler farsi giustizia da sé stessi (cfr v. 19) e a non lasciarsi vincere dal male, ma a vincere il male con il bene (cfr v. 21). Questo atteggiamento non è segno di debolezza ma della vera forza». Solo «chi è disposto ad ascoltare – conclude Francesco – è realmente disponibile ad accogliere una chiamata che rompe le sue sicurezze ma che porta a una vita migliore» (172). Questo atteggiamento «implica, naturalmente, obbedienza al Vangelo come ultimo criterio, ma anche al Magistero che lo custodisce, cercando di trovare nel tesoro della Chiesa ciò che può essere più fecondo per l’oggi della salvezza» (173). «Chiediamo – conclude papa Francesco – che lo Spirito Santo infonda in noi un intenso desiderio di essere santi per la maggior gloria di Dio e incoraggiamoci a vicenda in questo proposito» (177).