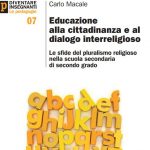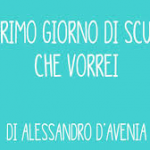“Qui la meta è partire” (Ungaretti). Partire ti costringe a lasciare certezze, a selezionare ricordi, a cristallizzare volti, a sentire nostalgia. E’ toccato anche a me sperimentare un po’ di tutto ciò: quest’estate ho saputo che avrei lasciato la scuola dove sono stato per otto anni. Mi accingevo a partire per un mare sconosciuto lasciando un porto sicuro in cui, tra normali fatiche e altrettante gioie, avevo costruito legami belli e fecondi con colleghi e studenti.
Alcuni miei alunni, venuti a sapere di questo mio passaggio, mi hanno inviato bigliettini che mi hanno riempito il cuore di gioia e tenerezza. Sì, perché uno dei tratti privilegiati del mio mestiere è la possibilità di creare relazioni vere con ragazzi che vivono un’età fondamentale della vita: l’adolescenza. Ecco alcune delle cose belle che mi hanno scritto: “Grazie prof! In questi anni lei non ha fatto religione ma ci ha mostrato come vivere”; oppure: “Grazie perché l’ora di religione ci ha permesso di esprimerci davvero, attraverso il dialogo e il confronto, senza dover aderire a dogmi preconfezionati…”; e ancora: “Sono state lezioni interessanti perché l’attualità è entrata in classe e non ci ha riproposto qualcosa di già sentito e a noi lontano”.
Dopo aver letto questi bigliettini, al di là dell’affetto e della stima, è sopraggiunto in me un senso di sconforto e parziale fallimento; con tutta la fatica che faccio a spiegare e far comprendere il senso dei 10 comandamenti, mi vedo scritto che non faccio religione? O con lo sforzo di rendere ragione oggi di tematiche attinenti la bioetica, la morale sociale, l’affettività rimanendo fedele al patrimonio della Chiesa cattolica, mi trovo scritto che l’attualità è entrata in classe quasi a scalzare un passato religioso che sa di “vecchio”? O ancora: l’apparente novità del dialogo e del potersi esprimere che i miei studenti avrebbero fatto “quasi in esclusiva” nella mia ora e non in tutte le materie scolastiche? Insomma, come sempre, i ragazzi ti mettono in discussione, spingendoti a comprendere meglio sia questo tempo sia la disciplina. Sono proprio i cuccioli d’uomo a mostrare i segni di una possibilità che si affaccia all’orizzonte e che chiede di essere guardata con franchezza e senza paura.
La questione del linguaggio
Così, ho avuto la conferma che il vero problema sia il linguaggio con cui cerchiamo di veicolare messaggi e far comprendere concetti. Come è possibile, oggi, spiegare in classe che il Dio cristiano è Trinità? O come presentare l’esperienza della misericordia come rivelazione di Dio? E’ necessario ri-significare il tutto. Come ricordava di recente don Fabio Landi a un corso di formazione per insegnanti, “il discorso religioso oggi patisce di un sistematico fraintendimento delle parole della fede: credenti e non credenti attivano gli stessi automatismi e ripropongono schemi e orizzonti di pensiero che, quanto più sono irriflessi, tanto più risultano inattaccabili. Per questo, il nostro discorso chiede, quasi per ogni vocabolo, la fatica di intervenire con tutto un corredo di note e precisazioni. Se ci asteniamo dal farlo, gli altri semplicemente non capiscono niente di quello che diciamo e prendono l’oggetto dei nostri discorsi come verità arbitrarie e, come si dice, piovute dal cielo”.
L’insegnamento della religione cattolica si presenta davvero come un’attività di frontiera per quanto riguarda la traduzione del discorso religioso in un linguaggio universale e comprensibile. E’ necessario non dare nulla per scontato e ripartire dall’esperienza personale e di tutti per dire in modo nuovo ciò che, da sempre, è “inattingibile e misterioso”.
Scommettere sull’umanità della fede
Il primo giorno di scuola entro in una classe di prima superiore e chiedo agli alunni se qualcuno partecipa a un gruppo. Una ragazza alza la mano e risponde che lei fa parte di 5 gruppi; incuriosito dall’elevato numero, le chiedo di raccontare e lei candidamente mi risponde che fa parte di 5 gruppi di WhatsApp. Istantaneamente mi rendo conto che la parola “gruppo” riporta oggi a una esperienza diversa dalla mia. E’ stato necessario partire dal “gruppo WhatsApp” per parlare di comunità. Il “cambiamento d’epoca” impone a tutti, e alla Chiesa in particolare, una conversione culturale. E’ necessario ripartire “dall’umanità della fede”, ovvero dall’esperienza umana condivisa hic et nunc per narrare l’esperienza di fede; è necessario non scoraggiarsi di fronte al nuovo bensì convertirsi, per ri-comprendere il desiderio perenne di un Dio che cerca l’uomo per amarlo fino alla “pazzia” della croce anche in questo tempo di grandi opportunità e non solo di fatiche. [1]
Efficace, a tal proposito, la definizione di Duilio Albarello secondo cui l’insegnante di religione è una sorta di “teologo in uscita”. Proprio il caso dell’Irc – afferma – “mi sembra significativo per intendere una corretta declinazione della ‘laicità dello Stato’. Tale principio di laicità non comporta affatto necessariamente né la rimozione dell’esperienza religiosa dallo spazio pubblico per ghettizzarla nell’ambito del privato, né la pura neutralità dello Stato e delle sue istituzioni rispetto alle differenti tradizioni religiose presenti nella società: occorre riconoscere da questo punto di vista che esistono limiti nel laicismo, uguali e contrari ai limiti del dogmatismo”. [2] Il caso Irc – prosegue Albarello – “mostra che può esistere una concezione della laicità dello Stato che non la identifica con la neutralizzazione delle differenze, bensì la intende come l’attitudine davvero democratica di riconoscere le differenze come tali e di apprezzarne l’apporto specifico, che esse possono offrire alla ricerca del bene di tutti e di ciascuno. Ecco il compito dell’insegnante specialista di religione cattolica, considerabile come un ‘teologo in uscita’, per usare un’espressione assonante al pensiero di Papa Francesco”.
Si tratta di proporre un linguaggio diverso che metta in luce aspetti nuovi, apra a prospettive inedite, permetta di capire ciò che non si era mai capito. In questo senso, ogni traduzione rappresenta anche una grande opportunità. Il lessico contemporaneo, mentre dice la vita così come l’uomo di oggi la vive e la coglie, fa risuonare il Vangelo in un modo inedito. Contemporaneamente, il Vangelo si appropria della parola umana, la illumina, le dona sostanza e verità. Ma la grazia porta a perfezione la natura senza sostituirla: è sempre nell’autenticità dell’esperienza comune che il Vangelo rivela la sua ricchezza e si afferma come parola divina.
Un “incredibile bisogno di credere”
Una seconda risorsa che l’insegnante di Religione sperimenta è il sincero desiderio di credere dei ragazzi. Certo, un credente dà per scontato che l’oggetto del credere sia il Dio di Gesù Cristo. Ma in un contesto secolarizzato è davvero così? No! Direi che “credere” è una non-evidenza che necessita di essere risignificata, con tutta la fatica che ciò comporta perché, prima ancora che in Dio, l’uomo ha bisogno di fare un’esperienza di fede-fiducia verso se stessi e gli altri, e solo successivamente in Dio.
Credere in Dio è qualcosa che i giovani associano all’infanzia o alla vecchiaia e esclude in blocco il mondo giovanile, alla ricerca di certezze basate sempre sulla esperienza personale. Eppure, nonostante tutto, riscontro che i giovani manifestano sempre più “l’incredibile bisogno di credere”[3], che si traduce nella ricerca di adulti in grado di accompagnarli in questo cammino di scoperta e fiducia: un cammino che non ha più argini e paletti socialmente riconosciuti, ma che si configura come un percorso soggettivo e personale in cui il dialogo con altri, che hanno intrapreso il medesimo viaggio, diviene necessario.
Per questo motivo, l’ora di religione ha una grande opportunità e, al contempo, una grande responsabilità nell’aiutare le nuove generazioni a dare voce a questo intimo desiderio, nel promuovere la bellezza del vivere come chiave per non perdere l’orizzonte di senso in cui i giovani si muovono e camminano quotidianamente. Ne segue che è fondamentale avere Idr affidabili, disponibili, preparati e capaci di aiutare i giovani a “spiccare il volo”.
Educare alla bellezza
Il terzo punto di forza in cui credo che l’Irc possa dare un potente contributo alla scuola di oggi e alla società di domani, è educare alla bellezza. Più passano gli anni, più sento che gli alunni chiedono un altro punto di vista rispetto al modello prevalente tecnico-economico.
Un mese fa una studentessa di seconda superiore mi chiese: “Prof, a cosa serve l’ora di religione? Può essere un’ora anche molto bella, ma credo sia un’ora inutile!”. Le ho risposto: “L’ora di religione non serve a nulla. Perciò è così fondamentale e, spero, bella”. Lei ovviamente in prima battuta non ha compreso, così ho provato a spiegarmi: “Vedi, se ciò che imparo mi deve servire nell’immediato, hai ragione tu. Non serve a nulla. Però desidero farti notare una cosa: a cosa serve passare del tempo con la tua amica del cuore il sabato pomeriggio? Oppure ascoltare la musica che ti piace? In realtà, secondo un’ottica economica, è inutile. Noi però viviamo di queste cose, che rendono bella e saporita la vita. Che ci fanno stupire e lasciano uno spazio ai sentimenti e alla curiosità. Di tutto ciò il nostro mondo ha un estremo bisogno, alla ricerca di ciò che è bello, perché buono e vero. A questo può servire l’ora di religione, ad avere questo sguardo. Che è lo sguardo di Gesù, in ogni tempo e su ogni uomo”.
Davvero c’è bisogno di educare alla bellezza come veicolo verso il riconoscimento di ciò che è buono; solo così si può contribuire al dare voce a quell’anelito, spesso sopito, dell’anima verso lo stupore e la meraviglia. Peppino Impastato soleva ricordare che se si insegnasse la Bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura, l’omertà. E’ per questo che bisognerebbe educare la gente alla Bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore.
L’Irc può contribuire in modo efficace a educare a uno sguardo così, sguardo troppo spesso offuscato dalle brutture, sfregiato dalle barbarie, sopito dal tiepido e mediocre. Se riusciremo, noi insegnanti di religione cattolica e di altre discipline, a mostrare che ne vale la pena, avremo aiutato le nuove generazioni a leggere la vita come un dono, come una risorsa produttiva che rinvia sempre a un futuro che appare promettente e per cui vale la pena sperare, combattere, vivere.
NOTE
[1] Cf D. ALBARELLO, La grazia suppone la cultura. Fede cristiana come agire nella storia, Giornale di Teologia 405, Queriniana, Brescia 2018.
[2] D. ALBARELLO, Da una prospettiva cattolica: i limiti del dogmatismo e l’universalità della Religione, intervento al Corso nazionale di aggiornamento per IdR, Assisi 2017.
[3] J. KRISTEVA, Bisogno di credere. Un punto di vista laico, Donzelli, Roma 2006.
L’esperienza di un insegnante di religione nella scuola secondaria di secondo grado
Francesco Luppi
(NPG 2020-02-77)