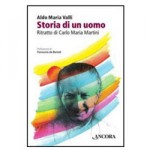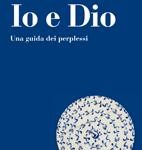|
XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
|
Lectio – Anno A
Prima lettura: Isaia 55,6-9
|
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
|
v Siamo nell’ultimo capitolo del secondo Isaia (40-55), un profeta anonimo del tempo dell’esilio babilonese (VI sec. a. C.) i cui oracoli di consolazione sono stati aggiunti al libro di Isaia (VIII sec. a.C.). Il cap. 55 si conclude con una esortazione a cercare e invocare il Signore, la rinnovata promessa dell’alleanza e l’efficacia della parola di Dio.
Nei versetti precedenti il nostro brano il profeta annuncia la nuova alleanza e la realizzazione delle promesse fatte a Davide, in un orizzonte universalistico che coinvolge i popoli e le nazioni: anche chi non conosce Israele accorrerà a rendergli onore a causa del Signore.
L’oracolo si apre con il v. 6 che esorta gli esiliati a cercare il Signore, mentre è vicino e si fa trovare.
È un tema caratteristico della profezia esilica quello della vicinanza del Signore, proprio in terra straniera, dove gli esuli temevano di averlo perduto. Gli ebrei avevano legato infatti la presenza del Signore al possesso della Terra, alla città santa e al Tempio: con la distruzione di quest’ultimo e la deportazione tutto sembrava compromesso, l’alleanza in-
franta e la salvezza irraggiungibile. Invece, proprio la condizione di smarrimento dell’esilio, assimilata dai profeti al deserto, è una condizione favorevole alla conversione e al ravvedimento.
Il v. 7 invita ad abbandonare le vie e i pensieri iniqui e a ritornare al Signore: il verbo shûv indica la conversione, la metanoia. Il Signore avrà misericordia: la radice rhm indica le viscere materne del Signore che prova compassione per il popolo, senza che esso lo abbia in alcun modo meritato.
Le «vie» e i «pensieri» ritornano al v. 8 per riaffermare con maggior forza la necessità della conversione: le vie e i pensieri degli uomini infatti (l’iniquo e l’empio del v. 7, ma anche tutto il popolo che si illude di essere nel giusto) non corrispondono alle vie e ai pensieri di Dio.
La differenza sostanziale e la superiorità assoluta del progetto di Dio rispetto ai progetti umani sono pari alla distanza infinita tra terra e cielo (v. 9): non è semplicemente l’idea filosofica della trascendenza di Dio, ma la grandezza e la profondità del suo amore, della sua misericordia e del suo perdono, che l’uomo non riesce nemmeno a immaginare.
L’efficacia della parola del Signore, che porta a compimento ciò che promette, viene riaffermata nei versetti seguenti.
Seconda lettura: Filippesi 1,20-24.27
|
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia.
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo.
|
v La lettera ai Filippesi è una delle «lettere dalla prigionia». Paolo è in attesa di giudizio, e rischia la condanna a morte. Nonostante questa condizione drammatica, egli esorta all’obbedienza e all’amore, con speranza e gioia.
Scrive ai cristiani di Filippi, in Macedonia (Grecia), la prima chiesa da lui fondata in Europa.
Le catene della prigionia di Paolo risultano essere un incoraggiamento a predicare il vangelo: nella persecuzione l’apostolo riconosce un dono di grazia che giova alla diffusione del messaggio di Cristo (cf. l,14ss.).
Paolo sviluppa in questi versetti un’audace e paradossale contabilità della sua missione apostolica.
I vv. 20c-22 pongono il problema.
La «partita doppia» tra sofferenze e pericoli della persecuzione e glorificazione di Cristo si chiude in pari, anzi in attivo: Cristo sarà glorificato, sia che l’apostolo venga liberato e viva, sia che subisca la condanna e muoia.
La morte, infatti, rappresenta per Paolo un guadagno perché significa essere ricongiunti a Cristo, che è la vita vera. Il discorso sembrerebbe qui chiuso con l’aspirazione al martirio: ma Paolo vi oppone un argomento altruistico. Per sé, egli sceglierebbe il martirio; ma la vita al servizio dei fratelli e del vangelo può dare frutti alla Chiesa, allora ecco che la scelta si fa più difficile.
I vv. 23-24, centrali nella pericope, propongono con chiarezza l’alternativa: morire in Cristo (espresso con il verbo analysai, come una liberazione) sarebbe il meglio, ed è il desiderio di Paolo; ma vivere è più necessario per i fratelli.
Gli ultimi tre versetti (25-27) risolvono la questione indicando la scelta di Paolo: «continuerò a rimanere in mezzo a voi». Ne segue, logica conseguenza, l’esortazione ai Filippesi perché si rendano degni del vangelo di Cristo: questo è il solo «vanto» (kauchema) riconosciuto valido dall’apostolo.
L’opposizione vita/morte si compone in Cristo, che sarà comunque glorificato dall’apostolo, sia con una morte testimoniale sia con una vita dedicata alla predicazione.
Vangelo: Matteo 20,1-16
|
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzo giorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».
|
Vangelo in immagini
XXV DOM TEMP ORDINARIO (A)
Esegesi
Siamo nella sezione del vangelo di Matteo dedicata al cammino verso la Passione (capp. 16-20).
La sezione si apre con la confessione di fede di Pietro — tu sei il Messia, il Figlio del Dio vivente (16,15) — e prosegue con i tre annunci della Passione (16,21; 16,22-23; 20,18-19). Poco prima dell’ultimo annuncio l’evangelista inserisce la parabola degli operai dell’ultima ora, incorniciata da due detti quasi identici sugli ultimi che saranno primi e i primi che saranno ultimi (19,30; 20,16). Il tutto è a sua volta incastonato fra due brani che riguardano il discepolato e pongono il problema della ricompensa (cf. il salario della parabola) e della gerarchia (cf. l’ordine di priorità fra gli operai della prima e dell’ultima ora). Il brano che precede è la domanda di Pietro sulla ricompensa che spetta a chi ha «lasciato tutto» per seguire Gesù, e la risposta di Gesù (19,27-29); segue immediatamente il terzo annuncio della Passione, e la richiesta della madre dei figli di Zebedeo sui posti da assegnare nel regno.
Nella parabola si possono distinguere tre parti.
1) la prima (vv. 1-7) racconta ciò che succede durante il giorno. Si tratta della giornata lavorativa tipica nella società agricola palestinese del tempo, che durava «dai primi raggi del sole fino al sorgere delle stesse» (cf. Sl 103/104,22-23). La suddivisione in 12 ore quindi, nella stagione estiva, comporta una durata dell’ora lavorativa ben superiore ai 60 minuti. Si susseguono quattro brani sul padrone di casa che esce cinque volte a cercare operai per la sua vigna. Nei primi tre abbiamo una contrattazione in cui si pattuisce un salario («Si accordò con loro per un denaro», la paga giornaliera normale, cf. Tob 5,15; «quello che è giusto ve lo darò»; «fece altrettanto»). Nell’ultimo brano si riferisce nei particolari il dialogo, ma non si parla di salario.
Si crea così una sospensione e un’attesa: anche il lettore si aspetta che gli altri ricevano di meno. Ciò anche perché rimane inespresso il motivo per cui a sera sono ancora disoccupati: non c’era lavoro a sufficienza o erano pigri? dov’erano, quando il padrone era uscito all’alba, alla terza, alla sesta e alla nona ora?
2) Al centro, il v. 8 crea il collegamento tra la parabola e ciò che precede e che segue: abbiamo il rovesciamento tra gli ultimi e i primi (che anticipa la risposta ai figli di Zebedeo), l’ordine inverso nella paga (la ricompensa rivendicata da Pietro). Il tutto a opera del «Signore della vigna» (il «padrone di casa» dei vv. 1 e 11), chiara metafora del regno dei cieli.
La tensione, già creata con il v. 7, viene qui accentuata. È insolito, anche se non impossibile, che si assumano operai al termine della giornata; ancor più insolito che si inizi da costoro il pagamento, costringendo chi ha faticato fin dall’alba ad attendere e rinviare così il momento del riposo. Tanto più che la Legge prescriveva di pagare senza indugio i lavoratori a giornata, che non avevano altro mezzo per provvedere al cibo per sé e per la famiglia: «gli darai il salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole» (Deut 24,15).
A questo punto ci aspettiamo che possa seguire qualcosa di ancora più strano. Era necessario del resto quest’ordine inverso, perché così i primi assistono al pagamento degli ultimi e possono attendersi di ricevere di più (v. 10).
3) Nell’ultima parte vengono messi in parallelo gli ultimi e i primi (vv. 9-10): «e venuti quelli dell’undicesima ora…», «e venuti i primi…». In seguito si riferisce il dialogo: la domanda dei primi operai (vv. 11-12) e la risposta del padrone (vv. 13-15).
Il padrone rivendica a sé la sovrana libertà di disporre del proprio come vuole. Un denaro non era solo la paga consueta, era anche il necessario per vivere: ebbene, la volontà del padrone della vigna è che ciascuno abbia il necessario per vivere (il pane quotidiano), indipendentemente dai propri meriti. Il problema nasce quando si fanno dei confronti, e ci si erge a giudici pretendendo che la giustizia del Signore segua i nostri criteri.
Alcuni elementi colpiscono particolarmente, e portano a comprendere che non di equità sociale o di diritti sindacali vuol parlare l’evangelista.
Il padrone della vigna sottolinea l’opposizione giusto/ingiusto: «quello che è giusto ve lo darò» (v. 4); «non sono ingiusto con te» (v. 13). Si tratta evidentemente di una strana giustizia: «la si perde se l’uomo la reclama per sé con leggerezza, come un suo diritto ovvio, confrontando il proprio curriculum con quello degli altri e non concentra così lo sguardo sulla bontà del Signore davanti alla quale tutto quello che egli ha fatto e meritato svanisce. Così proprio l’incomprensibile bontà di Dio diventa uno scandalo per colui che non vuole liberarsi dei suoi concetti umani di merito e giustizia» – (EDUARD SCHWEIZER, Il vangelo secondo Matteo, Paideia 2001, p. 367).
Il padrone, che nella prima parte della parabola appare tanto premuroso e generoso da uscire ben cinque volte alla ricerca di disoccupati cui offrire lavoro, si rivela subito dopo, se non ingiusto (è pur vero che rispetta i patti), quanto meno capriccioso e brusco («prendi il tuo e vattene», v. 14a). Il contrasto viene sciolto dall’ultima domanda che il padrone rivolge non a tutti gli operai, ma a uno, chiamandolo «amico»: rivolta perciò al lettore del vangelo, a ciascuno di noi personalmente, suona alla lettera: «o il tuo occhio è cattivo perché io sono buono?». La cattiveria sta nell’occhio dei primi, come Caino verso Abele, i fratelli verso Giuseppe: «Gli operai della prima ora non vogliono riconoscere che è stato un dono essere stati assunti: certo, hanno lavorato dodici ore, ma solo grazie all’invito del padrone di casa. Come la vita è un dono, regalata dal Padre, senza alcun merito da parte di chi la riceve» (ROLAND MEYNET, Una nuova introduzione ai vangeli sinottici, EDB 2001, p. 249).
Meditazione
La dichiarazione divina trasmessa dal profeta «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie» (Is 55,8) trova una esposizione narrativa nella parabola evangelica secondo la quale gli operai che hanno lavorato un’ora sola nella vigna del padrone ricevono una paga identica a quella di coloro che hanno lavorato tutto il giorno. Nello scandalo patito dagli operai della prima ora vi è tutta la distanza tra il pensare e l’agire di Dio e il pensare e l’agire degli uomini.
Questa distanza non dice il capriccio di Dio o il suo arbitrio, ma la sua misericordia. Ciò che gli operai della prima ora contestano al padrone è infatti di aver dato la stessa ricompensa agli ultimi arrivati come a loro che avevano patito il peso dell’intero giorno di lavoro. Letteralmente essi dicono: «Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo» (Mt 20,12). Il fare agli ultimi come ai primi abbatte le discriminazioni e i privilegi. Il Dio biblico, infatti, è il Dio della grazia. Esprime bene questo primato della misericordia e della grazia sulle logiche giuridiche un brano della Catechesi sulla santa Pasqua dello Pseudo-Giovanni Crisostomo: «Chi ha lavorato fin dalla prima ora, riceva oggi il giusto salario; chi è venuto dopo la terza, renda grazie e sia in festa; chi è giunto dopo la sesta, non esiti: non subirà alcun danno; chi ha tardato fino alla nona, venga senza esitare; chi è giunto soltanto all’undicesima, non tema per il suo ritardo. Il Signore è generoso, accoglie l’ultimo come il primo, accorda il riposo a chi è giunto all’undicesima ora come a chi ha lavorato dalla prima. Fa misericordia all’ultimo come al primo, accorda il riposo a chi è giunto all’undicesima ora come a chi ha lavorato fin dalla prima».
Il testo ci interpella su ciò che è al cuore della nostra vita con Dio: la relazione o la prestazione? Concepire il proprio servizio a Dio come prestazione conduce a misurarlo e a confrontarlo con il servizio degli altri entrando in un rapporto di competizione. Se invece c’è la relazione con il Signore allora anche il peso della giornata di lavoro è «giogo soave e leggero» e la bontà del Signore verso tutti è motivo di ringraziamento, non di contestazione.
La distanza tra pensieri di Dio e pensieri umani è importante da salvaguardare perché impedisce l’operazione perversa di identificare i propri pensieri umani con quelli di Dio. Questa affermazione contesta la presunzione religiosa che proietta in Dio le proprie azioni e i propri pensieri e identifica le proprie parole su Dio con Dio e la propria volontà con quella di Dio. L’istanza espressa dal profeta è un invito all’umiltà del pensiero, in particolare del pensiero teologico, del pensiero che osa «pensare Dio».
Gli operai della prima ora sono smascherati come invidiosi. E l’invidia è definita come avere «l’occhio cattivo» (Mt 20,15). L’etimologia è illuminante: in-videre, significa «non vedere», «vedere contro», ed esprime lo sguardo torvo di chi si chiede: «perché lui sì e io no?»; «perché a lui come a me che meritavo di più?». L’invidia ci acceca. Se essa è l’insofferenza verso i propri limiti che ci impediscono di raggiungere quello status che vediamo realizzato in altri da noi, essa chiede di essere corretta imparando a desiderare il possibile.
Nell’invidia non solo non si vede più il Dio misericordioso, ma non si vedono neppure più i fratelli: si entra in un rapporto giuridico padrone-servi, e si esce dalla solidarietà con gli altri operai, gli altri uomini.
Male della vita comunitaria ed ecclesiale è la mormorazione (Mt 20,11). Mormorando, gli operai della prima ora affermano che il padrone non aveva il diritto di comportarsi come si è comportato. La mormorazione non è una parola personale chiara che esprime un dissenso leale, ma movimento sotterraneo che aggrega diverse persone che si fanno forza vicendevolmente con il loro malumore per poi esprimersi in accuse e lamentele. La sua logica è la complicità, non la responsabilità.
Preghiere e racconti
Rattristati dalla felicità degli altri
È indiscutibile: noi siamo spesso rattristati dalla felicità degli altri. È uno degli aspetti del mistero del peccato, della ferita presente in ciascuno di noi, Vi sono persone che si rattristano quando vedono che gli altri si amano. Vi sono degli sventurati che non perdonano agli altri la loro giovinezza, la loro bellezza, la loro intelligenza. Vi sono nella Chiesa dei cristiani imbronciati e laboriosi che non perdonano a certi convertiti di essere stati soggiogati dalla grazia di Dio, apparentemente senza alcun sforzo e merito da parte loro… L’inizio della santità sarebbe riconoscere che, nonostante la disuguaglianza delle nostre vite, non ci manca nulla se Dio è con noi; e allora potremmo gioire della bontà di Dio che sembra amare maggiormente i nuovi arrivati nel suo amore.
(Cl. Geffré, Uno spazio per Dio)
Il tuo occhio è malvagio, perché io sono buono?
La vigna sono i precetti e i comandi di Dio, il tempo della fatica, la vita presente; gli operai quelli che in modo diverso sono chiamati a compiere i precetti; quelli venuti al mattino, all’ora terza, alla sesta, alla nona e all’undicesima ora sono quelli che sono giunti [alla fede] in età diverse e si sono fatti onore. Ma ciò che è da indagare è se i primi, che si sono splendidamente distinti e sono stati graditi a Dio e che per tutto il giorno hanno brillato per le loro fatiche, si lasciano dominare da quel male estremo della malvagità che è dato dall’invidia e dalla gelosia.
Vedendo infatti che quelli avevano usufruito della stessa ricompensa, dicono: «Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e del caldo» (Mt 20,12). E sebbene non ricevessero alcun danno e il loro compenso non fosse diminuito, si dispiacevano e si irritavano per i beni altrui, cosa che è propria dell’invidia e della gelosia. E il fatto più importante è che il padrone, che aveva preso le difese di quelli e si era giustificato dinanzi a chi aveva parlato in questi termini, lo condanna per la sua malvagità e la sua estrema invidia, dicendo: «Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene! Io voglio dare anche a quest’ultimo come a te. Forse il tuo occhio è malvagio perché io sono buono?» (Mt 20,13-15). Che cosa si ricava da queste parole? Quella stessa cosa che possiamo vedere anche in altre parabole. Infatti il figlio stimato per la sua buona condotta viene presentato con gli stessi sentimenti quando vede che il fratello dissoluto riceve molti più onori di lui (cfr. Lc 15,28). Come quelli godettero di un bene maggiore ricevendo la ricompensa per primi, così anche quello veniva onorato di più per l’abbondanza dei doni e lo testimonia il figlio dalla buona condotta.
(GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento al vangelo di Matteo, om. 64,3, PG 58,612-613).
Il ricco e il povero
C’era una volta due fratelli; uno molto ricco, l’altro molto povero. Un giorno il povero faceva la guardia ai covoni di grano ammucchiati nel campo del fratello ricco e mentre se ne stava lì seduto sul covone scorse una donna in bianco che raccoglieva le spighe rimaste nei campi mietuti e le aggiungeva ai covoni. Quando la donna giunse fino a lui, la prese per mano, se la tirò vicino e le chiese che cosa facesse lì. “Sono la Felicità di tuo fratello e raccolgo le spighe rimaste, perché il suo grano sia ancora più abbondante.” “Dimmi, allora, e la mia felicità, dov’è?” replicò il poveretto. “verso Oriente” rispose la donna, e scomparve.
Fu così che il povero si mise in testa di andare per il mondo in cerca della propria Felicità. E quando un giorno di buonora stava per mettersi in viaggio, dal suo camino saltò fuori la Miseria e piangeva e pregava che la prendesse con sé. “Mia cara, – disse il povero sei troppo debole per affrontare un viaggio così lungo, non ce la faresti mai; ma qui c’è una boccetta vuota, fatti piccina, infilatici dentro e ti porterò con me”. La Miseria s’infilò nella boccetta e lui senza perdere tempo la tappò con un turacciolo e l’avvolse bene in modo che non si rompesse.
Quando si trovò per via, appena arrivò a un pantano tirò fuori la boccetta e la gettò via, liberandosi così dalla Miseria.
Dopo qualche tempo giunse a una grande città e un certo signore lo prese al suo servizio con l’incarico di scavargli uno scantinato. “Non riceverai del denaro, – gli disse ma tutto ciò che trovi scavando è tuo”.
Dopo un po’ che scavava trovò un lingotto d’oro, secondo gli accordi gli sarebbe spettato, ma lui ne diede una metà al signore e riprese il lavoro. Arrivò finalmente a una porta di ferro, l’aperse e vi trovò un sotterraneo pieno di ogni ricchezza. Ed ecco che da una cassa lì sotto s’udì una voce: “Mio signore, aprimi! Aprimi!”. Egli spostò il coperchio e da dentro saltò fuori una bella fanciulla tutta in bianco che s’inchinò davanti a lui e gli disse: “Sono la tua Felicità, quella che hai cercato così a lungo; d’ora innanzi sarò vicina a te e alla tua famiglia”. Dopo di che scomparve. Egli rimase poi a guardarsi intorno e a rimirare quella ricchezza con il suo signore di una volta e da quel momento fu immensamente ricco e la sua fama cresceva di giorno in giorno. Eppure non dimenticò mai l’indigenza di un tempo e si prodigò in tutti i modi per aiutare i poveri del luogo.
Un giorno, mentre passeggiava per la città, incontrò il fratello che si trovava da quelle parti per affari. L’invitò a casa e gli raccontò con tutti i particolari le sue avventure e che aveva visto la Felicità spigolare nel campo di grano e come s’era liberato della propria Miseria e altro ancora. L’ospitò per qualche giorno e quando il fratello stava per partire gli diede molto denaro per il viaggio, fece molti doni alla moglie e ai figli e si separò da lui fraternamente.
Ma suo fratello era un uomo sleale e invidiava la Felicità dell’altro. Da quando aveva lasciato la sua casa non faceva che pensare come far tornare il fratello nella Miseria. Non appena giunse alla palude dove il fratello aveva ficcato la boccetta, si mise a cercarla e non si dette pace finché non la trovò. L’aperse subito. La Miseria saltò fuori immediatamente, cominciò a crescere davanti ai suoi occhi, saltargli intorno, l’abbracciò, lo baciò e lo ringraziò di averla liberata da quella prigionia. “Sarò sempre grata a te e alla tua famiglia e non vi abbandonerò fino alla morte”.
Inutilmente il fratello invidioso cercò di dissuaderla, invano la mandava dal suo padrone di una volta; non riuscì in nessun modo a togliersi la Miseria di dosso, né a venderla né a regalarla né a sotterrarla né ad annegarla, gli stette sempre alle calcagna. I briganti lo derubarono della merce che stava portando a casa; riuscì a ritornare chiedendo l’elemosina; al posto del suo palazzo trovò un mucchio di cenere e tutto il suo raccolto era stato portato via da una inondazione. Fu così che al fratello invidioso non rimase null’altro che… la Miseria.
(da: Fiabe di Praga magica, Arcana ed., 1993).
Quando sei chiamato, va’
Tu, quando sei chiamato, va’.
Sei chiamato a mezzogiorno? Va’ a quell’ora.
È vero che il padrone ti ha promesso un denaro anche se vai nella vigna all’ultima ora, ma nessuno ti ha promesso se vivrai fino alla prima ora del pomeriggio. Non dico fino all’ultima ora del giorno, ma fino alla prima ora dopo mezzogiorno.
Perché dunque ritardi a seguire chi ti chiama? Sei sicuro del compenso, è vero, ma non sai come andrà la giornata.
Vedi di non perdere, a causa del tuo differire, ciò che egli ti darà in base alla sua promessa.
(Agostino D’Ippona, Discorso 87, 6.8).
Non desiderare le cose altrui
“Se stai cercando di darti delle arie con chi sta in alto, scordatelo. Ti guarderanno dall’alto in basso comunque. E se stai cercando di darti delle arie con la gente che sta in basso, scordatelo lo stesso. Ti invidieranno e basta. Gli status-symbol non ti porteranno da nessuna parte. Solo un cuore sincero ti permetterà di stare alla pari con tutti.” […] “Fa’ il genere di cose che ti vengono dal cuore. Quando le farai, non ne resterai insoddisfatto, non sarai invidioso; non desidererai le cose altrui. Al contrario, sarai sommerso da quel che ti verrà in cambio.”
(Mitch ALBOM, I miei martedì col professore, Milano, Rizzoli, 2006, 132-133).
Non andare via, Signore
Quando trovi chiusa la porta del mio cuore,
abbattila ed entra: non andare via, Signore.
Quando le corde della mia chitarra dimenticano il tuo nome,
ti prego, aspetta: non andare via, Signore.
Quando il tuo richiamo non rompe il mio torpore,
folgorami con il tuo dolore: non andare via, Signore.
Quando faccio sedere altri sul tuo trono,
o re della mia vita: non andare via, Signore.
(Rabindranath Tagore)
Il Signore è buono ed accoglie l’ultimo come il primo
«Chi ama il Signore si rallegri in questa festa bella e luminosa!
Il servo fedele entri lieto nella gioia del suo Signore!
Chi ha atteso questo giorno nella penitenza riceva ora la sua ricompensa.
Chi ha lavorato fin dalla prima ora, riceva oggi il salario che gli è dovuto.
Chi è arrivato dopo la terza ora, sia lieto nel rendere grazie.
Chi è giunto dopo la sesta ora, non dubiti, non avrà alcun danno.
Chi ha tardato fino alla nona ora, venga senza esitare.
Chi è arrivato all’undicesima ora, non creda di essere venuto troppo tardi.
Perché il Signore è buono ed accoglie l’ultimo come il primo.
Concede il riposo all’operaio dell’undicesima ora come a quello della prima ora.
Ha misericordia dell’ultimo e premia il primo.
Al primo dà, all’ultimo regala.
Apprezza le opere di ciascuno, loda ogni intenzione.
Entrate tutti, dunque, nella gioia del nostro Signore;
primi e secondi, ricevete tutti la ricompensa;
ricchi e poveri, danzate insieme;
sia che abbiate digiunato, sia che abbiate fatto festa,
siate tutti nella gioia, onorate questo giorno!
Il banchetto è pronto, godetene tutti!
Il cibo è abbondante, basterà per tutti, nessuno se ne andrà affamato.
Gustate tutti il banchetto della fede.
Gustate tutti la larghezza della bontà.
Nessuno pianga la sua miseria:
il regno di Dio è aperto a tutti. Nessuno tema la morte, perché la morte del Salvatore ci ha liberati.
Dominato dalla morte, egli l’ha spenta.
Il Cristo è risorto e regna la vita!
A lui la gloria e la potenza per i secoli dei secoli. Amen».
(Annuncio pasquale della Chiesa orientale)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Lezionario domenicale e festivo. Anno A, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007.
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 92 (2011) 5, 42 pp.
– COMUNITÀ DI BOSE, Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno A, Milano, Vita e Pensiero, 2010.
– Fernando ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità, Anno A, Padova, Messaggero, 2001.