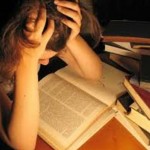Prima lettura: Isaia 5,1-7
|
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate; in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna.
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi.
|
Il richiamo della vigna e delle premure del padrone nei suoi confronti ha un noto antecedente nell’Antico Testamento, come testimonia il brano di Isaia, scelto come prima lettura. Questo piccolo poema è un autentico gioiello della letteratura universale.
Un valido cantore intona questo canto per il suo amico che ha avuto una vicenda dolorosa con la sua vigna. L’inizio fa echeggiare note di amore che celebrano la premurosa sollecitudine di un uomo nei confronti della sua vigna (vv. 1-2). Poi il cantore si tira in disparte e prende il suo posto lo stesso interessato che convoca gli abitanti di Gerusalemme come testimoni e proclama il suo totale impegno (vv. 3-4). Nella terza parte, cambiando decisamente registro, troviamo una requisitoria e una condanna verso Israele, presentato in forma criptata nella figura della vigna (vv. 5-7).
La cura amorosa per la vigna è espressa con la scelta di vitigni che danno l’uva vermiglia, una qualità ancora oggi molto apprezzata nel vicino Oriente per i suoi rubicondi grappoli. Oltre a ciò, alcuni interventi quali l’asportazione di pietrame e la costruzione di una torre difensiva erano garanzia di un frutto di qualità. Inaspettatamente, il risultato deludente contraddice tanta passione e tanto sforzo: i grappoli presentano solo agresta, un tipo di uva ad acini piccoli, fibrosi e per di più asprigni, così da allegare i denti.
Concluso lo status quaestionis, la scena si trasforma da amorosa in giudiziale. Ci sono tutte le premesse: lo stesso danneggiato prende la parola, espone il caso negativo (produzione di uva selvatica), cita i testimoni, dichiara il proprio stato di innocenza.
La reazione, che è altresì una punizione, serve a scoprire le carte. Dopo le cure infruttuose, ecco lo stato di abbandono (eliminazione della siepe e abbattimento del muro di cinta) che rende la vigna proprietà selvaggia di presenze indesiderate (animali e erbe male). Il vertice della narrazione è raggiunto con l’identificazione dei contendenti. Da una parte sta l’amato tradito che è Dio in quanto è colui che può comandare alle nubi di non far piovere (cf. v. 6) e dall’altra la vigna che è il popolo di Israele che produce grappoli amari di malvagità, espressa sinteticamente come «spargimento di sangue» e «grida di oppressi» (v. 7). Nonostante tutte le premure di Dio, l’elezione, la protezione dai suoi nemici e altro ancora, il popolo non ha realizzato le aspettative del suo Dio. Davvero una vigna ingrata, incapace di relazionarsi correttamente con chi l’ha tanto amata.
Seconda lettura: Filippesi 4,6-9
|
Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi!
|
Verso la parte finale della lettera alla comunità di Filippi, Paolo si attarda in una serie di raccomandazioni. Aveva esortato ad una gioia ben fondata perché il Signore era vicino. La sua vicinanza funge da deterrente contro ansie incontrollate. Chi lascia operare nella propria vita la semplice parola ‘il Signore è vicino’, esperimenta già ora la pace di Dio. Paolo non pensa tanto alla pace tra gli uomini, ma alla calma interiore del cuore, che ha il suo fondamento nelle promesse di Dio. Il cristiano che organizza la propria esistenza alla luce di Cristo, non si lascia irretire da lacci che frenano il suo impegno o che smorzano la sua serenità di fondo.
Paolo non fa mistero circa le reali e spesso dure difficoltà dell’esistenza cristiana ed è già stato chiaro, alludendo fin dall’inizio alle sue catene (cf. 1,13). È pure convinto che non giova lasciarsi prendere da ansiose inquietudini (cf. lo stesso verbo di Mt 6,25.31 dove si raccomanda un sincero abbandono alla Provvidenza) che bloccano e rendono improduttivi. Positivamente, tutto prende senso e valore nella comunione con Cristo/Dio di cui la «pace» del v. 7 è la sacramentalizzazione. La fiducia in Dio si concretizza nel manifestare a lui la nostra situazione, attraverso «preghiere, suppliche e ringraziamenti». Non è certo un ‘far conoscere’ qualcosa che non sa, ma è il modo per l’uomo di mantenere il filo diretto con Dio, nel dialogo di amore, nel sereno abbandono alla sua volontà, nella fiduciosa attesa davanti a lui. Colui che è capace di pregare e di ringraziare depone il suo affanno in Dio.
La formula «in conclusione» del v. 8 raccoglie un insieme di ammonimenti che appartenevano alla sapienza classica. Passiamo ora, dopo le pennellate teologiche, ad affreschi di tutto rispetto ma nell’ordine della normalità. E questo non dispiace. Il cristiano non è pensato come un abitante della stratosfera dello spirito, bensì come un essere incarnato che, partendo dalle virtù umane, risponde agli impulsi dello spirito per tendere alla perfezione. Non ci sarà santità di vita senza una piattaforma di sana ‘normalità’. Per questo un elenco di 8 virtù invita a ricercare e a perseguire «quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode». Le prime quattro indicano valori etici e spirituali individuali, le altre quattro invece, a due a due, sottolineano di più l’aspetto pubblico e sociale. Il cristiano è capace di valorizzare tutto, di integrare i valori proposti dai pagani e dai giudei e di inserirli in una sintesi superiore.
Paolo rimanda ancora al proprio esempio, concretizzazione di vita cristiana alla quale i Filippesi possono ispirarsi perché l’hanno, almeno in parte, sperimentata personalmente. Per loro Paolo, in quanto apostolo, rimane il collegamento diretto e sicuro con Cristo.
Con la promessa benedicente «Il Dio della pace sarà con tutti voi!» si conclude il presente brano a carattere esortativo.
Vangelo: Matteo 21,33-43
|
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».
|
Esegesi
Cronologicamente siamo verso la fine della vita pubblica di Gesù, dopo il solenne ingresso nella città santa. Gli ultimi giorni terreni sono segnati da un conflitto sempre più aspro con i capi. Gesù ha già polemizzato con loro a proposito della sua autorità nel tempio (cacciata dei venditori) e pronosticato un rivoluzionario sorpasso («i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio», 21,31). In questo rovente clima giunge la nostra parabola che, con la successiva riguardante il banchetto, rincara la dose arrivando addirittura all’esclusione dei capi giudei.
La parabola ha un canovaccio particolare. La minuta esposizione imbastita sui generosi interventi del padrone nei confronti della vigna e sulla feroce ostilità dei vignaioli produce una reazione immediata nell’uditorio, pronto a condannare un comportamento inqualificabile. Gli ascoltatori non si avvedono però che le loro parole sono un’autocondanna. Gesù raccoglie e fa proprio il loro giudizio orientando il senso della parabola in chiave d’istologica e pasquale.
Possiamo allora ravvisare questo schema:
vv. 33-39: esposizione del racconto parabolico;
vv. 40-41: domanda di Gesù e risposta (autoaccusa) degli ascoltatori;
vv. 42-43: prospettiva cristologica e passaggio di consegne da un popolo improduttivo a uno produttivo.
1. Il canovaccio della parabola
I primi destinatari delle parole di Gesù sono i principi dei sacerdoti e gli anziani del popolo (cf. 21,23), coloro che dovevano guidare il popolo sui sentieri di Dio. Di fatto, loro stessi si sono smarriti sui viottoli di un bieco interesse personale.
L’azione del padrone è minuziosamente descritta con una raffica di sette verbi («piantò, circondò, scavò, costruì, affidò, andò, mandò») di cui i primi cinque sono direttamente riferiti al rapporto padrone-vigna. Ne viene un itinerario dettagliato di appassionato amore. Si inizia dal fatto che il padrone pianta la vigna. Essa nasce quindi da una precisa volontà altrui. Sarebbe logico aspettarsi un profondo legame tra lei e colui che l’ha voluta. L’idea di dipendenza è arricchita da una serie di interventi che mostrano la cura che il padrone ha nei confronti della sua creatura. Dopo averla «generata» si premura di assicurarle un futuro prosperoso. Ecco le azioni di recinzione e di costruzione di una torre, con evidente intento difensivo. La costruzione del torchio nella stessa vigna è pure un atto di attenzione; è una vigna dove c’è tutto. Non occorre quindi trasportare il futuro raccolto da un’altra parte.
Il quarto verbo — «affidò» — sta ad indicare che il padrone non intende creare un monopolio nei confronti della vigna e associa altre persone come collaboratrici della sua opera. Consegna loro una situazione ottimale: vigna piantata e protetta, munita di tutto il necessario. Si tratta di continuare nella stessa linea, permettendo alla vigna di produrre e raccogliere il prodotto. In qualità di collaboratori, associati in un’opera da loro non fondata e ricevuta già ben avviata, devono anch’essi mantenere un legame di amorosa sudditanza nei confronti del padrone. Questi infatti se ne va, lasciando campo libero alla vigna e ai vignaioli.
Potrebbe sembrare che i punti di attenzione siano due: la produttività della vigna e la sollecitudine dei vignaioli nel favorire tale produttività. In realtà l’asse si sposta invece su un interesse che riguarda i vignaioli, perché non si fa parola sulla produttività della vigna, dando per acquisito l’esistenza dei frutti. Tutto l’interesse della parabola è fissato sul rapporto tra il padrone e i vignaioli a proposito della consegna del raccolto. Dal settimo verbo riferito al padrone — «mandò» — scaturisce tutto lo sviluppo della parabola (cf. vv. 34-39). Ciò fa capire che la punta polemica della parabola è rivolta verso i capi («principi dei sacerdoti e anziani del popolo») citati all’inizio.
L’esigenza del padrone di ritirare il raccolto è legittima e secondo le regole dell’epoca. Non si dice che lui voglia tutto il raccolto, costringendo i lavoratori alla fame. Possiamo ipotizzare qui una saggia regola della mezzadria e perciò anche i lavoratori partecipano alla rendita della vigna. Ciò che qui viene esplicitato, quindi degno di nota, è il rifiuto totale di consegnare qualche frutto al padrone, delegittimando così la sua autorità. I vignaioli infatti dimostrano un rifiuto totale e violento che diventa aggressione e uccisione dei servi inviati allo scopo d’impossessarsi dei frutti.
Anche qui troviamo un elenco di verbi che pubblicizzano i sentimenti dei lavoratori che si sono impossessati dei servi del padrone («presero»), compiendo azioni violente: «bastonarono, uccisero, lapidarono».
Il padrone è doppiamente danneggiato: non riceve i frutti della vigna e perde i suoi servi. Tuttavia mostra magnanimità nell’inviare altri servi, in numero maggiore dei primi. Stesso risultato fallimentare. Egli compie un ultimo tentativo, con l’invio del proprio figlio. Pure in questo caso, la sorte è analoga: espulsione dalla vigna e uccisione. I mezzadri non vogliono riconoscere alcuna autorità e si pongono come antagonisti nei confronti del padrone, usurpando la sua proprietà e uccidendo le persone che gli appartengono.
Come sempre succede nelle parabole, anche qui l’attenzione è posta sull’ultimo elemento, l’invio del figlio. L’importanza è ben messa in evidenza anche dalla duplice riflessione — del padrone e dei vignaioli — che permette al lettore di accedere ai sentimenti più profondi dei protagonisti. È un’introspezione psicologica che rivela i meccanismi profondi delle scelte e dello stile di vita. Il padrone è presentato come PADRE che investe tutto sul FIGLIO, pensando che a questo punto termini la furia omicida dei suoi dipendenti e che si rendano conto dei loro obblighi, riconoscendo così la legittima autorità. I vignaioli sanno bene che il figlio è l’EREDE e pensano di eliminarlo per entrare in possesso della vigna. Il loro pensiero denuncia un preciso piano: c’è in loro una lucida e programmata malvagità.
Qui termina la parte espositiva della parabola. Potrebbe suonare un po’ irreale (l’uccisione di coloro che vengono a riscuotere), se non fosse in filigrana la tragica vicenda che vede coinvolto Gesù. Egli è il figlio che «patì fuori della porta della città» (Eb 13,12) e che fu ucciso. E prima di lui tanti profeti hanno vissuto una sorte analoga.
Un aspetto abbastanza originale della parabola è la chiara domanda posta da Gesù ai suoi uditori (v. 40) e l’altrettanto chiara la risposta dei suoi uditori che non hanno titubanze nell’esecrare il comportamento dei vignaioli prospettando una drastica soluzione: «li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo» (v. 41). La prima parte della risposta riguarda la condanna di collaboratori indegni, sottoposti al supplizio da loro applicato a coloro che venivano a riscuotere (una specie di legge del taglione). La seconda parte, positiva, prospetta il corretto atteggiamento di collaboratori fedeli, pronti a consegnare i frutti al legittimo proprietario.
I poveri ascoltatori non si avvedono che la parabola è diretta contro di loro. Proprio perché sono liberi da condizionamenti e da pregiudizi convengono sulla necessità di punire gli empi mezzadri e di sostituirli con altri onesti e corretti.
L’immagine della vigna attinge i suoi colori ad una tavolozza tante volte impiegata nel mondo biblico, basti ricordare il cap. 5 di Isaia (cf. prima lettura) e il Salmo 80 (79). La vigna era una rappresentazione del popolo di Israele. Il padrone che pianta e cura la vigna era l’icona del comportamento di Dio. I vignaioli omicidi sono i capi che hanno rifiutato di essere il legittimo tramite tra Dio e la sua vigna. Su di loro si abbatte la scure di un giudizio senza appello.
2. La prospettiva cristologica
Gesù riprende in mano le redini del discorso a cui imprime una chiara svolta cristologica e pasquale. La citazione del Sal 118 (117), 22-23 sposta l’asse di interesse dal rapporto padrone-vignaioli a quello di accoglienza-rifiuto di Cristo. È lui la pietra di cui parla il salmo. Una pietra apparentemente senza valore, tanto da essere gettata dai costruttori perché ritenuta inutile, ma presa da Dio per diventare un punto di forza di tutta la costruzione. Il rapporto di Dio con gli uomini ha avuto il suo punto culminante con l’incarnazione, che è l’invio del figlio fatto carne, dell’erede che chiamava tutti gli uomini a diventare eredi del padre celeste. Lui non è stato accolto e gli è stata riservata una sorte analoga a quella dei profeti, condannandolo a morte. L’idea che siano i capi i primi e principali responsabili della sua morte affiora anche altrove nel vangelo (cf. Lc 24,20). Il rifiuto di Cristo è l’atto supremo di malvagità che squalifica una persona, facendole perdere l’occasione unica e irripetibile della sua vita. Per questo occorre ripristinare una nuova relazione.
Per fortuna, o meglio, per grazia, esiste qualcun altro con il quale è possibile ricominciare. Il brano termina positivamente con la prospettiva di un popolo capace di far fruttificare il regno di Dio. Ciò grazie all’opera salvifica di Cristo che culmina nel mistero pasquale. La sua morte è premessa e condizione di vita nuova che crea un popolo capace di opere degne e soprattutto di un rapporto filiale con Dio.
Meditazione
Isaia e Matteo sottolineano il tema del fare: c’è un fare di Dio che attende un fare umano come risposta; in particolare, attende da parte della vigna-Israele un fare frutti adeguati. La prassi dei credenti è un fare frutto: si tratta di entrare in una relazione che dona fecondità. L’agire cristiano, pastorale in specie, rischia spesso la cecità dell’attivismo, la pigrizia della forza d’inerzia, l’insipienza di chi ha «freddo il senso e perduto il motivo dell’azione» (Thomas Stearns Eliot). Il raffreddarsi della carità (Mt 24,12) si può accompagnare a un fare dissennato, indiscreto e senza discernimento. La fede nel fare di Dio per l’uomo, dunque nel suo amore, è il fondamento dell’agire del credente.
Il fare di Dio per la sua vigna è un lavorare (Is 5,2) che ne esprime l’amore (Is 5,1). L’amore è un lavoro, una fatica: la «fatica dell’amore» ( 1Ts 1,3). Anche per l’uomo, lungi dall’essere un’attività facile e immediata, l’amore è un lavoro che esige un’ascesi. La maturità umana trova nella capacità di lavorare efficacemente e di amare in modo adulto due elementi qualificanti decisivi.
L’amore divino nutre un’attesa nei confronti dell’amato: non attende amore di ritorno, ma giustizia (Is 5,7). La giustizia umana onora l’amore di Dio. L’amore che attende qualcosa dall’amato esercita una dolce violenza, ma un amore che non attenda nulla dall’amato è semplicemente irreale.
Prima lettura e vangelo sono brani di teologia della storia, di rilettura della storia alla luce della fede. Isaia parla dell’agire di Dio verso il suo popolo e la parabola evangelica rilegge la storia degli invii dei profeti e del loro rigetto da parte del popolo, fino all’invio del Figlio. Emerge la difficoltà di discernere il servo di Dio, il profeta. L’alterità insostenibile di Dio diviene l’alterità del profeta che si traduce nella sua presenza scomoda, imprevedibile, non racchiudibile in etichette del tipo «progressista» o «conservatore». Uomo del pathos di Dio, le reazioni del profeta agli eventi storici ed ecclesiali sfidano il buon senso comune e il comune sentire religioso e appaiono di volta in volta eccessive, non allineate, sproporzionate, difficilmente comprensibili, trascurabili, ininfluenti. Ed egli stesso viene sentito spesso come insopportabile o deriso come sognatore o considerato come presenza di cui si può tranquillamente non tener conto alcuno.
L’atteggiamento dei contadini a cui è affidata la vigna (Mt 21,33-39) denuncia un pericolo perenne nella comunità cristiana: l’occupazione dello spazio ecclesiale da parte di chi vi esercita una leadership (Mt 21,38). Questo avviene quando un gruppo di persone che rivestono ruoli dirigenti nella chiesa assolutizza la propria visione e cerca di far divenire norma generale le proprie opzioni.
La parabola pone di fronte all’enigma della violenza che può scandalosamente farsi presente in uno spazio religioso. Nell’alveo ecclesiale la violenza non riveste normalmente forme clamorose come la violenza fisica, ma più sottili come il non ascolto, il rifiuto, l’emarginazione, il disprezzo, la non accoglienza, il disinteresse, la pressione e l’abuso psicologico.
Avviene così che l’agire di Dio, che fa dello scarto umano il fondamento della storia di salvezza (Mt 21,42), sia contraddetto dall’agire ecclesiale che crea scarti e produce emarginati. Questo l’agire di Dio: «Dio sceglie ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato» ( 1Cor 1,28). Questo lo scandaloso agire messianico, e questo è chiamato a essere l’agire dei messianici, i «cristiani».
Lo stupore e lo scandalo che suscita in noi l’agire del padrone della vigna che, dopo avere visto tanti suoi servi subire una sorte violenta, infine invia il figlio, quasi sottovalutando il rischio, è indice della nostra distanza dal pensare di Dio, dalla radicalità del suo amore, dalla follia della sua gratuità.
Il passaggio della vigna a un popolo che la farà fruttificare non è un giudizio sulla vigna-Israele, ma sui suoi capi, ed è anche invito e ammonimento, agli «eredi» a essere fecondi. Nessun sostituzionismo (i vignaioli non si sostituiscono alla vigna!): nessuna idea di chiesa come nuovo o vero Israele scaturisce dal testo.
Preghiere e racconti
Curare la vigna è come curare la vita
Da ragazzo, all’età delle medie e delle superiori, ogni giorno per andare a scuola, all’andata come al ritorno, dovevo camminare mezz’ora tra le vigne, unica visione per i miei occhi sotto il cielo, unico scenario per i miei pensieri e le mie apprensioni scolastiche. Cosi ho imparato a conoscerle, a osservare i loro cambiamenti, ad amarle. La mia terra è tutta vigne, solo qua e là, ai bordi delle strade, un canneto che forniva i sostegni per le viti in quegli ordinati filari che segnavano i diversi anfiteatri collinari e sembravano sfidare la pendenza dei bricchi: filari disposti come oggetti preziosi in un’esposizione, ciascuno scostato dall’altro quel tanto necessario per essere visto e baciato dal sole.
D’inverno le vigne appaiono desolate, solo ceppi che con le loro torsioni sembrano ribellarsi all’ordine severo dei filari: le diresti morte, soprattutto quando lo scuro del vitigno si staglia sul bianco della neve, assecondando quel silenzio muto dell’inverno in cui persino il sole fatica a imporsi tra le nebbie del mattino. Eppure, anche in questa stagione morta, i contadini non cessano di visitare la vigna e si dedicano a quel lavoro sapiente di potatura che richiede un affinato discernimento. Si tratta, infatti, di mondarla, tagliando alcuni tralci e lasciando quelli che promettono maggiore fecondità: sacrificarne alcuni, che magari tanto hanno già dato, per il bene della pianta intera, rinunciare a un tutto ipotetico per avere il meglio possibile. Bisogna osservarli i vignaioli quando potano, mentre il freddo arrossa il naso e le guance; bisogna vedere come prendono in mano il tralcio, come i loro occhi scrutano e contano le gemme, come con le pinze danno un colpo secco che recide il tralcio con un suono che echeggia in tutta la vigna: un taglio che sembra un colpo di grazia spietato al culmine di una sentenza e che invece è colpo di grazia perché apre un futuro fecondo. E li, dove la ferita vitale ha colpito la vigna, proprio li, ai primi tepori, la vite «piange», versando lacrime da quel tralcio potato per un bene più grande. Curare la vigna è come curare la vita, la propria vita, attraverso potature e anche pianti, in attesa della stagione della pienezza: per questo la potatura è un’operazione che il contadino fa quasi parlando alla vite, come se le chiedesse di capire quel gesto che capire ancora non può.
(Enzo BIANCHI, Il pane di ieri, Torino, Einaudi, 2008, 53-54).
Io sarò vigna
Vorrei che poteste vivere della fragranza della terra, e che la luce vi nutrisse in libertà come una pianta.
Quando uccidete un animale, ditegli nel vostro cuore: « Dallo stesso potere che ti abbatte io pure sarò colpito e distrutto, poiché la legge che ti consegna nelle mie mani, consegnerà me in mani più potenti.
Il tuo sangue e il mio sangue non sono che la linfa che nutre l’albero del cielo ».
E quando addentate una mela, ditele nel vostro cuore: « I tuoi semi vivranno nel mio corpo, e i tuoi germogli futuri sbocceranno nel mio cuore, la loro fragranza sarà il mio respiro, e insieme gioiremo in tutte le stagioni ».
E quando in autunno raccogliete dalle vigne l’uva per il torchio, dite nel vostro cuore: «Io pure sarò vigna, e per il torchio sarà colto il mio frutto, e come vino nuovo sarò custodito in vasi eterni ».
E quando d’inverno mescete il vino, per ogni coppa intonate un canto nel vostro cuore, e fate in modo che vi sia in questo canto il ricordo dei giorni dell’autunno, della vigna e del torchio.
(K. GIBRAN, Il Profeta)
Continuate a esortarli finché vengano alla fede
Cristo «ci ha affidato il ministero della riconciliazione» (2Cor 5,18). Di nuovo con queste parole Paolo mostra la grandezza degli apostoli indicando quale ministero è stato loro affidato e contemporaneamente la sovrabbondanza dell’amore di Dio. Egli non si è adirato né ha abbandonato gli uomini per il fatto che non avevano ascoltato il suo inviato, ma persevera nell’esortare da se stesso o per mezzo di altri. Chi si meraviglierebbe a sufficienza dinanzi a tale sollecitudine? È stato ucciso il Figlio, il vero Unigenito venuto a riconciliare gli uomini con Dio, e il Padre non ha voltato le spalle a quelli che l’hanno ucciso; non ha detto: «Ho inviato mio figlio quale mediatore, e loro non solo non hanno voluto ascoltarlo, ma l’hanno messo a morte e l’hanno crocifisso. È giusto che li abbandoni». Ha fatto proprio il contrario, e ora che Cristo ha lasciato la terra, l’incarico è stato affidato a noi. Ci ha affidato il ministero della riconciliazione poiché Dio stesso era in Cristo e ha riconciliato a sé il mondo non tenendo conto dei peccati degli uomini. Vedi l’amore che supera ogni pensiero, ogni intelligenza! Chi era stato offeso? Dio. Chi fa il primo passo verso la riconciliazione? Dio. […] Paolo dice: «Ci ha affidato il ministero della riconciliazione»; queste parole necessitano di una precisazione. Non pensate che questo potere risieda in noi; siamo servi, colui che opera tutto è Dio che si è riconciliato il mondo attraverso il suo unico Figlio. E come se lo è riconciliato? Questa è la cosa meravigliosa che non solo lo abbia amato, ma che l’abbia amato in questo modo. Come? Perdonando agli uomini i peccati; non v’era altro modo. Perciò Paolo aggiunge: «Non tenendo conto dei peccati degli uomini» (2Cor 5,19). […] «Ci ha affidato il ministero della riconciliazione» (2Cor 5,18). Non veniamo a voi per sottoporvi a un’opera faticosa, ma per fare di tutti gli uomini degli amici di Dio. Poiché non hanno ascoltato, ci dice il Signore, continuate a esortarli finché vengano alla fede. Perciò Paolo prosegue: «Fungiamo da ambasciatori per Cristo; è come se Dio vi esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor5,20).
(GIOVANNI CRISOSTOMO, Sulla seconda lettera ai Corinti 11,2-3, PG 61,476-477).
La tensione degli opposti
“La vita è una sorta di tiro alla fune. Vorresti fare una cosa, ma sei costretto a fare qualcos’altro. Qualcosa ti fa male, eppure tu sai che non dovrebbe. Prendi per scontate alcune cose, pur sapendo che non c’è nulla di scontato. “La tensione degli opposti, come un elastico che si tira. E quasi sempre stiamo da qualche parte, nel mezzo.” Sembra un incontro di pugilato, commento io. “Già, un incontro di pugilato”, ride lui. “Ecco, potresti proprio descrivere la vita così”. “Chi vince?” Mi sorride, e gli si formano le rughe intorno agli occhi, gli si scoprono i denti storti. “Vince l’amore. L’amore vince sempre”.
(Mitch ALBOM, I miei martedì col professore, Milano, Rizzoli, 2006, 47).
No, lui, io non l’ho conosciuto
Del resto, si interessava poco
a questo figlio sfortunato
che si rese antipatico
a tutti i poteri politici.
No, lui, io non l’ho conosciuto.
E tuttavia, suo figlio lo adorava,
diceva: io, ciò che spero
e augurerei a tutti
è di andare a vivere presso mio padre.
No, lui, io non l’ho conosciuto.
Non fece assolutamente nulla
per salvare questo figlio, un vero santo
che fu condannato ingiustamente
e morì fra atroci supplizi.
Ma lui, io non l’ho conosciuto.
(Norge, Suo figlio e lui)
Preghiera
O Padre, celeste vignaiolo che hai piantato sulla nostra terra la tua vite scelta – il santo germoglio della stirpe di David – e compi il tuo lavoro in ogni stagione.
Fa’ che accettiamo le potature di primavera, anche se, teneri tralci, gemiamo trasudando lacrime sotto i colpi decisi delle tue cesoie. Vieni pure a mondarci nel culmine della stagione estiva, perché i viticci superflui non sottraggano linfa vitale al grappolo che deve maturare.
Frutto della nostra vita sia l’amore, quel «più grande amore» che dal tuo cuore, attraverso il cuore di Cristo, con flusso inesauribile si riversa in noi. E tutti gli uomini, fratelli nostri nel tuo nome, ne siano ricolmati, con spirito di dolcezza, di gioia e di pace.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004;2007-.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– Comunità domenicana di Santa Maria delle Grazie, La grazia della predicazione. Tempo ordinario – Parte prima, in «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 95 (2014) 5, pp. 36.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Tempo ordinario anno A, Milano, vita e Pensiero, 2010.
– F. ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità. Anno A, Padova, Messaggero, 2001.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
PER L’APPROFONDIMENTO
XXVII DOM TEMP ORDINARIO