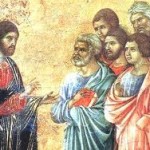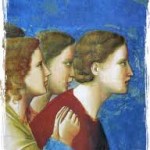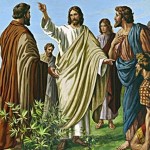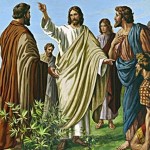
Prima lettura: Deuteronomio 30,10-14
|
Mosè parlò al popolo dicendo: «Obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e ti convertirai al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: “Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Non è di là dal mare, perché tu dica: “Chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica».
|
Ancora una volta è necessario retrocedere nella lettura per comprendere meglio il senso della pericope proposta nella liturgia. Bisogna leggere il v.6 dello stesso capitolo: «Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché tu ami il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima e viva».
A questa formula si ricollega il v 10 che apre la lettura e che richiede di convertirsi al Signore «con tutto il cuore e con tutta l’anima». La medesima formula ricorre in 6,5 ripresa nel vangelo come primo comandamento da osservare. Si tratta di un pensiero fondamentale sul quale il libro del Deuteronomio ricorre più volte insistendo sull’amore integrale a Dio in 10,12; 11,13; 13,3. In 26,16 invece lo stesso formulario viene usato per parlare dell’osservanza dei comandamenti di Dio e in 30,2 della conversione al Signore da attuare sempre «con tutto il cuore e con tutta l’anima». Potremmo così dire che la pericope che stiamo commentando assume un ruolo riassuntivo del messaggio del libro. È l’ultima volta che ricorre la formula appena ricordata prima: «con tutto il cuore e con tutta l’anima».
Il nostro brano vuole persuadere il lettore circa la praticabilità di quanto ha letto nell’intera opera. Il messaggio è impegnativo perché totalizzante, ma la pretesa radicale della teologia deuteronomista non rimane una utopia; è traducibile in vita. Il cielo era un punto inarrivabile per l’uomo di allora e il mare per un popolo come Israele estraneo alla navigazione, era inaccessibile. Le immagini servono per dire che non esistono barriere insormontabili tra la parola di Dio e il cuore umano. L’interiorizzazione della parola e dei precetti divini è un altro tema assai caro al Deuteronomio: 6,6; 11,18. Forse l’autore si aspetta che sia già stato attuato l’invito di Dio? Sarebbe ingenuo rispondere di sì. Il profeta Geremia non estraneo alla teologia deuteronomista dirà chiaramente che questo non può avvenire che per dono divino: Ger 31,31-34. Anche il profeta Ezechiele annuncia la promessa della interiorizzazione della legge come dono concesso da Dio: 11,19-20; 36,27. Siamo dunque con il brano in questione agli albori di una tradizione che porterà alle prospettive profetiche appena ricordate? Non è facile rispondere. Bisognerà accontentarsi soltanto di accogliere questa affermazione della presenza interiore della parola di cui la pericope non ci dice con chiarezza a chi attribuirla. L’unica cosa che per ora interessa all’autore è evitare al suo lettore la tentazione di ritenere il suo messaggio impraticabile, mentre invece è una realtà già misteriosamente presente in lui. San Paolo riprenderà il contenuto di questa lettura in Rm 10,6-8.
Seconda lettura: Colossesi 1,15-20
|
Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.
|
Il noto inno cristologico che viene proposto oggi come seconda lettura è molto probabilmente di composizione anteriore alla lettera cui appartiene. Può essere una testimonianza della liturgia della comunità della chiesa apostolica, un testo noto ai colossesi che può così diventare ottimo strumento di catechesi. La sua posizione iniziale nella lettera pertanto non vuole essere semplicemente celebrativa, ma fondante il messaggio teologico che l’autore darà nel suo scritto.
L’inno è facilmente divisibile in due parti: i vv. 15-17 illustrano il rapporto esistente tra Cristo e il creato, Egli viene presentato qui come il mediatore della creazione. Nei vv. 18-20 viene presentato il ruolo di Cristo in merito alla redenzione umana.
La prima parola con la quale Cristo viene indicato è «immagine». Per capirne il senso in modo pertinente bisognerebbe ricollocarsi nella cultura ellenistica secondo la quale l’immagine, pur restando distinta dal suo archetipo, ne costituiva una manifestazione reale. In termini semplici si può dire che la relazione tra immagine e realtà rappresentata era assai più stretto che non nella nostra cultura. Eb 1,3 che definisce Gesù rispetto al Padre come «irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza» costituisce una resa scritturistica di quanto è appena stato detto. Si vede così come Gesù sia una immagine assolutamente nitida di Dio, che lo rende visibile in modo chiaro; distinto dal Padre, ma sua riproduzione fedelissima. Il Dio che Gesù ci presenta era prima caratterizzato dall’invisibilità: 1Tim 1,17; 6,16; Gv 1,18; 6,46; 1Gv 4,12. Ora c’è una svolta decisiva perché nel Figlio il Padre si rende visibile: Gv 1,18; 14,9. A dire il vero esisteva già nell’ordine del creato un’immagine di Dio, era l’uomo stesso come dice bene Gn 1,26-27, convinzione che riecheggia in 1Cor 11,7; Col 3,10.
Si tratta di una immagine che non si colloca sul piano dell’identità, né su quella dell’approssimazione. Un’immagine tuttavia insufficiente per una piena conoscenza di Dio e per la scoperta del progetto autentico del creato. Gesù, apparso in forma umana (cf. Fil 2,27), assolve entrambe i compiti: rendere visibile il Padre e comprensibile il progetto creatore.
Egli è lo strumento della creazione, pensiero che Paolo aveva già manifestato in 1Cor 8,6 e che ritroviamo come convinzione della comunità apostolica anche in Gv 1,3 e Eb 1,2. Soprattutto Gesù è il fine per il quale il mondo viene creato. L’inno svela così che fin dall’inizio vi è un obiettivo positivo dal momento che tutto viene creato in vista di Cristo. Il modello che il Padre ha davanti a sé nella creazione del mondo e dell’uomo è il suo unigenito; e il fatto che il Padre dia al Figlio questa attenzione nella progettazione del creato fa sì che Cristo non sia più solo «l’unigenito», ma diventi anche «il primogenito» come sottolineano i vv. 17-18. Il primo si colloca ancora semplicemente nell’ordine creaturale, il secondo ormai nell’ordine nuovo stabilito da Cristo con la sua risurrezione. Vi è dunque per Cristo un primato antecedente e uno conseguente. Il suo primato antecedente (vv. 15.17) sta nel fatto che viene scelto dal Padre come modello e strumento del creato; il suo primato conseguente invece nel fatto che la sua risurrezione inaugura la sua signoria universale sull’umanità rigenerata dal suo mistero pasquale. Tutto questo, come dice il v. 19 appartiene alla volontà di Dio. Il verbo «piacere» indica infatti le decisioni di Dio in merito al piano salvifico (Mt 11,26; Lc 10,21; 12,32; 1Col 1,21). La volontà del Padre ha poi un contenuto ancora più preciso: stabilire in Cristo ogni pienezza. In 2,9 si dirà che «in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità». È una spiegazione esaustiva. La pienezza di Cristo è pienezza di vita che si partecipa al creato in quanto vi è in lui pienezza di divinità. Il v. 20 ci riporta sul piano storico per mostrarci come si è consumata l’opera di Gesù.
Dopo i termini grandi e speculativi ne troviamo ora due concretissimi e cruenti: sangue e croce. Sono le modalità reali in cui la riconciliazione si è consumata rendendo Cristo sintesi vitale e vivificante. Come esisteva un orizzonte universale per la mediazione creatrice, esiste anche un ordine universale ed ultraterreno per l’efficacia redentrice. Il raggio universale dell’opera realizzata da Gesù mediante la croce e chiamata riconciliazione è un tema caro all’innografia cristiana originaria come attesta anche la lettera agli Efesini: 1,10; 2,14.16.
Vangelo: Luca 10,25-37
|
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».
|
Esegesi
Il brano a nostra disposizione si divide chiaramente in due parti. La prima occupa i vv. 25-28 e si concentra sulla necessità di mettere a fuoco le cose più importanti da fare per avere la vita eterna. La seconda parte occupa i vv. 29-39 per spiegare in un modo concretissimo la focalizzazione dell’unità precedente.
I vv. 25-28 trovano un parallelo in Mt 22,34-40 e Mc 12,28-31. In quei due passaggi si sente però il sapore di una disputa tra scuole teologiche, la necessità di trovare nell’oceano di una precettistica sofisticata almeno l’essenziale. Siamo nell’ambito di un orientamento teorico in cui la parola di Gesù diventa decisiva. È lui infatti a dare la risposta che combina
insieme i due comandamenti presi rispettivamente da Dt 6,5 quello che riguarda l’amore a Dio e (Lv 19,18) quello che riguarda l’amore al prossimo. Il testo di Luca propone differenze evidenti. La preoccupazione del dottore della legge, che come in Mt mantiene uno scopo polemico, insidioso, non è sul piano teorico, ma pratico. Abbiamo qui la medesima domanda che si ritroverà in 18,18, posta in quella occasione dal ricco che ha pure lui la preoccupazione di «ereditare la vita eterna». Questa domanda prende pertanto in Lc un rilievo notevole; la preoccupazione concreta per quanto è necessario fare per avere la salvezza interessa il terzo evangelista in un modo particolare. Sul «fare» insiste la domanda del dottore (v. 25), la prima risposta di Gesù (v. 25) e l’ultima (v. 37). La risposta alla domanda centrale però non viene formulata da Gesù. Egli la gira al dottore della legge ed è lui stesso a combinare insieme Dt 6,5 e Lv 19,18 praticamente in un comandamento unico. Mentre in Matteo e Marco si ha una precedenza chiara del comandamento dell’amore di Dio rispetto a quello del prossimo stabilendo un parallelismo (Mt 22,39) o una subordinazione (Mc 12,31), in Luca è risultata una indicazione sola, praticamente un unico inscindibile comandamento. Abbiamo già detto che non è Gesù a dare la risposta; ma va notato bene a quale fonte egli rimandi il suo interlocutore perché sia lui stesso a formularla: la legge. Gli scritti di Mosè pertanto conservano ancora secondo Gesù il loro valore di indicazione valida della volontà salvifica di Dio.
L’amore per Dio è totalizzante, nessuna dimensione della persona umana ne è esclusa. Rispetto alla versione originale di Dt 5,6 Luca aggiunge qui anche la mente per sottolineare ancora di più l’impegno dell’uomo nell’amore di Dio. Per l’amore al prossimo si propone invece come termine di paragone l’amore a se stessi. Non si tratta di pensare all’egoismo che ognuno porta in sé o all’istinto di conservazione innato in ciascuno; si tratterebbe di un confronto negativo. Anche se le seguenti osservazioni probabilmente non sono nell’intenzione dell’autore del libro del Levitico, credo però che siano opportune. Il soggetto dell’amore vero è colui che ha con se stesso un rapporto sereno, armonioso. La conoscenza e l’accettazione di sé stanno alla base di un rapporto con gli altri veramente amorevole. Amare gli altri come se stessi non significa dunque condividere con gli altri il proprio egoismo, ma partecipare loro la propria serenità e la propria gioia di vivere.
Un problema ora è decisivo: questo prossimo chi è? La domanda è ineludibile per quanto segue. Nella mentalità comune al tempo di Gesù il prossimo era il membro dello stesso popolo, per gli esseni addirittura solo gli appartenenti alla loro setta. La visione del prossimo era dunque assai limitata. La parabola farà saltare un simile modo di intenderla.
I vv. 30-37 raccontano la notissima parabola che Gesù offre come risposta concreta al quesito iniziale: che fare per salvarsi? Si tratta di un caso umano presentato con grande realismo ed efficacia. La strada da Gerusalemme a Gerico, effettivamente conosciuta da Gesù (cf. Lc 18,35,19,1.28) è davvero un luogo adatto a simili fatti di cronaca. Una rapina lungo la strada lascia la vittima al bordo della medesima; a distanza non si può fare una diagnosi precisa delle sue condizioni. Per questo motivo il sacerdote, ministro qualificato del culto, e un levita, ministro di grado inferiore addetto all’ordine del tempio, non osano neanche avvicinarsi. Nell’eventualità che il malcapitato fosse morto essi sarebbero tagliati fuori dalle loro funzioni in base alle leggi di purità cultuale (Lv 21; Nm 19,11). Il soccorso a quella persona è dunque per loro un rischio che non si può correre, pena l’esclusione dalle loro mansioni professionali. Su questa linea si potrebbe notare nell’insegnamento di Gesù una nota polemica nei confronti del culto e il desiderio di superarne la formalità come già insegnavano i profeti: Os 6,6.
Al v. 33 arriva la vera sorpresa. Il soggetto scelto per il soccorso, per la buona azione è un personaggio che l’ascoltatore di Gesù non avrebbe nominato se non per biasimarlo, rinfacciargli la sua razza bastarda (cf. 1Re 17,24-41), il suo essere eretico e scismatico (Gv 4,20). Gesù invece l’ha scelto come soggetto di un verbo delicatissimo: «ne ebbe compassione». Di questo verbo è soggetto Gesù stesso in 7,13; 15,20. Nessun ribrezzo per Gesù dunque ad identificarsi con un samaritano. Già questo è il primo atteggiamento da notare. La parabola insegnerà l’abolizione di qualsiasi barriera nei rapporti interpersonali, ma insegnando questo Gesù non farà altro che rivelare il suo cuore ed il suo stile (cf. 6,36; 15,1-3).
I vv. 34-35 vanno letti non come cronaca, ma come completamento dei sentimenti notati prima nel samaritano. Egli non è solo capace di compassione, è capace di renderla autentica con gesti concreti, a proprie spese. Senza questa complementarietà operativa non si potrebbe parlare di misericordia.
Al v. 36 tocca allo stesso dottore della legge tirare la conclusione; ciò fa parte del metodo parabolico di Gesù (cf. Mt 21,28-31) e in un certo senso si riallaccia alla prima parte del brano dove era toccato ancora a lui dare la risposta al suo interrogativo.
Il v. 37 è l’apice del brano e la risposta definitiva che trova il suo fulcro in quel «fa’». Così si capisce che per entrare nella vita eterna non c’è che una cosa da fare: vivere un amore autentico e fattivo per tutti, per qualsiasi persona, in una parola riprodurre nella propria vita l’amore senza esclusioni di Gesù.
Meditazione
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto… Un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione» (Lc 10,30.33). Su di una strada due uomini si incontrano occasionalmente: uno è ferito, «mezzo morto», l’altro è uno straniero che sa vedere la sofferenza del fratello e farsi prossimo. Su di una strada, casualmente, a due uomini viene data la possibilità di obbedire al grande comandamento che è al cuore della Legge: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso» (Lc 10,27; cfr. Dt 6,5 e Lv 19,18). Obbedire alla parola del Signore «osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge» (Dt 30,10) è dare carne, nella vita e nelle relazioni, a questa parola perché essa «è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica» (Dt 30,14): questo è il messaggio che ci viene consegnato dalla liturgia della Parola di questa domenica.
La forte dimensione di operatività, di vita, di concretezza, di obbedienza alla parola è tradotta attraverso il racconto parabolico con cui Gesù risponde ad alcuni interrogativi posti da uno scriba. È un racconto che termina proprio con questa affermazione: «Va’ e anche tu fa ‘così» (v. 37).
Il dialogo tra lo scriba e Gesù, riportato in Lc 10,25-29, prende avvio da una domanda posta dallo scriba: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» (v. 25). Ereditare la vita è ciò che sta a cuore a quello scriba. Ma quale vita cercare e come orientare ad essa tutto il cammino? La risposta di Gesù allo scriba è un’altra domanda che orienta alla Parola per eccellenza, la Torà: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?» (v. 26). E lo scriba stesso può trovare una risposta al suo desiderio di vita: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso» (v. 27). Nell’ascolto della Parola, di quella Parola che è spirito e vita, lo scriba stesso ha trovato una risposta al suo desiderio di vita. Gesù ha fatto emergere dal cuore di quell’uomo il bisogno più profondo e il desiderio più autentico che è nascosto in ogni uomo: quello di una vita che è dono, quello di una vita che apre alla eternità. Con la pedagogia sapiente del padre nello spirito, Gesù non ha risposto allo scriba offrendogli qualcosa di esterno a lui; l’ha semplicemente invitato a mettersi in ascolto della Parola e a scoprire che proprio la Parola traduceva quel desiderio di vita che era in lui. E veramente è questa la Parola che sta alla radice del nostro agire e del nostro essere, la Parola che sa unificare tutta la complessità della nostra esistenza (cuore, anima forze, mente), che sa orientare tutte le nostre potenzialità verso l’infinito (Dio stesso) e sa renderle vere attraverso la mediazione della nostra carne (il fratello). «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai» (v. 28), è la semplice constatazione di Gesù. La vita passa attraverso un fare questa precisa Parola e questa Parola è veramente tutto. È il ‘grande comandamento’: grande perché al di sopra di esso non c’è nulla; grande perché ci supera; grande perché è il nome stesso di Dio (cfr. Dt 6, 4-9).
Il dialogo tra lo scriba e Gesù avrebbe potuto terminare con questo rimando alla vita: «fa’ questo e vivrai». Ma lo scriba «volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”. Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico… Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo…”» (vv. 29.36). Lo scriba pone quella domanda a Gesù per giustificarsi: fa fatica a riconoscere che non sa amare e preferisce spostare il problema al di fuori di sé. Gesù gli pone sotto gli occhi un uomo che sa amare, obbligandolo a ricollocare nuovamente la domanda dentro di sé: non è questione di chi si deve amare, ma di come si deve amare. Il samaritano è un modello di amore e da lui quello scriba deve imparare. E sotto le spoglie del samaritano c’è Gesù stesso, il ‘buon samaritano’ per eccellenza. È da lui che quello scriba deve imparare ad amare.
La parabola narrata da Gesù allo scriba non ha bisogno di una spiegazione; attorno ad essa non dobbiamo costruire teorie o riflessioni teologiche sofisticate (cadremmo nel tranello che la domanda dello scriba tentava di porre a Gesù). È un racconto esemplare in quanto propone un comportamento da imitare; «non va trasposta da un piano all’altro, da quello figurato a quello religioso, poiché è già essa stessa su quello religioso» (B. Maggioni). Di fronte a questa parabola, che ci presenta una situazione concreta e tutt’altro che ideale, dobbiamo semplicemente seguire l’esempio del samaritano, quell’esempio che Gesù pone di fronte allo scriba dicendo: «Va e anche tu fa’ così» (v. 37). L’atteggiamento corretto di fronte a questa parabola è proprio questo: dopo averla ascoltata, non c’è altro da fare che riprendere il cammino e fare ogni giorno, a partire dalle situazioni concrete che la vita ci fa incontrare, quello che ha fatto il samaritano: «passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino… lo caricò sopra la sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui» (v. 34). Ciò che il samaritano ci insegna a fare è nient’altro che amare, vivere quella compassione che ci apre senza riserve e senza difese all’altro e che fa entrare l’altro nel profondo del nostro cuore, come un dono prezioso da custodire e di cui prendersi cura. Questo è il segreto della parabola che Gesù ci racconta. Ogni domanda in più è nient’altro che un tentativo di frenarci o di rimandare quello che la parola di Dio ci chiede di fare, non è nient’altro che un tentativo di giustificarci e nasconderci dietro a riserve e paure: «ma quello volendo giustificarsi disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”» (v. 29). Il vero problema non è quello di possedere una descrizione precisa che ci permetta di identificare il nostro prossimo e poi agire con sicurezza nei suoi riguardi. In un certo senso il volto del prossimo deve avere sempre i tratti indefiniti e imprevisti della gratuità; il prossimo è sempre l’altro che ‘per caso’ incontro sul
mio cammino, sul ciglio della strada, l’altro che non conosco che mi appare lontano e che, così diverso da me, forse non mi da immediatamente sicurezza. Il prossimo è ogni uomo che chiede proprio a me un gesto e una parola di vita. Il vero problema è che io devo farmi prossimo proprio di quest’uomo, concreto, non di un altro e devo farmi prossimo passandogli accanto, vedendolo, fasciandogli le ferite, prendendomi cura di lui: il vero problema è avere il coraggio di diventare prossimo di ogni fratello percorrendo la via rischiosa della compassione. La vera domanda che la parabola ci suggerisce di farci ogni volta che incontriamo un uomo, così come lo ha incontrato il samaritano, non è: chi è l’altro per me, ma: chi sono io per l’altro; «chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo…?» (v. 36).
Notiamo infine che il racconto di Gesù non parla di Dio, ma dell’uomo. Quel samaritano, nel momento in cui sceglie di compromettersi con l’uomo sofferente, non decide di far questo perché, agendo così, osserverà la legge di Dio, quella parola che lo scriba aveva ricordato a Gesù. Anzi il samaritano è uno che non conosce la legge, a differenza del sacerdote e del levita (cfr. vv. 31-32). Il samaritano agisce così semplicemente perché di fronte all’uomo sofferente, che chiede aiuto, non gli passa per la mente nessun altro atteggiamento se non quello della compassione. Ma proprio qui sta lo stupendo paradosso di que-sto atteggiamento: senza saperlo, nella più totale gratuità, il samaritano ama come ama Dio. Anzi, senza saperlo, quel samaritano ama Dio. Quel samaritano è la rivelazione della compassione di Dio verso la nostra umanità ferita e abbandonata; quel samaritano è Gesù che si china su ciascuno di noi, che fascia le nostre ferite, che si carica delle nostre sofferenze, che ci affida alla comunità, alla Chiesa per essere curati e guariti. Ed è stupendo vedere come tutto questo non ci viene detto attraverso un linguaggio religioso che forse anche il sacerdote e il levita avrebbero saputo narrare e spiegare con molta precisione (lo scriba non aveva forse dato la risposta giusta a Gesù?), ma attraverso il linguaggio della vita, dell’umanità, conosciuto solo da chi sa amare con gratuità l’altro semplicemente perché è uomo. Solo Gesù, colui che è vero Dio e vero uomo, può raccontare Dio in questo modo ed indicarci un nostro fratello in umanità come esempio da seguire. «Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa ‘così”» (v. 37).
Preghiere e racconti
La parabola del buon samaritano (Lc 10, 25-3 7)
Al centro della storia del buon samaritano vi è la domanda fondamentale dell’uomo. t un dottore della Legge, quindi un maestro dell’esegesi, che la pone al Signore: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» (10,25). Luca aggiunge che il dottore avrebbe fatto quella domanda a Gesù per metterlo alla prova. Egli personalmente, in quanto dottore della Legge, conosce la risposta che a essa dà la Bibbia, ma vuole vedere che cosa dice al riguardo quel profeta digiuno di studi biblici. Il Signore lo rimanda molto semplicemente alla Scrittura che questi, appunto, conosce e lascia che sia lui stesso a dare la risposta. Il dottore della Legge risponde con esattezza mettendo insieme Deuteronomio 6,5 e Levitico 19,18: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso» (Lc 10,27). Riguardo a questa domanda Gesù non insegna cose diverse dalla Torah, il cui intero significato è unito in questo duplice comandamento. Ora, però, quest’uomo dotto, che da sé conosce benissimo la risposta alla sua domanda, deve giustificarsi: la parola della Scrittura è indiscussa, ma come essa debba essere applicata nella pratica della vita solleva questioni che sono molto dibattute nella scuola (e anche nella vita stessa).
La domanda, nel concreto, è: chi è «il prossimo»? La risposta abituale, che poteva poggiarsi anche su testi delle Scritture, affermava che «prossimo» significava «connazionale». Il popolo costituiva una comunità solidale, in cui ognuno aveva delle responsabilità verso l’altro, in cui ogni individuo era sostenuto dall’insieme e quindi doveva considerare l’altro, «come se stesso», parte di quell’insieme che gli assegnava il suo spazio vitale. Gli stranieri allora, le persone appartenenti a un altro popolo, non erano «prossimi»? Ciò, però, andava contro la Scrittura, che esortava ad amare proprio anche gli stranieri ricordando che in Egitto Israele stesso aveva vissuto un’esistenza da forestiero. Tuttavia, dove porre i confini restava argomento di discussione. In generale si considerava appartenente alla comunità solidale e quindi «prossimo» solo lo straniero che si era stanziato nella terra d’Israele. Erano diffuse anche altre limitazioni del concetto di «prossimo». Una dichiarazione rabbinica insegnava che non bisognava considerare «prossimo» eretici, delatori e apostati (Jeremias, p. 170). Inoltre era dato per scontato che i samaritani, che a Gerusalemme, pochi anni prima (tra il 6 e il 9 dopo Cristo) avevano contaminato la piazza del tempio proprio nei giorni della Pasqua spargendovi ossa umane (Jeremias, p. 17 1), non erano «prossimi».
Alla domanda, resa in questo modo concreta, Gesù risponde con la parabola dell’uomo che sulla strada da Gerusalemme a Gerico viene assalito dai briganti che lo abbandonano ai bordi della via, spogliato e mezzo morto. E’una storia assolutamente realistica, perché su quella strada assalti simili accadevano regolarmente. Passano sulla medesima strada un sacerdote e un levita – conoscitori della Legge, esperti circa la grande domanda della salvezza di cui erano al servizio per professione – e vanno oltre. Non dovevano essere necessariamente uomini particolarmente freddi; forse hanno avuto paura anche loro e hanno cercato di arrivare più presto possibile in città; forse erano maldestri e non sapevano da che parte cominciare per prestare aiuto tanto più che, comunque, sembrava che non ci fosse più molto da aiutare. Poi sopraggiunge un samaritano, probabilmente un mercante che deve percorrere spesso quel tratto di strada ed evidentemente conosce il padrone della locanda più vicina; un samaritano – quindi uno che non appartiene alla comunità solidale di Israele e non è tenuto a vedere nella persona assalita dai briganti il suo «prossimo».
Bisogna qui ricordare che, nel capitolo precedente, l’evangelista ha raccontato che Gesù, in cammino verso Gerusalemme, aveva mandato avanti dei messaggeri che erano giunti in un villaggio di samaritani e volevano preparare per Lui un alloggio: «Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme» (9,52s). Infuriati, i figli del tuono – Giacomo e Giovanni – dissero allora a Gesù: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Il Signore li rimproverò. Si trovò poi alloggio in un altro villaggio.
Ed ecco ora apparire il samaritano. Che cosa farà? Egli non chiede fin dove arrivino i suoi doveri di solidarietà e nemmeno quali siano i meriti necessari per la vita eterna. Accade qualcos’altro: gli si spezza il cuore; il Vangelo usa la parola che in ebraico indicava in origine il grembo materno e la dedizione materna. Vedere l’uomo in quelle condizioni lo prende «nelle viscere», nel profondo dell’anima. «Ne ebbe compassione», traduciamo oggi indebolendo l’originaria vivacità del testo. In virtù del lampo di misericordia che colpisce la sua anima diviene lui stesso il prossimo, andando oltre ogni interrogativo e ogni pericolo. Pertanto qui la domanda è mutata: non si tratta più di stabilire chi tra gli altri sia il mio prossimo o chi non lo sia. Si tratta di me stesso. lo devo diventare il prossimo, così l’altro conta per me come «me stesso».
Se la domanda fosse stata: «E’ anche il samaritano mio prossimo?», allora nella situazione data la risposta sarebbe stata un «no» piuttosto netto. Ma ecco, Gesù capovolge la questione: il samaritano, il forestiero, si fa egli stesso prossimo e mi mostra che io, a partire dal mio intimo, devo imparare l’essere-prossimo e che porto già dentro di me la risposta. Devo diventare una persona che ama, una persona il cui cuore è aperto per lasciarsi turbare di fronte al bisogno dell’altro. Allora trovo il mio prossimo, o meglio: è lui a trovarmi.
Helmut Kuhn, nella sua interpretazione della parabola, va certamente oltre il senso letterale del testo e tuttavia individua correttamente la radicalità del suo messaggio quando scrive: «L’amore politico dell’amico si fonda sull’uguaglianza dei partner. La parabola simbolica del samaritano, invece, sottolinea la radicale disuguaglianza: a samaritano, che non appartiene al popolo d’Israele, sta di fronte all’altro, a un individuo anonimo, egli che aiuta di fronte alla vittima inerme dell’attacco dei briganti. L’agape, così ci fa intendere la parabola, attraversa ogni tipo di ordinamento politico in cui domina il principio del do ut des, superandolo e caratterizzandosi in questo modo come soprannaturale. Per principio essa si colloca non solo al di là di questi ordinamenti, ma si comprende anzi come il loro capovolgimento: i primi saranno ultimi (cfr. Mt 19,30). E i miti erediteranno la terra (cfr. Mt 5,5)» (p. 88s). Una cosa è evidente: si manifesta una nuova universalità, che poggia sul fatto che io intimamente già divengo fratello di tutti quelli che incontro e che hanno bisogno del mio aiuto.
L’attualità della parabola è ovvia. Se la applichiamo alle dimensioni della società globalizzata, vediamo come le popolazioni dell’Africa che si trovano derubate e saccheggiate ci riguardano da vicino. Allora vediamo quanto esse siano «prossime» a noi; vediamo che anche il nostro stile di vita, la storia in cui siamo coinvolti li ha spogliati e continua a spogliarli. In questo è compreso soprattutto il fatto che le abbiamo ferite spiritualmente. Invece di dare loro Dio, il Dio vicino a noi in Cristo, e accogliere così dalle loro tradizioni tutto ciò che è prezioso e grande e portarlo a compimento, abbiamo portato loro il cinismo di un mondo senza Dio, in cui contano solo il potere e il profitto; abbiamo distrutto i criteri morali così che la corruzione e una volontà di potere priva di scrupoli diventano qualcosa di ovvio. E questo non vale solo per l’Africa.
Sì, dobbiamo dare aiuti materiali e dobbiamo esaminare il nostro genere di vita. Ma diamo sempre troppo poco se diamo solo materia. E non troviamo anche intorno a noi l’uomo spogliato e martoriato? Le vittime della droga, del traffico di persone, del turismo sessuale, persone distrutte nel loro intimo, che sono vuote pur nell’abbondanza di beni materiali. Tutto ciò riguarda noi e ci chiama ad avere l’occhio e il cuore di chi è prossimo e anche il coraggio dell’amore verso il prossimo. Perché – come detto – il sacerdote e il levita passarono oltre forse più per paura che per indifferenza. Dobbiamo, a partire dal nostro intimo, imparare di nuovo il rischio della bontà; ne siamo capaci solo se diventiamo noi stessi interiormente «buoni», se siamo interiormente «prossimi» e se abbiamo poi anche lo sguardo capace di individuare quale tipo di servizio, nel nostro ambiente e nel raggio più esteso della nostra vita, è richiesto, ci è possibile e quindi ci è anche dato per incarico.
I Padri della Chiesa hanno dato alla parabola una lettura cristologica. Qualcuno potrebbe dire: questa è allegoria, quindi un’interpretazione che allontana dal testo. Ma se consideriamo che in tutte le parabole il Signore ci vuole invitare in modi sempre diversi alla fede nel regno di Dio, quel regno che è Egli stesso, allora un’interpretazione cristologica non è mai una lettura completamente sbagliata. In un certo senso corrisponde a una potenzialità intrinseca del testo e può essere un frutto che si sviluppa dal suo seme. I Padri vedono la parabola in dimensione di storia universale: l’uomo che li giace mezzo morto e spogliato ai bordi della strada non è un’immagine di «Adamo», dell’uomo in genere, che davvero «è caduto vittima dei briganti»? Non è vero che l’uomo, questa creatura che è l’uomo, nel corso di tutta la sua storia si trova alienato, martoriato, abusato? La grande massa dell’umanità è quasi sempre vissuta nell’oppressione; e da altra angolazione: gli oppressori – sono essi forse le vere immagini dell’uomo o non sono invece essi i primi deformati, una degradazione dell’uomo? Karl Marx ha descritto in modo drastico l’«alienazione» dell’uomo; anche se non ha raggiunto la vera profondità dell’alienazione, perché ragionava solo nell’ambito materiale, ha tuttavia fornito una chiara immagine dell’uomo che è caduto vittima dei briganti.
La teologia medievale ha interpretato i due dati della parabola sullo stato dell’uomo depredato come fondamentali affermazioni antropologiche. Della vittima dell’imboscata si dice, da un lato, che fu spogliato (spoliatus); dall’altro lato, che fu percosso fin quasi alla morte (vulneratus: cfr. Lc 10,30). Gli scolastici riferirono questi due participi alla duplice dimensione dell’alienazione dell’uomo. Dicevano che è spoliatus supernaturalibus e vulneratus in naturalibus: spogliato dello splendore della grazia soprannaturale, ricevuta in dono, e ferito nella sua natura. Ora, questa è allegoria che certamente va molto oltre il senso della parola, ma rappresenta pur sempre un tentativo di precisare il duplice carattere del ferimento che grava sull’umanità.
La strada da Gerusalemme a Gerico appare quindi come l’immagine della storia universale; l’uomo mezzo morto sul suo ciglio è immagine dell’umanità. Il sacerdote e il levita passano oltre – da ciò che è proprio della storia, dalle sole sue culture e religioni, non giunge alcuna salvezza. Se la vittima dell’imboscata è per antonomasia l’immagine dell’umanità, allora il samaritano può solo essere l’immagine di Gesù Cristo. Dio stesso, che per noi è lo straniero e il lontano, si è incamminato per venire a prendersi cura della sua creatura ferita. Dio, il lontano, in Gesù Cristo si è fatto prossimo. Versa olio e vino sulle nostre ferite – un gesto in cui si è vista un’immagine del dono salvifico dei sacramenti – e ci conduce nella locanda, la Chiesa, in cui ci fa curare e dona anche l’anticipo per il costo dell’assistenza.
I singoli tratti dell’allegoria, che sono diversi a seconda dei Padri, possiamo lasciarli serenamente da parte. Ma la grande visione dell’uomo che giace alienato e inerme ai bordi della strada della storia e di Dio stesso, che in Gesù Cristo è diventato il suo prossimo, la possiamo tranquillamente fissare nella memoria come una dimensione profonda della parabola che riguarda noi stessi. Il possente imperativo contenuto nella parabola non ne viene infatti indebolito, ma è anzi condotto alla sua intera grandezza. Il grande tema dell’amore, che è l’autentico punto culminante del testo, raggiunge così tutta la sua ampiezza. Ora, infatti, ci rendiamo conto che noi tutti siamo «alienati» e bisognosi di redenzione. Ora ci rendiamo conto che noi tutti abbiamo bisogno del dono dell’amore salvifico di Dio stesso, per poter diventare anche noi persone che amano. Abbiamo sempre bisogno di Dio che si fa nostro prossimo, per poter diventare a nostra volta prossimi.
Le due figure, di cui abbiamo parlato, riguardano ogni singolo uomo: ogni persona è «alienata», estraniata proprio dall’amore (che è appunto l’essenza dello «splendore soprannaturale» di cui siamo stati spogliati); ogni persona deve dapprima essere guarita e munita del dono. Ma poi ogni persona deve anche diventare samaritano – seguire Cristo e diventare come Lui. Allora viviamo in modo giusto. Allora amiamo in modo giusto, se diventiamo simili a Lui, che ci ha amati per primo (cfr. 1 Gv 4,19).
(Joseph Ratzinger/Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoli, capitolo 7: il messaggio delle parabole, 219-256).
Cos’è la sconfitta?
“Nel ciclo della natura, non esistono né vittoria né sconfitta: esiste solo il moto del cambiamento.
“L’inverno lotta per imporre il suo regno ma, alla fine, è costretto ad accettare la vittoria della primavera, che porta fiori e allegrezza.
“L’estate cerca di estendere il dominio dei suoi giorni caldi, giacché è convinta che il calore sia un elemento benefico per le genti. Ma finisce per piegarsi all’arrivo dell’autunno, che regala un meritato riposo alla terra.
“La gazzella si nutre di arbusti ma, contemporaneamente, è il cibo del leone. Non si tratta di una questione di forza o di scaltrezza, bensì del modo in cui Dio ha scelto di mostrarci il ciclo della morte e della resurrezione.
“In questo ciclo non ci sono vincitori né vinti, ma soltanto fasi che devono compiersi. Allorché il cuore dell’essere umano comprende un simile meccanismo, può dirsi libero: accetta senza afflizione i periodi difficili, e non si lascia trarre in inganno dai momenti di gloria.
(Paulo COELHO, Il manoscritto ritrovato ad Accra, Bompiani, Milano, 2012, 25-26)
Preghiera
Signore, quando ho fame,
dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;
quando ho sete,
mandami qualcuno
che ha bisogno di una bevanda;
quando ho freddo,
mandami qualcuno da scaldare;
quando ho un dispiacere,
offrimi qualcuno da consolare;
quando la mia croce diventa pensate,
fammi condividere la croce di un altro;
quando sono nell’indigenza,
guidami da qualcuno nel bisogno;
quando non ho tempo,
dammi qualcuno
che io possa aiutare per qualche momento;
quando sono umiliato,
fa’ che io abbia qualcuno da lodare;
quando sono scoraggiato,
mandami qualcuno da incoraggiare;
quando ho bisogno
della comprensione degli altri,
dammi qualcuno che ha bisogno della mia;
quando ho bisogno
che un altro si occupi di me,
mandami qualcuno di cui occuparmi;
quando penso solo a me stesso,
attira la mia attenzione su un’altra persona.
E così avrò la vita eterna, la vita della carità.
(beata Teresa di Calcutta).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– M. FERRARI, monaco di Camaldoli, «Oggi di è adempiuta questa scrittura». Tempo ordinario – Parte prima, Milano, Vita e Pensiero, 2013.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Seconda parte: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla Risurrezione, Città del Vaticano, Liberia Editrice Vaticana, 2011.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
PER L’APPROFONDIMENTO:
XV DOM TEMP ORD (C)