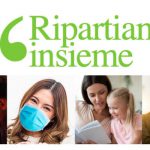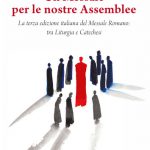Non stare parcheggiati ai lati della vita: nella Messa per il passaggio della Croce della Gmg, il Papa parla ai giovani di “grandi sogni” che rendono liberi, da cercare oltre il pensiero dominante che riduce la felicità al divertimento, l’esistenza ad una febbre di consumi, l’amore ad emozioni. Poi l’annuncio: la celebrazione diocesana della GMG dal prossimo anno passa dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Cristo Re
“Io sono lì – dice Gesù – dove il pensiero dominante, secondo cui la vita va bene se va bene a me, non è interessato. Io sono lì, dice Gesù anche a te, giovane che cerchi di realizzare i sogni della vita”. Così il Papa si rivolge ai ragazzi nella Santa Messa per il passaggio della Croce della Giornata Mondiale della Gioventù nella festa di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. Commentando l’ultima pagina del Vangelo di Matteo prima della Passione sottolinea che “prima di donarci il suo amore sulla croce, Gesù ci dà le sue ultime volontà”. Francesco chiarisce: “Ci dice che il bene che faremo a uno dei suoi fratelli più piccoli – affamati, assetati, stranieri, bisognosi, malati, carcerati – sarà fatto a Lui”. (Ascolta il servizio con la voce del Papa)
Due domande essenziali
Il Papa pone due interrogativi: “Aiuto qualcuno che non può restituirmi? Sono amico di una persona povera?”. Il Papa pone questi interrogativi per poi dare la risposta di Cristo: “Io sono lì, ti dice Gesù, ti aspetto lì, dove non immagini e dove magari non vorresti nemmeno guardare, lì nei poveri”. Il Papa ricorda la figura di San Martino: da giovane soldato non battezzato, un giorno vide un povero che “chiedeva aiuto alla gente, ma non ne riceveva, perché tutti passavano oltre”. Francesco spiega che “vedendo che gli altri non erano mossi a compassione, comprese che quel povero gli era stato riservato”. Non aveva niente con sé, solo la sua divisa di lavoro e allora tagliò il suo mantello e ne diede metà al povero, “subendo – sottolinea – le risa di scherno di alcuni lì attorno”. Poi sognò Gesù, rivestito della parte di mantello con cui aveva avvolto il povero. Fece quel sogno – aggiunge il Papa – “perché lo aveva vissuto, pur senza saperlo, come i giusti del Vangelo di oggi”.
L’invito a non restare parcheggiati ai lati della vita
E dunque il forte incoraggiamento del Papa: “Cari giovani, cari fratelli e sorelle, non rinunciamo ai grandi sogni. Non accontentiamoci del dovuto. Il Signore non vuole che restringiamo gli orizzonti, non ci vuole parcheggiati ai lati della vita, ma in corsa verso traguardi alti, con gioia e con audacia”. E’ molto incisivo il richiamo all’attualità e a convinzioni che sembrano imperanti: “Non siamo fatti per sognare le vacanze o il fine settimana – afferma il Papa – ma per realizzare i sogni di Dio in questo mondo. Egli ci ha reso capaci di sognare per abbracciare la bellezza della vita”. Dunque, la convinzione profonda: “Le opere di misericordia sono le opere più belle della vita. Se hai sogni di vera gloria, non della gloria del mondo che viene e va, ma della gloria di Dio, questa è la strada. Perché le opere di misericordia danno gloria a Dio più di ogni altra cosa”. E su questa frase il Papa si sofferma, la ripete.
Grandi scelte per grandi sogni
Il Papa dà voce a un interrogativo importante: “Ma da dove si parte per realizzare grandi sogni?”, si chiede per poi rispondere: “Dalle grandi scelte”. E’ il Vangelo a chiarirlo, ricorda: “Nel momento del giudizio finale il Signore si basa sulle nostre scelte. Sembra quasi non giudicare: separa le pecore dalle capre, ma essere buoni o cattivi dipende da noi. Egli trae solo le conseguenze delle nostre scelte, le porta alla luce e le rispetta. Per i giovani il messaggio è chiaro e potente: “La vita, allora, è il tempo delle scelte forti, decisive, eterne. Scelte banali portano a una vita banale, scelte grandi rendono grande la vita”. Papa Francesco lo dice senza mezzi termini: “Noi, infatti, diventiamo quello che scegliamo, nel bene e nel male. Se scegliamo di rubare diventiamo ladri, se scegliamo di pensare a noi stessi diventiamo egoisti, se scegliamo di odiare diventiamo arrabbiati, se scegliamo di passare ore davanti al cellulare diventiamo dipendenti”. Con una certezza che illumina: “Se scegliamo Dio diventiamo ogni giorno più amati e se scegliamo di amare diventiamo felici”.
Non restare appesi ai perché della vita
“Sì, perché – aggiunge – la bellezza delle scelte dipende dall’amore”. E anche questa affermazione Papa Francesco sceglie di ripeterla, sottolineando così tutta l’importanza. Gesù sa che “se viviamo chiusi e indifferenti restiamo paralizzati, ma se ci spendiamo per gli altri diventiamo liberi”. Dunque il Papa “consegna” ai giovani il segreto della vita: “Il Signore della vita ci vuole pieni di vita e ci dà il segreto della vita: la si possiede solo donandola”. “Ma ci sono degli ostacoli che rendono ardue le scelte”: Francesco lo ricorda, citando “spesso il timore, l’insicurezza, i perché senza risposta”. Anche qui un’indicazione chiara: l’amore chiede di andare oltre, di “non restare appesi ai perché della vita aspettando che dal Cielo arrivi una risposta”. E, dunque, “l’amore spinge a passare dai perché al per chi, dal perché vivo al per chi vivo, dal perché mi capita questo al per chi posso fare del bene. Per chi? Non solo per me: la vita è già piena di scelte che facciamo per noi stessi, per avere un titolo di studio, degli amici, una casa, per soddisfare i propri hobby e interessi.
La febbre dei consumi e l’ossessione del divertimento
Tra tante riflessioni, il Papa mette a nudo il rischio che tutte le attraversa: “Rischiamo di passare anni a pensare a noi stessi senza cominciare ad amare”. E cita Manzoni sottolineando che “diede un bel consiglio”, quando ne I promessi Sposi scrisse: «Si dovrebbe pensare più a far bene, che a star bene: e così si finirebbe anche a star meglio». Ma “non ci sono solo i dubbi e i perché a insidiare le grandi scelte generose, ci sono tanti altri ostacoli”. Il Papa ricorda “la febbre dei consumi, che narcotizza il cuore di cose superflue” e “l’ossessione del divertimento, che sembra l’unica via per evadere dai problemi e invece è solo un rimandare il problema”. Ma anche “c’è il fissarsi sui propri diritti da reclamare, dimenticando il dovere di aiutare”. E poi sintetizza “la grande illusione sull’amore” spiegando che “sembra qualcosa da vivere a colpi di emozioni, mentre amare è soprattutto dono, scelta e sacrificio”.
Difendere l’originalità contro le mentalità dell’usa-e-getta e del tutto-e-subito
Poi due inviti a ribaltare la mentalità che vorrebbe imporsi: “Scegliere – sottolinea il Papa – soprattutto oggi è non farsi addomesticare dall’omologazione, è non lasciarsi anestetizzare dai meccanismi dei consumi che disattivano l’originalità, è saper rinunciare alle apparenze e all’apparire”. Inoltre, “scegliere la vita è lottare contro la mentalità dell’usa-e-getta e del tutto-e-subito, per pilotare l’esistenza verso il traguardo del Cielo, verso i sogni di Dio”. A questo proposito il Papa aggiunge a braccio che l’obiettivo è vivere e non vivacchiare, spiegando di aver sentito questa espressione da un ragazzo. Francesco aggiunge: “Vorrei darvi un ultimo consiglio per allenarsi a scegliere bene. Se ci guardiamo dentro, vediamo che in noi sorgono spesso due domande diverse. Una è: che cosa mi va di fare? È una domanda che spesso inganna, perché insinua che l’importante è pensare a sé stessi e assecondare tutte le voglie e le pulsioni che vengono. Ma la domanda che lo Spirito Santo suggerisce al cuore è un’altra: non che cosa ti va? ma che cosa ti fa bene?”. Il Papa ribadisce che “qui sta la scelta quotidiana, che cosa mi va di fare o che cosa mi fa bene?”. E afferma: “Da questa ricerca interiore possono nascere scelte banali o scelte di vita. Guardiamo a Gesù, chiediamogli il coraggio di scegliere quello che ci fa bene, per camminare dietro a Lui, nella via dell’amore. E trovare la gioia.”
Il passaggio della Croce
Al termine della celebrazione eucaristica, il Papa ha salutato cordialmente tutti i presenti e quanti hanno seguito attraverso i media. E ha rivolto un saluto particolare ai giovani panamensi e portoghesi, rappresentati da due delegazioni, che hanno fatto, subito dopo, il significativo gesto del passaggio della Croce e dell’icona di Maria Salus Populi Romani, simboli delle Giornate Mondiali della Gioventù. “È un passaggio importante – ha detto il Papa – nel pellegrinaggio che ci condurrà a Lisbona nel 2023.
La GMG locale nella festa di Cristo Re
Poi l’annuncio della decisione di Papa Francesco con queste parole: “E mentre ci prepariamo alla prossima edizione intercontinentale della GMG, vorrei rilanciare anche la sua celebrazione nelle Chiese locali. Trascorsi trentacinque anni dall’istituzione della GMG, dopo aver ascoltato diversi pareri e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, competente sulla pastorale giovanile, ho deciso di trasferire, a partire dal prossimo anno, la celebrazione diocesana della GMG dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Cristo Re”. Il Papa ha spiegato che “al centro rimane il Mistero di Gesù Cristo Redentore dell’uomo, come ha sempre sottolineato San Giovanni Paolo II, iniziatore e patrono delle GMG”. Aggiungendo: “Cari giovani, gridate con la vostra vita che Cristo vive e regna! Se voi tacerete, grideranno le pietre!”.
Fausta Speranza – Città del Vaticano