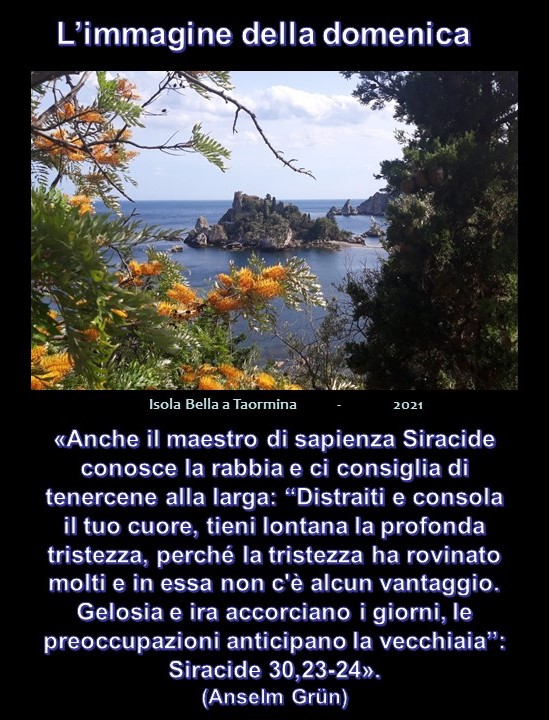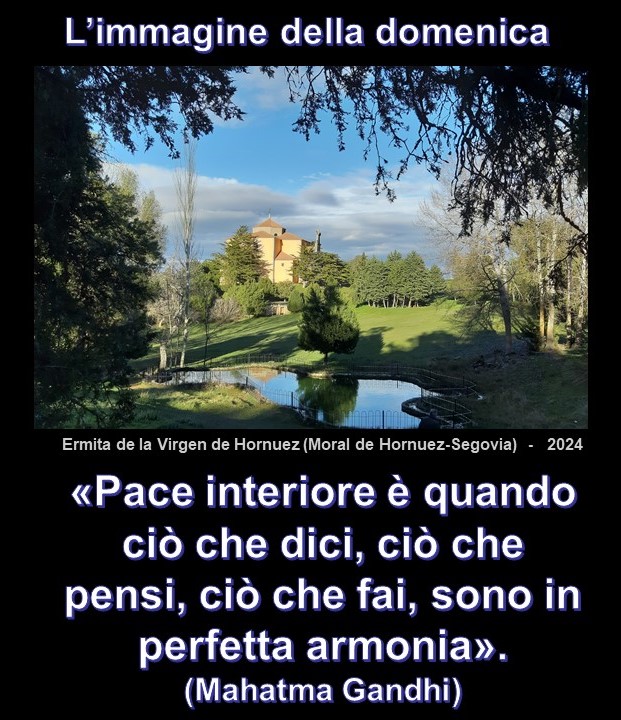Lectio – Anno C
Prima lettura: Atti 10,34a.37-43
| In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». |
- Il discorso in casa di Cornelio è l’ultimo dei discorsi cristologici di Pietro nel libro degli Atti (cf. 2,12-36; 3.11-26; 4,8-22).
La catechesi su Gesù è ancora sulle sue linee essenziali: «consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret», cioè investito dello Spirito di Dio (battesimo) e insignito di particolari poteri taumaturgici Gesù si era presentato a Israele. Partendo dalla Galilea aveva percorso «tutta la Giudea».
L’opera di Gesù è riassunta da pochi verbi; qualcuno di meno di quelli di Mt 4,23: «passò» per le contrade della Palestina, «beneficando» e «risanando» gli uomini dalle possessioni diaboliche ovvero dalle loro malattie. Sono omessi i due verbi di Matteo «predicava» e «insegnava nelle loro sinagoghe».
Ma il suo agire dimostrava che «Dio era con lui», in altre parole era l’«Emmanuele» predetto dal profeta Isaia (7,14), traduceva con i fatti la bontà di Dio in mezzo agli uomini.
Gesù ha svolto la sua missione davanti a tutto il popolo poiché davanti a tutti ha parlato e compiuto i suoi prodigi, ma per quanto riguarda il prodigio conclusivo e dimostrativo della sua missione, la risurrezione dai morti, ha voluto un gruppo scelto di testimoni con i quali si è a lungo trattenuto, dando sufficienti prove della realtà del suo nuovo stato di vita.
Gli apostoli sono quelli che possono attestare la sopravvivenza di Gesù dopo che i nemici l’avevano messo in croce. Essi l’hanno visto prima di morire e l’hanno rivisto vivo dopo la morte; possono perciò assicurare che è risorto, che non è rimasto nella tomba.
La sorte di Gesù si è rovesciata; egli è stato giudicato e condannato, ma dalla risurrezione è diventato lui il giudice di tutti, di quanti sono attualmente vivi e di quelli che sono già morti. Tutti si sono confrontati o saranno chiamati a confrontarsi con lui per ricevere il premio o la condanna delle loro buone o cattive azioni. Se si vuole evitare un incontro spiacevole con lui occorre credere, cioè ripercorrere la strada che egli ha percorso.
Pietro sta parlando in casa di Cornelio, un ufficiale romano, e ad ascoltarlo sono i suoi familiari, alcuni «congiunti e amici intimi» (10,14), tutta gente che non faceva parte del popolo della promessa, quindi della salvezza, ma si trattava di una discriminazione che con Gesù era destinata a cadere.
L’apostolo l’aveva già intravisto nella visione avuta a Joppe (10,9-15) e compreso meglio dal racconto di Cornelio (10,30-35); ora ne ha una conferma dal cielo mentre gli è dato costatare che lo Spirito di Dio sta discendendo su coloro che l’ascoltavano, per la maggior parte incirconcisi.
Era la Pentecoste dei gentili che richiamava quella sui rappresentanti d’Israele che era già avvenuta (At 2,1-12).
Seconda lettura: Colossesi 3,1-4
| Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. |
- La comunità di Colossi è alle prese con i primi confronti o le prime contaminazioni con la cultura del mondo circostante, giudaico e greco.
I giudei dell’Asia minore, alla pari dei greci, parlano di potenze cosmiche intermedie tra Dio e gli uomini, di signorie, potestà, dominazioni. Per l’autore esse possono rimanere solo che siano subordinate all’unico Signore, Cristo (1,15-20; 2,9-15).
Gesù ha affrancato l’uomo da qualsiasi giogo, come lo ha reso libero da rituali inutili, da «feste, noviluni, sabati», «cibi e bevande» (2,8,16-17).
Il cristiano è chiamato a ripercorrere il cammino di Cristo, un’esperienza di morte e di vita, di mortificazione e di risurrezione. Si tratta di morire agli «elementi di questo mondo», di finire con tutte quelle pratiche, astinenze imposte in nome di un’«affettata», falsa «religiosità, umiltà e austerità riguardo al corpo» (2,23).
Il cristiano è un uomo nuovo e il suo mondo non è tanto di quaggiù, quanto del cielo, di lassù. Nel battesimo egli è disceso nel fonte e risalendo ha lasciato nell’acqua la sua vecchia appartenenza con tutte le sue inclinazioni peccaminose e ha assunto l’immagine del Cristo glorioso.
Egli vive ancora sulla terra ma è un essere di un altro mondo, per questo deve assumere comportamenti degni della sua nuova condizione. Occorre «cercare» e «pensare alle cose di lassù», ciò che è consono con il mondo e il modo di vivere del Cristo risorto.
L’autore non specifica quali sono le cose di lassù e quali quelle della terra, ma lo dice subito dopo quando chiede di «mortificare quella parte di voi che appartiene alla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi» che designa con il termine «vizi». E aggiunge: «Voi deponeste tutte queste cose, ira, passione, malizia, maldicenze e parole oscene» (3,5-8). Tutte azioni che appartenevano, è detto sinteticamente, all’«uomo vecchio» in contrapposizione al l’«uomo nuovo che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine del suo creatore» (3,9-10).
I comportamenti dell’uomo nuovo che si avvicina a quello celeste sono invece caratterizzati da «sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Al di sopra di tutto vi è poi la carità che è il vincolo di perfezione» (3,12-14).
La vita cristiana è sempre un preludio di quella celeste che è segnata dal Cristo glorificato. Allora verrà sublimata anche quella di coloro che credono in lui.
La vita terrestre si spiega solo alla luce della sua apoteosi celeste.
Vangelo: Giovanni 20,1-9
| Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. |
Esegesi
Gli evangelisti sinottici parlano delle donne che si recano al sepolcro di buon mattino per compiere i riti sul cadavere di Gesù; Giovanni incentra l’attenzione su una donna particolare: Maria di Magdala. Ella trova la pietra rimossa e ne deduce che il corpo è stato trafugato e corre ad avvertire Pietro e il discepolo prediletto, che la tradizione identifica con l’evangelista Giovanni.
Questi si portano immediatamente al sepolcro, al quale giunge per primo il discepolo più giovane. Egli da uno sguardo fugace all’interno, vede le bende abbandonate, ma, per deferenza verso il più anziano, non entra e lo aspetta sulla soglia. Pietro entra nella cella mortuaria e vede le bende e il sudario «avvolto» a parte. Il vangelo di Giovanni non parla delle sue reazioni. Luca (24,12) dice che tornò indietro pieno di stupore (thaumazo in greco, verbo che indica grande perplessità).
«Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette» (Gv 20,8). Che cosa vide? non è il vedere di Tommaso (Gv 21,29), ma il vedere interiore. Egli di fronte al sepolcro vuoto non pensa, come la Maddalena, che hanno trafugato il cadavere o non sospende il giudizio come Pietro, ma crede sulla Parola di Gesù, a sua volta fondata sulla tradizione delle Scritture ebraiche. Il frutto della comprensione delle Scritture è il credere; non, però, un frutto «automatico», ma dono dello Spirito, che raggiunge le persone in modo misterioso ed è accolto da ciascuno in maniera diversa. Anche la Maddalena e Pietro avevano avuto comunanza con Gesù e conoscevano le Scritture, ma a loro non basta ancora per credere dinanzi al sepolcro vuoto. Essi «non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti» (Gv 20,9).
Meditazione
La scoperta del sepolcro vuoto il primo giorno dopo il sabato nel vangelo di Giovanni, che troviamo come brano evangelico nella celebrazione del giorno di Pasqua, non va letta come una cronaca di ciò che avvenne il giorno della risurrezione del Signore, bensì come un itinerario di fede verso l’incontro con lui che i discepoli di ogni tempo possono e devono vivere. Il tema dominante nel brano giovanneo non è la dimostrazione della veridicità storica della risurrezione, ma lo sguardo della fede che arriva a riconoscere la centralità per la vita della Chiesa della vita nuova sbocciata nel giardino il primo giorno dopo il sabato. Protagonisti di questo itinerario di fede sono Maria Maddalena, la prima testimone della tomba vuota, Pietro e il discepolo che Gesù amava.
Il brano degli Atti degli Apostoli (prima lettura) riporta il quinto discorso di Pietro, che lega gli eventi pasquali all’intera esistenza di Gesù a partire dal battesimo predicato da Giovanni. I discepoli che hanno vissuto con Gesù non sono solo testimoni della sua risurrezione, ma della sua intera esistenza. In questo modo viene sottolineato come tutta la vita di Gesù è stata segnata dalla logica pasquale del dono di sé.
Nella Lettera ai Colossesi (seconda lettura) si proclama che la risurrezione del Signore è ormai un fatto che riguarda la vita di tutti i credenti, che sono «risorti con Cristo» (Col 3,1). Questa realtà illumina di luce nuova la loro esistenza e deve segnare concretamente la loro vita.
Quando era ancora buio
Il primo tratto dell’itinerario di fede che il brano evangelico vuole farci compiere è affidato alla figura di Maria Maddalena. Essa si reca al sepolcro spinta dal legame che aveva con il Maestro defunto. È ancora buio e siamo nel primo giorno della settimana, che nella Scrittura è anche il primo giorno della creazione. Nel testo troviamo il verbo vedere (blepo), che nel vangelo di Giovanni appartiene al vocabolario della fede. Questo sguardo di Maria, avvolto dal buio esteriore e interiore nel quale essa si trova, è un modo di guardare che sta ancora all’inizio del cammino di fede. È ancora segnato da «una visione materiale, una visione che non comprende» (Bruno Maggioni). Il cammino di fede consiste nel far maturare questo sguardo, che deve passare dall’osservazione di elementi di cui sfugge il senso all’affidamento. Maria non entra nemmeno nel sepolcro, ma corre dai discepoli e la sua incomprensione emerge dalle parole che rivolge loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro» ( Gv 20,2).
Alle parole di Maria due discepoli corrono alla tomba. Sono Pietro e il discepolo amato. Pietro lo conosciamo, svolge in tutti i vangeli un ruolo molto particolare. Ma chi è il discepolo amato? Lo troviamo nei racconti della passione e morte di Gesù (Gv 13,23; 19,26), ma prima non compare mai. Non ha un nome e viene indicato solo attraverso la relazione che ha con Gesù. È un discepolo, ma non uno qualunque: è il discepolo che Gesù amava. Il suo nome è lo sguardo di Gesù su di lui.
L’evangelista sottolinea la fretta con cui accadono questi fatti. I due discepoli corrono al sepolcro e uno dei due, il discepolo amato, corre più forte e raggiunge per primo la tomba. Non entra, ma si china e vede (blepo). Come testimonia l’uso dello stesso verbo nel testo greco, la sua esperienza è simile a quella di Maria Maddalena. Anche qui siamo davanti all’esperienza di un vedere materiale che non sa penetrare la realtà per coglierne un senso ulteriore. Tuttavia egli vede qualcosa di più di Maria: si avvicina alla tomba vuota, si china e vede le tele che ricoprivano il cadavere del Signore ‘giacenti’.
Poi alla tomba giunge anche Pietro. A differenza dell’altro discepolo, egli entra nella tomba e vede (theoreo) le bende e il sudario. Qui Giovanni usa un verbo che indica qualcosa di diverso rispetto a quello usato nei casi precedenti. Non siamo ancora alla meta del cammino, «non è ancora lo sguardo della fede, ma è pur sempre uno sguardo attento, che suscita il problema e rende perplessi» (Maggioni).
Infine, entra anche l’altro discepolo. Davanti ai suoi occhi trova le stesse cose viste da Pietro, ma di lui si dice che vide (orao) e credette (potremmo anche dire: ‘vedendo credette’) . A indicare la vista troviamo qui un terzo verbo, orao, che indica «il vedere penetrante di chi sa cogliere il significato profondo di ciò che materialmente appare» (Maggioni). E il tipo di visione che all’inizio del vangelo viene promessa ai discepoli (Gv 1,39.50-51) e che verrà donata a Tommaso, quando gli apparirà il Signore risorto ‘otto giorni dopo’. Per questo valore, un tale modo di ‘vedere’ è affiancato dal verbo `credere’.
La vista della fede
Usando questi verbi diversi per indicare l’unica esperienza del vedere è come se l’evangelista Giovanni volesse indicarci un itinerario di fede. I personaggi vedono in modo differente l’uno dall’altro e anche a seconda della loro vicinanza alla tomba vuota: solo quando entra nel sepolcro vuoto il discepolo che Gesù amava riesce ad avere lo sguardo della fede. I discepoli fanno dapprima l’esperienza di un grande vuoto, l’esperienza di un’assenza. Vedono solo i segni dell’assente. Ma entrando nella profondità di quel vuoto e di quell’assenza, lo sguardo può divenire capace di ‘vedere’ veramente il senso di ciò che è accaduto.
Non va dimenticato un particolare decisivo: colui che arriva allo sguardo della fede non è, per ora, né Maria Maddalena — di lei il vangelo di Giovanni parlerà più avanti — né Pietro, bensì quel discepolo senza nome che viene chiamato ‘il discepolo che Gesù amava’. Non bastano ‘i segni dell’assenza’, occorrono ‘gli occhi dell’amato’ per arrivare allo sguardo della fede.
Questo discepolo senza nome è certamente una figura misteriosa, ma è anche una ‘figura aperta’ (Maggioni), che può rimandare alla figura del discepolo ideale al quale ogni discepolo di Gesù deve tendere. Ancor più interessante è la sua qualifica: egli è colui che Gesù amava. Potremmo dire allora che è l’essere amati da Gesù che rende `chiaroveggenti’. Ancor prima di essere discepoli che amano il Signore, occorre accorgersi che è lui ad amarci per primo. Sarà la scoperta anche di Maria, quando incontrerà il suo Signore, nel giardino della risurrezione. Lo riconoscerà quando si sentirà chiamare per nome.
Don Bosco commenta il Vangelo
Pasqua di risurrezione
Pietro e l’amico Giovanni
“Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro” (Gv 20,3-4).
Per don Bosco il discepolo che accompagnò Pietro al sepolcro era Giovanni, spesso nominato l’amico di Pietro nella Vita di san Pietro:
Dopo la sua risurrezione Gesù apparve primieramente alla Maddalena e ad altre donne, perché esse sole erano venute al sepolcro per imbalsamarlo. Dopo essersi loro manifestato soggiunse: andate tosto, riferite ai miei fratelli e particolarmente a Pietro che mi avete veduto vivo. Pietro, che si credeva già forse dimenticato dal Maestro, al sentirsi a nome di Gesù annunziare a lui nominatamente la nuova della sua risurrezione diede in un torrente di lagrime, e non poteva più tenere l’allegrezza in cuore. Trasportato dalla gioia e dal desiderio di vedere il Maestro risorto, egli in compagnia dell’amico Giovanni si mise a correre velocemente su pel monte Calvario.
Don Bosco prosegue mettendo in risalto il modo con cui l’amico dà la precedenza a Pietro al momento di entrare nel sepolcro di Gesù:
Correvano entrambi insieme, ma Giovanni essendo più giovane e più svelto vi giunse prima di Pietro. Con tutto ciò egli non ebbe ardire di entrare, ed inchinatosi alquanto all’imboccatura vide i pannolini in cui era stato avvolto il corpo di Gesù. Poco dopo sopraggiunse anche Pietro, il quale, fossa per l’autorità maggiore che sapeva di godere, fosse perché era di un carattere più risoluto e pronto, senza fermarsi al di fuori, discese dentro, lo esaminò in tutte le sue parti, tastò ancora da per tutto, e altro non vide che i medesimi pannolini ed il sudario, avviluppato in disparte. Sull’esempio di Pietro entrò di poi anche Gioanni, il quale fatto il medesimo esame e vedute le medesime cose rimase al pari di lui persuaso che il corpo di Gesù era stato tolto come altri avevano detto.
Don Bosco conclude il racconto dicendo che “non avevano ancora ben potuto comprendere la promessa del Redentore, quando disse che sarebbe risorto tre giorni dopo la sua morte” (OE8 345s).
Nella stessa Vita di san Pietro don Bosco nota che “il divin Redentore portava speciale affetto a questi due Apostoli; ad uno per la sublime dignità cui era destinato, all’altro per la santità e candidezza dei costumi. Essi poi riamavano il loro Salvatore col più intenso affetto ed erano stretti tra di loro dai vincoli di specialissima amicizia, della quale il medesimo Redentore mostrò di compiacersi perché era fondata sulla virtù” (OE8 335).
Ecco alcuni esempi a titolo di prove. Durante l’ultima cena “Giovanni appagò il desiderio del suo amico Pietro” chiedendo a Gesù il nome del traditore (OE8 336).
Durante l’arresto di Gesù si nota che “quando Pietro fu alla porta del cortile non poteva entrar dentro, perché la portinaia non voleva dargliene il permesso. Il suo amico Giovanni, essendo conosciuto nella corte del Pontefice, aveva potuto entrare senza difficoltà, e ottenne dalla portinaia che Pietro potesse entrare nel cortile medesimo” (OE8 340).
Dopo l’annuncio della risurrezione, come si è detto, Pietro si mise a correre verso il sepolcro “in compagnia dell’amico Giovanni”.
Dopo la risurrezione, “Pietro vedendo che dava a lui un’autorità suprema ed a lui solo prediceva il martirio, si dimostrò sollecito di dimandare che ne sarebbe stato del suo amico Giovanni, e disse: di costui che ne sarà?” (OE8 352).
Dopo la Pentecoste “Pietro e il suo amico Giovanni” andavano insieme al tempio dove incontrarono un uomo storpio che Pietro guarì (OE8 364).
Più tardi furono chiamati in Samaria tutti e due: “Pietro perché come capo della Chiesa ricevesse in grembo di essa quella straniera nazione e unisse i Samaritani ai Giudei; Giovanni poi come speciale amico di san Pietro” (OE8 385).
(Morand Wirth)
Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.
L’immagine della domenica
| Puerta del Carmen (Murallas de Ávila) – 2022 |
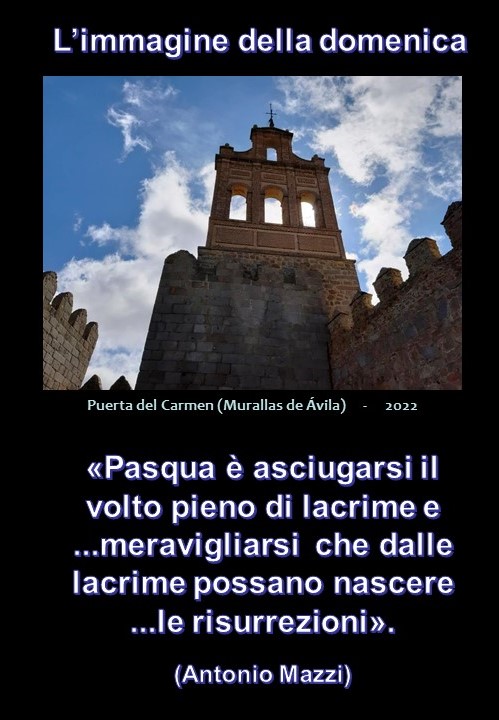
Pasqua è
asciugarsi il volto pieno di lacrime e
…meravigliarsi
che dalle lacrime possano nascere
…le risurrezioni.
(Antonio Mazzi)
Preghiere e racconti
Al discepolo che Gesù amava non appaiono angeli; nella cavità sepolcrale vede brillanti le bende.
“La notte è inoltrata, il giorno è ormai vicino”; gli occhi del discepolo stanno per aprirsi alla fede. “Le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende”.
Come nella precedente icona, un albero verde annuncia la nuova primavera di vita e ne capta il profumo nell’aria. E’ un momento trepido, un incontro appassionato: la visione inebria di senso e di grazia il riserbo del discepolo amico. Poi viene Pietro…, il destinatario dell’annuncio, la “pietra” del nuovo edificio.
(testi di fr. Espedito D’Agostini in ” Via lucis”, p.16, Servitium editrice)
Per il mattino di Pasqua
I
Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Andrò in giro per le strade
zuffolando, così,
fino a che gli altri dicano: è pazzo!
E mi fermerò soprattutto coi bambini
a giocare in periferia,
e poi lascerò un fiore
ad ogni finestra dei poveri
e saluterò chiunque incontrerò per via
inchinandomi fino a terra.
E poi suonerò con le mie mani
le campane sulla torre
a più riprese
finché non sarò esausto.
E a chiunque venga
– anche al ricco – dirò:
siedi pure alla mia mensa
(anche il ricco è un povero uomo).
E dirò a tutti:
avete visto il Signore?
Ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso.
II
Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Tutto è suo dono
eccetto il nostro peccato.
Ecco, gli darò un’icona
dove lui – bambino – guarda
agli occhi di sua madre:
così dimenticherà ogni cosa.
Gli raccoglierò dal prato
una goccia di rugiada
– è già primavera
ancora primavera
una cosa insperata
non meritata
una cosa che non ha parole;
e poi gli dirò d’indovinare
se sia una lacrima
o una perla di sole
o una goccia di rugiada.
E dirò alla gente:
avete visto il Signore?
Ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso.
III
Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Non credo più neppure alle mie lacrime,
queste gioie sono tutte povere:
metterò un garofano rosso sul balcone
canterò una canzone
tutta per lui solo.
Andrò nel bosco questa notte
e abbraccerò gli alberi
e starò in ascolto dell’usignolo,
quell’usignolo che canta sempre solo
da mezzanotte all’alba.
E poi andrò a lavarmi nel fiume
e all’alba passerò sulle porte
di tutti i miei fratelli
e dirò a ogni casa: «pace!»
e poi cospargerò la terra
d’acqua benedetta in direzione
dei quattro punti dell’universo,
poi non lascerò mai morire
la lampada dell’altare
e ogni domenica mi vestirò di bianco.
IV
Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
E non piangerò più
non piangerò più inutilmente;
dirò solo: avete visto il Signore?
Ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso
poi non dirò più niente.
(D. M. TUROLDO, O sensi miei…, Milano, Rizzoli, 1993).
Il giorno di Pasqua
Restiamocene tranquilli, a occhi chiusi, un istante prima che si levi l’alba del giorno della Risurrezione. È ancora notte fonda, ma già in due o tre case di Gerusalemme c’è qualcuno in movimento. Lumi che si accendono, donne frettolose che si pettinano e vestono. Il Sabato è finito, ed una stella incomparabile, approfittando di tutto quel firmamento che sta abdicando attorno a lei, irradia il volto della nostra prima domenica. Il gallo del calzolaio si prepara ad accettare la sfida che gli è stata lanciata dal compagno dell’altra sponda del Cedron. Non è più la Pasqua degli Ebrei: è la Pasqua dei cristiani! Guardate, ascoltate! Nel silenzio ebraico, all’incrocio di tre strade, avviene un incontro di donne velate che si interrogano sottovoce: «Chi toglierà per noi la pietra dal sepolcro?». Chi la toglierà? Il profumo che esse portano con loro si incarica di rispondere! E così la speranza irresistibile che è nel loro cuore, e l’emanazione di ingredienti mistici nel cuor della notte, preparati dalle mani stesse dell’aurora. Secoli riuniti, santa composizione, la cui dilatazione progressiva come ha poco fa vinto il sonno, così ora si mette in marcia per trionfare della morte! Degli altri avvenimenti di quell’immensa mattina, l’eco smarrita e incoerente dei quattro Vangeli fa ancora risuonare, ad ogni nuova primavera, tutte le chiese della cristianità.
(P. CLAUDEL, Credo in Dio, Torino, SEI, 1964).
Sulle tracce di Gesù
II punto cruciale di questo cammino sta nel riconoscere che il Gesù risorto, che compie i desideri dell’uomo, è ancora il Gesù crocifisso, che ha affidato al Padre il compimento dei propri desideri. Ha uniformato la propria volontà alla volontà del Padre. Ha accettato di perdere la propria vita sulla croce, per compiere la missione di proclamare all’uomo peccatore e separato da Dio che il Padre non lo abbandona al fallimento, non lo rifiuta anche se è rifiutato; anzi gli dona il proprio Figlio, per mostrare che neppure il peccato impedisce a Dio di amare l’uomo e di attirarlo a sé in un gesto di perdono, che vince il peccato e la morte.
Tutto questo è implicitamente contenuto nel grido del discepolo prediletto, che rompe il silenzio del mattino: «E il Signore» (Gv 21,7). Questa espressione, infatti, rievoca le professioni di fede della Chiesa primitiva. Gesù, che si è umiliato nella morte, in obbedienza al Padre e per amore degli uomini, è stato glorificato dal Padre ed è stato proclamato Signore, cioè colui che reca pienamente in sé la forza d’amore e di salvezza che è propria di Dio stesso.
Gesù manifesta la sua capacità e volontà di comunicare agli uomini l’amore salvifico del Padre anche attraverso un gesto simbolico. Egli mangia con i discepoli.
L’umile, quotidiano gesto del mangiare è ricco di potenzialità espressive. Può prestarsi a esprimere la comunicazione di beni sempre più grandi e misteriosi, che approfondiscono il bene fisico del cibo e il bene psicologico della conversazione, scambiati durante il pasto comune.
Gesù assume questo gesto umano e lo carica di prodigiose potenzialità. Il pasto descritto nel cap. 21 di Giovanni non risulta essere un convito propriamente eucaristico. Rievoca però il convito di Jahvè col popolo degli ultimi tempi, annunciato nell’Antico Testamento. Si ricollega ai conviti messianici fatti da Gesù con i discepoli o con le folle. Allude all’ultima cena o ad altri conviti di Gesù risorto, che hanno caratteri più propriamente e chiaramente eucaristici e comportano quindi il trapasso del generico simbolismo conviviale nella reale comunione col Signore, che si rende presente trasformando il pane e il vino nella vita e misteriosa realtà del corpo donato e del sangue versato.
(C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009, 258-259).
Cantiamo: Alleluia!
Bisogna che «questo corpo corruttibile» – non un altro – «si rivesta di incorruttibilità, e questo corpo mortale» – non un altro – «si rivesta di immortalità. Allora s’avvererà la parola della Scrittura: La morte è stata inghiottita nella vittoria». Cantiamo: Alleluia! «Allora si avvererà la parola della Scrittura», parola di gente non più in lotta, ma in trionfo: «La morte è stata inghiottita nella vittoria». Cantiamo: Alleluia! «Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». Cantiamo: Alleluia! (cfr. 1Cor 15,53-55). […] Cantiamo «Alleluia» anche adesso, sebbene in mezzo a pericoli e a prove che ci provengono sia dagli altri sia da noi stessi. Dice l’Apostolo: «Dio è fedele e non permetterà che siate tentati al di sopra delle vostre forze» (1Cor 10,13). Anche adesso, dunque, cantiamo «Alleluia». L’uomo resta ancora preda del peccato, ma Dio è fedele. E non si dice che Dio non permetterà che siate tentati, ma: «Non permetterà che siate tentati al di sopra delle vostre forze; al contrario, insieme con la tentazione, vi farà trovare una via d’uscita perché possiate reggere». Sei in balìa della tentazione, ma Dio ti farà trovare una via per uscirne e non perire nella tentazione. […]
Oh! Felice alleluia quello di lassù! Alleluia pronunciato in piena sicurezza, senza alcun avversario! Lassù non ci saranno nemici, non si temerà la perdita degli amici. Qui e lassù si cantano le lodi di Dio, ma qui da gente tribolata, là da gente libera da ogni turbamento; qui da gente che avanza verso la morte, lassù da gente viva per l’eternità; qui nella speranza, lassù nella realtà; qui in via, lassù in patria. Cantiamo dunque adesso, fratelli miei, non per esprimere la gioia del riposo, ma per procurarci un sollievo nella fatica. Come sogliono cantare i viandanti, canta ma cammina; cantando consolati della fatica, ma non amare la pigrizia. Canta e cammina! Cosa vuol dire: cammina? Avanza, avanza nel bene, nella retta fede, in una vita buona.
(AGOSTINO DI IPPONA, Discorsi 256,2-3, NBA XXXII/2, pp. 816-818).
Pasqua è…
Credere che anche i ladroni possono andare in Paradiso. Dico ladroni perché mi pare che aggiungere “buoni” sia pleonastico.
È credere che in tre giorni possono accadere cose che non sono accadute in trenta secoli.
È credere che i soldi non comprano mai nessuno e se lo comprano è per distruggerlo.
È credere che anche gli amici veri possono tradire altri amici veri. La causa: troppa sicurezza nel reputarsi “veri”.
È accettare di iscrivere il dolore dentro la storia della nostra vita, accettarlo come compagno. C’è un dolore che annulla l’uomo e c’è un dolore che annulla gli errori dell’uomo.
È uscire dalla metropoli e percorrere i sentieri oltre le mura: sentieri di silenzio, faticosi, scoscesi, puliti, stretti.
È credersi Giuda e Pietro, cireneo e soldato, Pilato e Maddalena, sepolcro e giardino, terremoto e sindone, legno e sangue, mors e alleluja.
È smettere di farsi parola per incominciare a farsi pane, vino, mensa, cenacolo, fuoco, amore.
È incontrarsi con il giardiniere e scoprirlo Cristo; incontrarsi con un viandante e scoprirlo Cristo; incontrarsi con i vecchi compagni e scoprirli Cristo; incontrarsi con i pescatori e …mangiare con Cristo.
È asciugarsi il volto pieno di lacrime e …meravigliarsi che dalle lacrime possano nascere …le risurrezioni.
(Antonio Mazzi).
Andate presto, andate a dire…
Voi che l’avete intuito per grazia
correte su tutte le piazze
a svelare il grande segreto di Dio.
Andate a dire che la notte è passata.
Andate a dire che per tutto c’è un senso.
Andate a dire che l’inverno è fecondo.
Andate a dire che il sangue è un lavacro.
Andate a dire che il pianto è rugiada.
Andate a dire che ogni stilla è una stella.
Andate a dire: le piaghe risanano.
Andate a dire: per aspera ad astra.
Andate a dire: per crucem ad lucem.
Voi, che lo avete intuito per grazia,
correte di porta in porta
a svelare il grande segreto di Dio.
Andate a dire che il deserto fiorisce.
Andate a dire che l’Amore ha ormai vinto.
Andate a dire che la gioia non è sogno.
Andate a dire che la festa è già pronta.
Andate a dire che il bello è anche vero.
Andate a dire che è a portata di mano.
Andate a dire che è qui, Pasqua nostra.
Andate a dire che la storia ha uno sbocco.
Andate a dire: liberate, lottate.
Andate a dire che ogni impegno è un culto.
Voi, che lo avete intuito per grazia,
correte, correte per tutta la terra
a svelare il grande segreto di Dio.
Andate a dire che ogni croce è un trono.
Andate a dire che ogni tomba è una culla.
Andate a dire che il dolore è salvezza.
Andate a dire che il povero è in testa.
Andate a dire che il mondo ha un futuro.
Andate a dire che il cosmo è un tempio.
Andate a dire che ogni bimbo sorride.
Andate a dire che è possibile l’uomo.
Andate a dire, voi tribolati.
Andate a dire, voi torturati.
Andate a dire, voi ammalati.
Andate a dire, voi perseguitati.
Andate a dire, voi prostrati.
Andate a dire, voi disperati.
Andate a dire, comunque sofferenti.
Andate a dire, offerenti-sorridenti.
Andate a dire su tutte le piazze.
Andate a dire di porta in porta.
Andate a dire in fondo alle strade.
Andate a dire per tutta la terra.
Andate a dire gridandolo agli astri.
Andate a dire che la gioia ha un volto.
Proprio quello sfigurato dalla morte.
Proprio quello trasfigurato nella Pasqua.
Oggi, proprio ora, qui andate a dire.
Andate a dire.
Ed è subito pace.
Perché è subito Pasqua.
(SabinoPalumbieri, Via Paschalis, Elledici, 2000, pp. 28-29)
Quelli che fanno suonare le campane
Qualche mese fa, concludendo la visita pastorale in una parrocchia della mia diocesi, l’ultimo giorno andai in una scuola materna. C’erano tantissimi bambini di tre o quattro anni che si affollavano stupiti intorno a me: non mi conoscevano, mi vedevano come un personaggio esotico. La maestra chiese: “Bambini, sapete chi è il vescovo?”. Tutti diedero delle risposte. Uno disse: “E’ quello che porta il cappello lungo in testa”; un altro, chissà per quale associazione di immagini, disse una cosa bellissima che a me piacque tanto: “il Vescovo è quello che fa suonare le campane”. Forse mi aveva visto in processione, al suo paese, in qualche festa accompagnata dal tripudio delle campane. Il vescovo come colui che fa suonare le campane: è una definizione bellissima, forse poco teologica ma profondamente umana. Sarebbe bello che i vostri fedeli, i vostri amici, coloro che vi conoscono, potessero dare di voi una definizione così. Sarebbe bello che la gente dicesse di tutti noi che siamo “quelli che fanno suonare le campane”: le campane della gioia di Pasqua, le campane della speranza.
(Don Tonino Bello, Parabole e metafore).
I macigni rotolati
Ricorrerò alla suggestione del macigno che la mattina di Pasqua le donne, giunte nell’orto, videro rimosso dal sepolcro. Ognuno di noi ha il suo macigno. Una pietra enorme, messa all’imboccatura dell’anima, che non lascia filtrare l’ossigeno, che opprime in una morsa di gelo, che blocca ogni lama di luce, che impedisce la comunicazione con l’altro. E’ il macigno della solitudine, della miseria, della malattia, dell’odio, della disperazione, del peccato. Siamo tombe alienate. Ognuna col suo sigillo di morte. Pasqua, allora, sia per tutti il rotolare del macigno, la fine degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi, e se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà finalmente il miracolo del terremoto che contrassegnò la prima Pasqua di cristo. Pasqua è la festa dei macigni rotolati. E’ la festa del terremoto.
(Don Tonino Bello, Parabole e metafore).
L’affidamento dell’uomo a Dio
Nella Pasqua Gesù, da un lato, rivela il mistero dell’amore di Dio per l’uomo; dall’altro, celebra e attua nel modo umanamente più perfetto l’amore, l’obbedienza, l’affidamento dell’uomo a Dio. L’aspetto singolare, eccezionale, unico del sacrificio pasquale è che la rivelazione e la celebrazione – attuazione sono una sola cosa, così come nell’essere di Gesù, Dio e l’uomo, pur rimanendo distinti, diventano una sola cosa.
La Pasqua di Gesù, proprio perché è quella manifestazione-celebrazione dell’amore di Dio ora descritta, tende a raggiungere ogni uomo, sia per manifestargli l’amore di Dio, per annunciargli che il suo peccato è perdonato, per dargli speranza di vita e di gioia oltre la sofferenza e la morte, sia per attrarre ogni uomo nello stesso movimento di celebrazione del mistero, di adorazione di Dio, di conformazione alla volontà del Padre che ha animato tutta la vita di Gesù suggellata nella Pasqua.
L’eucaristia è appunto la modalità istituita da Gesù nell’ultima cena per attuare questa intrinseca intenzione salvifica della Pasqua.
(Carlo Maria MARTINI, Incontro al Signore risorto, vol. II: Dalla croce alla gloria, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2007, 91-94).
La Settimana con don Bosco
12-19 aprile 2025
12. “La temperanza e il lavoro sono i migliori custodi della virtù” (E7 480).
13. (S. Martino I) – “Il nuovo errore [dei monoteliti] fu combattuto precipuamente dal santo Abbate Massimo, e da san Martino I, Papa” (OE1 336).
14. “Le cose vanno male! Mi vedo la miseria crescere in modo spaventoso […]. Non so che faremo. Dio ci aiuterà; esso è nostro Padre” (E4 99).
15. “Il cristiano deve essere umile, siccome fu Gesù Cristo, il quale ginocchioni lavò i piedi ai suoi apostoli, e li lavò anche a Giuda, quantunque conoscesse che quel perfido doveva tradirlo. Il vero Cristiano si considera come il minore degli altri e come servo di tutti” (OE8 21).
16. “Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare. Renditi umile, forte, robusto; e ciò che in questo momento vedi succedere di questi animali, tu dovrai farlo pei figli miei” (MO 62).
17. “In mezzo a quei trambusti avevamo la nostra musica che consisteva in un tamburo, in una tromba ed in una chitarra. Era tutto disaccordo, ma servendo a fare rumore colle voci dei giovani bastava per fare una meravigliosa armonia” (MO 146).
18. “La nostra vita è nelle mani del Signore che è un buon padre; egli sa fino a quando ce la debba conservare” (OE13 225).
19. “Niuno può vantarsi di appartenere a Gesù Cristo se non si adopera per imitarlo. Perciò nella vita e nelle azioni di un Cristiano devonsi trovare la vita e le azioni di Gesù Cristo medesimo” (OE8 20).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– M. FERRARI, monaco di Camaldoli, «Oggi di è adempiuta questa scrittura». Tempo di Quaresima e Tempo di Pasqua, Milano, Vita e Pensiero, 2013.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.