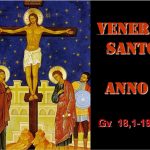Prima lettura: Atti 4,8-12
| In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati». |
- Il testo è il terzo discorso cristologico «di» Pietro negli Atti (cf. 2,14-36; 3,12-26). Egli sta parlando proprio negli atri del Tempio (portico di Salomone) dopo aver ridato, «nel nome di Gesù il Nazareno» la salute a uno storpio. Nonostante la sua fine ignominiosa sulla croce, Gesù è risuscitato dai morti.
Pietro e Giovanni si arrogavano un diritto, quello di parlare dentro il recinto sacro, che non avevano, facendo pure affermazioni false, almeno dubbie, sulla risurrezione di un condannato a morte. Per questo le autorità intervengono: «i sacerdoti, il capitano del tempio, i sadducei» (4,1). Questi ultimi fanno parte del partito dominante, ma intervengono soprattutto perché offesi nelle loro convinzioni dottrinali. Essi non ammettevano la risurrezione dei morti (cf. At 23,8; Mt 22,23). I due apostoli sono messi in prigione e il processo è rimandato al giorno dopo, debbono rispondere del loro potere taumaturgico. In genere i prodigi si operavano in nome di Dio, ma ci si poteva avvalere anche di forze avverse a lui. Gesù era stato accusato di compiere i miracoli in virtù di Beelzebub; potevano essere impostori anche i suoi discepoli.
La risposta di Pietro, forse meglio la prima apologetica cristiana, è apodittica; il loro potere viene da Gesù. Il «nome» è un ebraismo che sta per la persona. «Quell’uomo» (2,22) pertanto che essi avevano crocifisso è in grado di operare ancora; vuol dire che è tuttora vivo; è uscito dal regno dei morti; è passato nel mondo della vita, ossia di Dio. È infatti alla «sua destra» ed è «stato costituito Signore e Cristo», aveva affermato poco prima davanti al popolo (2,24,33,36).
Pietro e Giovanni sono, a detta delle stesse autorità, dei semplici «illetterati», non possono conoscere segrete arti magiche, perciò la guarigione del paralitico non può non essere attribuita che a una potenza superiore che parte sempre da Dio. Questa era quindi una riprova delle rivendicazioni di Gesù. La sua sconfitta era stata solo apparente. Egli opera ancora nella storia anche se solo tramite i suoi discepoli.
Il coraggio dei due illetterati che polemizzano con le stesse autorità giudaiche è al di sopra di ogni supposizione. Occorre che gli interlocutori cambino il loro giudizio su Gesù di Nazaret: invece che un malfattore debbono considerarlo il loro salvatore. Egli solo è la pietra angolare su cui grava la nuova comunità dei credenti. Se non si accetta questo rife-rimento e questa subordinazione non si arriva a Dio.
Seconda lettura: 1 Giovanni 3,1-2
| Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. |
- L’autore della I lettera di Giovanni richiama un aspetto essenziale dell’identità cristiana, la filiazione da Dio. Egli non è un teologo e ancor meno un filosofo bensì una guida spirituale che deduce la «filiazione divina» del cristiano dalla comunione di vita e dall’identità di comportamento che riesce ad avere con il Signore.
La «conoscenza» di Dio, è detto al cap. 2,1, quindi il rapporto intimo con lui (senso biblico di conoscere), non dipende dalla comprensione della sua realtà ultima, ma dall’adeguazione dei propri comportamenti con i suoi. È l’agire come Dio agisce — cioè con quella stessa rettitudine, santità, perfezione — che rivela la somiglianza, la «connaturalità» con lui. «Da questo sappiamo di conoscerlo (di amarlo), se osserviamo i suoi comandamenti» (2,3). E aggiunge: «Da ciò conosciamo di essere in lui» (2,5). Concludendo ribadisce: «Chi dice di dimorare in lui (in Dio) deve comportarsi come lui (Gesù Cristo) si è comportato» (2,5-6).
In fondo vivere cristianamente è ripercorrere fino alla perfezione il cammino di Gesù il quale in tutto ha cercato di attuare il volere del Padre. Ma il cristiano deve rimanere in comunione con Dio e in unione con Cristo non solo intenzionalmente ma realmente, facendo propria la testimonianza di Cristo che è l’esplicitazione ultima della volontà di Dio. «Se voi conoscete che egli è giusto anche chi opera la giustizia è da lui (Dio) generato» (2,29).
È l’agire che rivela l’intima natura dell’uomo, in questo caso del cristiano. Se ci si comporta come Dio che sa compiere solo il bene a tutti anche a quelli che non lo meritano, si da non solo a vedere ma realmente si dimostra che si hanno i suoi stessi sentimenti, la sua stessa bontà e santità. «Figlio di Dio» è un appellativo onorifico ma anche oneroso, poiché comporta una scelta operativa che deve mantenersi sulla stessa linea di quella di Dio. La filiazione è un dono di Dio ma è anche risposta dell’uomo che ha saputo accogliere le mozioni dello Spirito e si è lasciato guidare da esse nella sua vita.
Il cristiano che sa fare il bene a chi ne ha bisogno, sino ad amare pure chi lo odia, è vero figlio di Dio perché compie ciò che Dio stesso realizza nel corso del tempo e della storia.
Vangelo: Giovanni 10,11-18
| In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». |
Esegesi
La pericope (Gv 10,11-18) illustra il comportamento di Gesù verso gli uomini. Esso si contrappone a quello delle guide giudaiche, ma l’evangelista pensa anche a quelle di certe comunità cristiane. Il confronto che compare altre volte nel libro (cf. 2,13ss; 8,31 ss) inizia al termine del capitolo IX.
Gesù sta parlando con un gruppo di farisei definiti ciechi non per nascita, ma volontari, perché, pur vedendo le opere che il Cristo compie, rifiutano di comprenderne la portata, come dimostra la reazione davanti al miracolo dell’uomo a cui è stata ridonata la vista (9,14). Non solo non vogliono vedere ma pretendono di imporre come verità la loro menzogna. Ritorna il detto: gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce (3,19).
I dirigenti d’Israele sono guide cieche, ma più ancora sono «briganti e ladri» (10,1). Essi si sono introdotti nell’«atrio», (aulè), il recinto sacro, il tempio, non attraverso la porta, legittimamente quindi, ma fraudolentemente, peggio, rubando e uccidendo le persone giuste e innocenti che vi si frapponevano. I ladri sono chiamati tali perché saltano i muri; il vero pastore passa attraverso la porta: è noto al portiere e alle pecore, può chiamarle e condurle al pascolo.
Affinché non ci siano equivoci, l’evangelista scopre l’identità del pastore: «Io sono», proclama solennemente Gesù; ma non uno qualunque, bensì «il pastore per eccellenza» (ho kalòs). L’espressione dice di più di «buon pastore». Egli solo realizza l’oracolo di Ez 34,23 («Susciterò per loro un pastore che li pascerà, David mio servo; egli li condurrà al pascolo; sarà il loro pastore»). Il re-pastore che Israele attende è, nonostante le apparenze e la sua provenienza da un oscuro villaggio della Galilea (Gv 1,42), Gesù il nazareno.
Nella storia d’Israele si sono susseguiti molti pastori, forse anche buoni, ma nessuno merita tale appellativo quanto Gesù, perché nessuno ha svolto compiti pari ai suoi e soprattutto con la dedizione eguale alla sua. La specificità del vero pastore è vivere e operare per il bene del gregge, non per la propria esaltazione o per interesse. In realtà il vero pastore è a servizio delle pecore e non permette che queste siano a servizio della sua persona (cf. Ez 34,10). Il suo contrario è il mandriano che lavora per la mercede, senza affezione e nemmeno tanta attenzione alla sicurezza delle pecore, che pure ha in custodia.
Quelli che prima erano «guide cieche», «briganti e ladri», sono ora designati come «mercenari». Essi che uccidevano e distruggevano ora lasciano sbranare le pecore dai «lupi» che sono in fondo i loro alleati poiché compiono le loro stesse operazioni, disperdere le pecore invece che proteggerle.
Il ragionamento giovanneo avanza, com’è risaputo, per «circoli concentrici». L’evangelista ha detto il suo pensiero fin dall’inizio del capitolo, ne ha enunciato il tema al v. 11 ; ma vi torna sopra ripetutamente aggiungendovi ulteriori precisazioni. Gesù è il pastore vero, ideale, perché assolve il suo mandato non tanto per dovere, quanto con dedizione e amore. Egli infatti ama le pecore che gli sono state affidate. Il verbo «conoscere» nel linguaggio biblico non è semplice percezione mentale, ma relazione affettiva e fattiva. È sinonimo di volontà di bene; è amare. «Nessuno conosce il padre se non il figlio», afferma Gesù nel comma giovanneo di Mt 11,27; nessuno cioè lo ama quanto lui ed è da lui riamato. Allo stesso modo Gesù dedica le sue energie, e alla fine la sua stessa vita, per le persone alle quali è stato inviato. Il rapporto che lo lega a Dio è lo stesso che lo porta agli uomini, per questo si tratta di un riferimento autentico, sincero, vero. «Quel giorno conoscerete, cioè sperimenterete, che io sono nel padre mio; voi in me ed io in voi», affermerà più avanti egli stesso (Gv 14,20). Con Dio non si può fingere quindi non ci può essere inganno nell’amore di Gesù per l’uomo. Esso è senza limiti, senza restrizioni, totale, poiché non si arresta neanche davanti al pericolo della vita. Gesù infatti ha sostenuto la causa dei suoi «fratelli» (cf. Gv 20,17) contro il potere delle guide cieche, affrontando ladri e banditi con il rischio di rimanere vittima delle loro aggressioni.
Non solo. Il pericolo né l’ha fatto recedere dai suoi compiti, né ha ristretto l’ambito delle sue operazioni. Egli più che fermarsi alle pecore perdute della casa d’Israele (Mt 10,6), rivolge i suoi messaggi e le sue attenzioni a tutti coloro che incontra nel suo cammino, dentro e fuori i confini della Palestina. La sua luce si irradia su «ogni uomo» (Gv 1,6), non solo sugli israeliti. La comunità cristiana è senza frontiere, universale. I privilegi d’Israele sono caduti una volta per sempre. Il velo del tempio, direbbe Matteo, è stato strappato da capo a fondo e non può essere più ricucito (27,51).
I seguaci di Gesù, i nuovi credenti, provengono dalle fila del giudaismo, dall’interno del recinto sacro (atrio), ma anche dalle nazioni, poiché pure ad esse appartiene la salvezza. L’unità di tutti i credenti non sarà più fondata sulla dipendenza a istituti o istituzioni sacre, ma dalla comunione che gli uomini avranno tra di loro e con Cristo. La «voce» di Gesù
che tutti egualmente ascolteranno si identifica innanzitutto con le sue proposte, ma anche con il calore con cui le comunica, l’amore con cui le accompagna. Coloro che l’ascoltano ne rimarranno per questo conquistati e coinvolti, diventando suoi discepoli.
L’ultima ripresa del discorso, il «circolo» conclusivo, allarga ancora una volta il tema iniziale. Gesù è stato investito dallo Spirito di Dio per una missione tra gli uomini (Gv 1,32), in concreto ha avvertito in sé i riflessi che l’amore di Dio ha per le sue creature predilette e gli ha dato piena accoglienza, non tanto per la sua realizzazione o glorificazione, quanto per il loro bene. Il dare se stesso è perdere la propria vita, ma non è perdersi, poiché la vita data per amore diventa un guadagno (cf. Fil 1,21; 3,7), un ricupero centuplicato di quanto si è dato (Mt 19,29).
L’amore è libera donazione. Per questo ciò che Gesù ha compiuto è frutto di una sua personale decisione; nessuno l’ha obbligato, tanto meno costretto; ha fatto solo quello che lo Spirito gli ha suggerito e quello che lui ha «liberamente» voluto. L’amore di Dio è stato liberamente accolto e liberamente sono state accettate le sue richieste. Per questo l’opera di
Gesù è stata una risposta di amore.
Meditazione
La comunità ecclesiale dedica questa quarta domenica di Pasqua, chiamata del Buon Pastore, alla preghiera e alla riflessione per le vocazioni sacerdotali e religiose. Al centro della liturgia della Parola c’è l’appassionato, discorso ove Gesù, in piena polemica con la classe dirigente d’Israele, si presenta come il «buon pastore», ossia come colui che raccoglie e guida le pecore sino ad offrire la sua stessa vita. E aggiunge: «chi non offre la vita per le pecore non è pastore bensì mercenario». In effetti, l’opposizione tra il pastore e il mercenario nasce proprio da questa motivazione: il pastore svolge la sua opera per amore, rinunciando al proprio interesse anche a costo della vita, mentre il mercenario lo fa per interesse personale e per denaro, ed è quindi logico che nel momento del pericolo abban-doni le pecore al loro destino. L’evangelista indica il pericolo con l’immagine del lupo che «rapisce e disperde» le pecore. È una sferzata durissima ai farisei, accusati di «pascere se stessi… e non il gregge» (Ez 34,2), mentre egli è venuto per «raccogliere in unità i figli dispersi» (Gv 11,52).
A guardare bene, l’opera del lupo è congeniale all’atteggiamento del mercenario. Ad ambedue, infatti, interessa solo il proprio tornaconto, la propria soddisfazione, il proprio guadagno e non quello delle pecore; si realizza così una alleanza di fatto tra l’interesse per sé e il disinteresse per gli altri. Ne viene fuori una sorta di diabolica congiura degli indifferenti e degli egoisti contro i più deboli e gli indifesi. Se pensiamo all’enorme numero di persone che hanno smarrito il senso della vita e vagano senza meta alcuna, se guardiamo i milioni di profughi che abbandonano le loro terre e i loro affetti in cerca di una vita migliore senza che nessuno se ne preoccupi, se osserviamo lo sbandamento dei giovani in cerca della felicità senza che ci sia chi gliela indichi, dobbiamo purtroppo constatare la triste e crudele alleanza tra i lupi e i mercenari, tra gli indifferenti e coloro che cercano solo di trar-re vantaggi personali da tali sbandamenti. Scrive il profeta Ezechiele: «le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura» (Ez 34,6).
Viene il Signore Gesù e con autorità grande afferma: «Io sono il buon pastore, o dò la vita per le mie pecore». Non solo lo ha detto. Lo ha anche mostrato con i fatti, particolarmente nei giorni della Settimana Santa, quando ha amato i suoi fino alla fine, fino all’effusione del sangue. Finalmente è arrivato in mezzo agli uomini chi spezza la triste e amara alleanza tra il lupo e il mercenario, tra l’interesse per sé e il disinteresse per gli altri, e finalmente chi ha bisogno di conforto e di aiuto sa dove rivolgersi, sa dove bussare, sa dove muovere i suoi occhi e il suo cuore. Gesù stesso lo disse: «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 12, 32). Tutto il Vangelo, in fondo, non parla d’altro che di questo legame tra folle disperate, abbandonate, sfinite, senza pastore e Gesù che si commuove per loro. «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova?» (Lc 15,4), dice il Signore. Si attribuisce a San Carlo Borromeo la frase: «per salvare un’anima, anche una sola, andrei sino all’inferno». Questo è l’animo del pastore: andare sino all’inferno, sino al punto più profondo, sino al limite più basso, per salvare una persona. Si può comprendere anche in questa prospettiva la «discesa agli inferi» di Gesù nel Sabato Santo. Neppure da morto, potremmo dire, Gesù si è fermato a pensare a se stesso; ma come buon pastore è andato a cercare chi era perduto, chi era ed è dimenticato, chi era ed è negli inferni di questo mondo che il male e gli uomini hanno creato.
Il Vangelo sembra dire che o si è pastori in questo modo o altrimenti non si può che essere mercenari. È vero, solo Gesù è «buon pastore»: o si somiglia a lui o si tradisce la sua stessa missione. Sappiamo bene di essere inadeguati, ed è il suo Spirito effuso nei nostri cuori che ci trasforma perché «abbiamo in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù» (Fil 2, 5). L’odierna pagina evangelica — come questa domenica suggerisce — si applica anzitutto a coloro che hanno responsabilità «pastorali» nella Chiesa, in particolare ai vescovi e ai sacerdoti. Ed è sommamente opportuno; è anzi doveroso pregare, e non solo oggi, perché i «pastori» somiglino sempre più a Gesù, vero ed unico «buon pastore». Ed è anche urgente intensificare la nostra preghiera perché il Signore doni alla sua Chiesa giovani che ascoltino l’invito ad essere «pastori» secondo il suo cuore, secondo la sua stessa passione d’amore.
Ogni comunità cristiana è chiamata a guardare l’abbondanza della «messe» e la scarsità degli «operai». Fa parte della sua preoccupazione più intensa. C’è tuttavia una responsabilità «pastorale» che appartiene a tutti i credenti. Ogni discepolo, infatti, è nello stesso tempo membro del gregge del Signore ma, a suo modo, anche «pastore», ossia responsabile dei fratelli, delle sorelle e del prossimo. In tante altre pagine della Scrittura emerge questa responsabilità «pastorale» di ogni credente. Alle origini dell’umanità Dio chiese conto a Caino di suo fratello, e non fu certo esemplare la risposta: «Son forse io custode di mio fratello?». Sì, Caino era il custode (in questo senso si può dire che era il «pastore») di Abele. Così ogni credente deve esserlo per il suo prossimo. Salga a Dio la preghiera perché nella comunità cristiana ci sia chi ascolti la chiamata del Signore a servire la Chiesa nel ministero ordinato. È da questo terreno pieno di «pastoralità» che possono nascere «pastori» per l’oggi. Una comunità appassionata genera pastori. Il buon pastore, infatti, non è un eroe; è uno che ama; e l’amore porta là dove neppure sogneremmo di arrivare.
L’amore sostiene il «buon pastore» e lo sottrae dalla logica del mercato e dalle trame fredde dell’interesse individuale. Questo amore ci fa uscire dalle nostre chiusure, dalle nostre abitudini pigre, dai nostri recinti, e ci inserisce nelle preoccupazioni stesse del Signore: «Ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore». L’amore di Dio intenerisce il cuore: ci fa commuovere su coloro che vagano nella nostra città in cerca di un approdo, su quelli che non sanno ove trovare conforto, sui milioni e milioni di disperati che coprono la faccia della terra, su quell’uomo o quella donna vicina o lontana che aspetta consolazione e non la trova. Scrive Matteo: «Gesù vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore». E aggiunge subito l’evangelista: «Allora disse ai suoi discepoli: pregate dunque il signore della messe perché mandi operai nella sua messe» (Mt 9,36-37). Tutta la comunità cristiana è unita al Signore Gesù che si commuove ancora sulle folle di questo mondo. E con lui prega perché non manchino gli operai per la vigna del Signore. Ma nello stesso tempo, ogni credente, davanti a Dio e davanti «ai campi che già biondeggiano per la mietitura» (Gv 4,35) deve dire con il profeta: «Ecco, Signore, manda me!» (Is 6,8).
L’immagine della domenica

|
|
| Pastore a Moral de Hornuez (Segovia-Spagna) – Pasqua 2013 |
|
«Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere!».
(Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe)
Preghiere e racconti
Solo in Dio e solo a partire da Dio si conosce veramente l’uomo
«Ascoltiamo ancora una volta la frase decisiva: «Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore» (10,14s). In questa frase c’è ancora una seconda interrelazione di cui dobbiamo tenere conto. La conoscenza reciproca tra il Padre e il Figlio si intreccia con la conoscenza reciproca tra il pastore e le pecore. La conoscenza che lega Gesù ai suoi si trova all’interno della sua unione conoscitiva con il Padre. I suoi sono intessuti nel dialogo trinitario; lo vedremo di nuovo riflettendo sulla preghiera sacerdotale di Gesù. Allora potremo capire che la Chiesa e la Trinità sono intrecciate tra loro. Questa compenetrazione di due livelli del conoscere è molto importante per capire la natura della «conoscenza» di cui parla il Vangelo di Giovanni.
Applicando tutto al nostro orizzonte di vita, possiamo dire: solo in Dio e solo a partire da Dio si conosce veramente l’uomo. Un conoscersi che limita l’uomo alla dimensione empirica e afferrabile non raggiunge affatto la vera profondità dell’uomo. L’uomo conosce se stesso soltanto se impara a capirsi partendo da Dio, e conosce l’altro soltanto se scorge in lui il mistero di Dio. Per il pastore al servizio di Gesù ciò significa che egli non deve legare gli uomini a sé, al suo piccolo io.
La conoscenza reciproca che lo lega alle «pecore» a lui affidate deve mirare a introdursi a vicenda in Dio, a dirigersi verso di Lui; deve pertanto essere un ritrovarsi nella comunione della conoscenza e dell’amore di Dio. Il pastore al servizio di Gesù deve sempre condurre al di là di se stesso affinché l’altro trovi tutta la sua libertà; per questo anche egli stesso deve sempre andare al di là di se stesso verso l’unione con Gesù e con il Dio trinitario.
L’Io proprio di Gesù è sempre aperto al Padre, in intima comunione con Lui; Egli non è mai solo, ma esiste nel riceversi e ridonarsi al Padre. «La mia dottrina non è mia», il suo Io è l’Io aperto verso la Trinità.
Chi lo conosce «vede» il Padre, entra in questa sua comunione con il Padre. Proprio questo superamento dialogico presente nell’incontro con Gesù ci mostra di nuovo il vero pastore, che non si impossessa di noi, bensì ci conduce verso la libertà del nostro essere portandoci dentro la comunione con Dio e dando Egli stesso la sua vita».
(Joseph RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Città del Vaticano/Milano, Libreria Editrice Vaticana/Rizzoli, 2007, 326-328).
Gesù, il buon pastore
Chi è Gesù? Gesù è il buon pastore. Siamo invitati dallo stesso Signore a pensarlo così: una figura estremamente amabile, dolce, vicina. E noi possiamo attribuire soltanto al Signore l’esprimersi con bontà infinita. Presentandosi in tale aspetto, egli ripete l’invito del pastore: disegna cioè un rapporto che sa di tenerezza e di prodigio. Conosce le sue pecorelle, e le chiama per nome. Poiché noi siamo del suo gregge, è agevole la possibilità di corrispondenza che antecede il nostro stesso ricorso a lui.
Egli ci conosce e ci nomina; si avvicina a ciascuno di noi e desidera farci pervenire a una relazione affettuosa, filiale con lui. La bontà del Signore si palesa qui in maniera sublime, ineffabile […].
Il Cristo che portiamo all’umanità è il «Figlio dell’uomo», come lui stesso si è chiamato. È il primogenito, il prototipo della nuova umanità, è il Fratello, il Compagno, l’Amico per eccellenza. Solo di lui si può dire con piena verità che «conosceva tutto quanto c’è nell’uomo» (Gv 2,25). È l’inviato da Dio, non per condannare il mondo, ma per salvarlo. È il buon pastore dell’umanità. Non c’è valore umano che non abbia rispettato, innalzato e riscattato. Non c’è sofferenza umana che non abbia compresa, condivisa e valorizzata. Non c’è bisogno umano – fatta eccezione delle imperfezioni umane – che non abbia assunto e provato lui stesso e proposto alla inventiva e alla generosità degli altri uomini come oggetto della loro sollecitudine e del loro amore, per così dire come condizione della loro salvezza.
(PAOLO VI, Discorso del 28 aprile 1968).
Il Pastore ucciso come pecora
Volgiamo gli occhi al nostro pastore, il Cristo. Vediamo il suo amore che con la sua mitezza vince l’indolenza delle pecore. Gioisce delle pecore che lo circondano, cerca quelle che si smarriscono. Non rifiuta di percorrere monti e foreste, attraversa precipizi, è accanto a quella che vagabonda e se la trova affaticata, non la odia a motivo del suo comportamento, ma è mosso a compassione dal suo patire e, presala sulle spalle, cura la fatica della pecora con la propria fatica. E gioisce della propria fatica, perché ha trovato le pecore e guarisce le loro fatiche. «Chi se ha cento pecore e ne ha perduta una, non lascia le novantanove nel deserto e non va a cercare la perduta finché la trova?» (Lc 15,4). La perdita di una sola pecora turba la gioia di quelle al sicuro, e la tristezza di una sola minaccia la gioia di tutte. […] Ma se il pastore «la trova, la prende sulle sue spalle con gioia» (Gv 10,11) «ed, entrato nella casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta” (Lc 15,6)». […]
«Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la propria vita per le pecore» (Gv 10,11). Pilato ha visto questo pastore, gli ebrei lo hanno visto, condotto alla croce per il suo gregge, come annunciava il coro dei profeti: «Come un agnello è condotto al macello, come pecora muta davanti ai tosatori, non ha aperto la sua bocca» (Is 53,7). Il Pastore è ucciso come pecora per le pecore, non oppone resistenza al patire, non fugge il giudizio, non respinge quelli che lo mettono in croce. Non ha subito la passione, ma volontariamente ha accolto la morte per le pecore. «Ho il potere di dare la mia vita e di riprenderla di nuovo» (Gv 10,18). Distrugge la passione con la sua passione, la morte con la sua morte; con la sua tomba apre le tombe, smuove i chiavistelli degli inferi. La morte ha potere fino a quando Cristo ha accolto la morte; fino ad allora i sepolcri sono chiusi pesantemente e la prigionia non ha soluzione, fino a quando il Pastore scende e annuncia alle pecore in potere della morte la liberazione. Appare agli inferi e dà l’ordine di uscire. Appare e rinnova l’appello alla vita. «Il buon pastore dà la vita per le pecore»; così cerca di essere amato dalle pecore. Ama Cristo chi ascolta attentamente la sua voce.
(BASILIO DI SELEUCIA, Omelia 26, PG 85,304A-308A).
Il prete piccolo e grande
Un prete dev’essere contemporaneamente piccolo e grande,
nobile di spirito come di sangue reale,
semplice e naturale come di ceppo contadino,
una sorgente di santificazione,
un peccatore che Dio ha perdonato,
un servitore per i timidi e i deboli,
che non s’abbassa davanti ai potenti ma si curva davanti ai poveri,
discepolo del suo Signore,
capo del suo gregge,
un mendicante dalle mani largamente aperte,
una madre per confortare i malati,
con la saggezza dell’età e la fiducia d’un bambino,
teso verso l’alto,
i piedi sulla terra,
fatto per la gioia,
esperto del soffrire,
lontano da ogni invidia,
lungimirante,
che parla con franchezza,
un amico della pace,
un nemico dell’inerzia,
fedele per sempre…
Così differente da me!
(Anonimo).
Salmo 23
O Dio,
che hai regalato al mondo e alle chiese tanti buoni pastori, tante donne e tanti uomini che vivono la loro funzione come servizio di amore, noi Ti ringraziamo per la testimonianza che ci hai dato mediante Gesù, il buon pastore.
Ma, soprattutto, noi ci rivolgiamo a Te sapendo che le Scritture fanno di Te non solo il pastore buono ed amorevole, ma l’unico pastore a cui possiamo affidare le nostre esistenze. Così ti preghiamo:
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca,
mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male,
perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.
Gesù il pastore buono che dà la vita, che contagia d’amore
Pastore buono: è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia dato a se stesso. Eppure questa immagine non ha in sé nulla di debole o remissivo: è il pastore forte che si erge contro i lupi, che ha il coraggio di non fuggire; il pastore bello nel suo impeto generoso; il pastore vero che si frappone fra ciò che dà la vita e ciò che procura morte al suo gregge.
Il pastore buono che nella visione del profeta «porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri» (Isaia 40,11), evoca anche una dimensione tenera e materna che, unita alla fortezza, compone quella che papa Francesco chiama con un magnifico ossimoro, una «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium 88).
Che cosa ha rivelato Gesù ai suoi? Non una dottrina, ma il racconto della tenerezza ostinata e mai arresa di Dio. Nel fazzoletto di terra che abitiamo, anche noi siamo chiamati a diventare il racconto della tenerezza di Dio. Della sua combattiva tenerezza.
Qual è il comportamento, il gesto che caratterizza questo pastore secondo il cuore di Dio? Il Vangelo di oggi lo sottolinea per cinque volte, racchiudendolo in queste parole: il pastore dà la vita. Qui affiora il filo d’oro che lega insieme tutta intera l’opera ininterrotta di Dio nei confronti di ogni creatura: il suo lavoro è da sempre e per sempre trasmettere vita, «far vivere e santificare l’universo» (Prece eucaristica III).
Dare la vita non è, innanzitutto o solamente, morire sulla croce, perché se il Pastore muore le pecore sono abbandonate e il lupo rapisce, uccide, vince. Dare la vita è l’opera generativa di Dio, un Dio inteso al modo delle madri, uno che nel suo intimo non è autoreferenzialità, ma generazione. Un Dio compreso nel senso della vite che dà linfa ai tralci; del seno di donna che offre vita al piccolo; dell’acqua che dà vita alla steppa arida.
Io offro la mia vita significa: vi offro una energia di nascita dall’alto; offro germi di divinità, per farvi simili a me (noi saremo simili a lui, 1 Gv 3,2 nella II Lettura). Solo con un supplemento di vita, la sua, potremo battere coloro che amano la morte, i tanti lupi di oggi.
Perché anche noi, discepoli che vogliono, come lui, sperare ed edificare, dare vita e liberare, siamo chiamati ad assumere il ruolo di “pastore buono”, cioè forte e bello, combattivo e tenero, del gregge che ci è consegnato: la famiglia, gli amici, quanti contano su di noi e di noi si fidano.
“Dare vita” significa contagiare di amore, libertà e coraggio chi avvicini, di vitalità ed energia chi incontri. Significa trasmettere le cose che ti fanno vivere, che fanno lieta, generosa e forte la tua vita, bella la tua fede, contagiosi i motivi della tua gioia.
Ermes Ronchi
Il «Buon Pastore»
La quarta domenica di Pasqua, domenica del buon Pastore, ha il suo centro nella pagina evangelica che, con l’immagine di Gesù pastore, presenta una visione sintetica dell’evento pasquale, culmine della storia di salvezza. Nel suo ministero Gesù è stato pastore del “piccolo gregge” (Lc 12,32) esponendo la sua vita fino a donarla per amore dei suoi (cf. Gv 10,11-15: riferimento alla morte di Cristo); la sua morte poi sfocia nella resurrezione che prolunga ed estende il suo ministero di pastore a livello universale che crea comunione e unità (Gv 10,16-18: riferimento alla resurrezione).
E in forza dell’evento pasquale egli è il “pastore buono”, cioè il pastore che dà salvezza, l’unico a cui spetti questo titolo che nel Primo Testamento designa Dio nel rapporto con il popolo d’Israele nel suo insieme (Sal 80: “Tu, pastore d’Israele”) e con ciascun figlio d’Israele singolarmente (Sal 23: “Il Signore è il mio pastore”).
La prima lettura, tratta come sempre nel tempo pasquale (secondo un’antica tradizione liturgica) dagli Atti degli apostoli, presenta l’annuncio della resurrezione di Cristo nel discorso di Pietro al sinedrio: le energie della resurrezione agiscono nella chiesa e, grazie alla fede, il nome del Signore opera guarigioni di malati. La seconda lettura presenta il cristiano quale rigenerato a figlio di Dio dal dono di amore del Padre.
Il paradosso cristiano emerge dalla rivelazione di Gesù quale “buon pastore”, cioè quale autentico e unico pastore: egli “offre (lett. “depone”) la vita per le pecore”, cioè rischia la vita, la espone ai pericoli dei briganti e degli animali feroci, pur di salvare le sue pecore. E arriva anche a dare la vita, a morire per i suoi. Egli non è un mercenario, un salariato, ma il pastore unito alle pecore da un legame personale e di amore.
Niente di funzionale nella qualità di pastore che Cristo vive: egli è in legame di obbedienza e di amore con il Padre (“il Padre conosce me e io conosco il Padre”) e vive un legame di conoscenza, amore e appartenenza con le pecore: “Conosco le mie (pecore) e le mie (pecore) conoscono me”. Tutto si gioca sul piano della relazione, non del ruolo, né della funzione, sul piano dell’amore, non del dovere: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13).
La rivelazione del pastore diviene anche rivelazione della qualità della pecora, ovvero, fuor di metafora, del credente che segue il pastore Gesù Cristo. Il credente è colui che conosce il Signore e ne ascolta la voce (vv. 14.16). Ascolto e conoscenza del Signore sono azioni anzitutto personali che introducono nella vita spirituale e conducono verso l’unità interiore. Ma sono anche azioni ecclesiali che consentono al Signore di governare la sua comunità e di condurla verso l’unità: “Diventeranno un solo gregge e un solo pastore”.
Il testo intravede il formarsi di un popolo composto da persone provenienti non solo da Israele, ma anche dalle genti (“ho altre pecore che non sono di questo ovile”), evento che sarà frutto della Pasqua (“quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”: Gv 12,32) e si compirà nell’eschaton (“l’Agnello sarà il loro pastore”: Ap 7,17). Giovanni presenta Gesù come pastore universale: a lui solo spetta questo titolo.
È Gesù Cristo il “Pastore della chiesa universale sparsa su tutta la terra”, come recita il Martirio di Policarpo (XIX,2). Giovanni inoltre parla dell’unicità del pastore, che è Cristo, non dell’ovile, come intese erroneamente la traduzione latina di Gerolamo (et fiet unum ovile) suscitando interpretazioni che vi vedevano un riferimento alla sede petrina: “Giovanni non avrebbe mai detto che Pietro era l’unico pastore!” (Ignace de la Potterie).
Il legame tra Cristo “buon pastore” e la resurrezione emerge anche dall’arte funeraria cristiana antica che rappresenta Cristo con una pecora sulle spalle già nelle antiche catacombe e nelle zone cimiteriali: egli è il pastore che conduce l’uomo attraverso la morte alla vita eterna in Dio.
(Luciano Manicardi)
Commento al Salmo 23
Rivolgersi al Signore nella preghiera implica un radicale atto di fiducia, nella consapevolezza di affidarsi a Dio che è buono, «misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6-7; Sal 86,15; cfr Gl 2,13; Gn 4,2; Sal 103,8; 145,8; Ne 9,17). Per questo oggi vorrei riflettere con voi su un Salmo tutto pervaso di fiducia, in cui il Salmista esprime la sua serena certezza di essere guidato e protetto, messo al sicuro da ogni pericolo, perché il Signore è il suo pastore. Si tratta del Salmo 23 – secondo la datazione greco latina 22 – un testo familiare a tutti e amato da tutti.
«Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla»: così inizia questa bella preghiera, evocando l’ambiente nomade della pastorizia e l’esperienza di conoscenza reciproca che si stabilisce tra il pastore e le pecore che compongono il suo piccolo gregge. L’immagine richiama un’atmosfera di confidenza, intimità, tenerezza: il pastore conosce le sue pecorelle una per una, le chiama per nome ed esse lo seguono perché lo riconoscono e si fidano di lui (cfr Gv 10,2-4). Egli si prende cura di loro, le custodisce come beni preziosi, pronto a difenderle, a garantirne il benessere, a farle vivere in tranquillità. Nulla può mancare se il pastore è con loro. A questa esperienza fa riferimento il Salmista, chiamando Dio suo pastore, e lasciandosi guidare da Lui verso pascoli sicuri:
«Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome» (vv. 2-3).
La visione che si apre ai nostri occhi è quella di prati verdi e fonti di acqua limpida, oasi di pace verso cui il pastore accompagna il gregge, simboli dei luoghi di vita verso cui il Signore conduce il Salmista, il quale si sente come le pecore sdraiate sull’erba accanto ad una sorgente, in situazione di riposo, non in tensione o in stato di allarme, ma fiduciose e tranquille, perché il posto è sicuro, l’acqua è fresca, e il pastore veglia su di loro. E non dimentichiamo qui che la scena evocata dal Salmo è ambientata in una terra in larga parte desertica, battuta dal sole cocente, dove il pastore seminomade mediorientale vive con il suo gregge nelle steppe riarse che si estendono intorno ai villaggi. Ma il pastore sa dove trovare erba e acqua fresca, essenziali per la vita, sa portare all’oasi in cui l’anima “si rinfranca” ed è possibile riprendere le forze e nuove energie per rimettersi in cammino.
Come dice il Salmista, Dio lo guida verso «pascoli erbosi» e «acque tranquille», dove tutto è sovrabbondante, tutto è donato copiosamente. Se il Signore è il pastore, anche nel deserto, luogo di assenza e di morte, non viene meno la certezza di una radicale presenza di vita, tanto da poter dire: «non manco di nulla». Il pastore, infatti, ha a cuore il bene del suo gregge, adegua i propri ritmi e le proprie esigenze a quelli delle sue pecore, cammina e vive con loro, guidandole per sentieri “giusti”, cioè adatti a loro, con attenzione alle loro necessità e non alle proprie. La sicurezza del suo gregge è la sua priorità e a questa obbedisce nel guidarlo.
Cari fratelli e sorelle, anche noi, come il Salmista, se camminiamo dietro al “Pastore buono”, per quanto difficili, tortuosi o lunghi possano apparire i percorsi della nostra vita, spesso anche in zone desertiche spiritualmente, senza acqua e con un sole di razionalismo cocente, sotto la guida del pastore buono, Cristo, siamo certi di andare sulle strade “giuste” e che il Signore ci guida e ci è sempre vicino e non ci mancherà nulla.
Per questo il Salmista può dichiarare una tranquillità e una sicurezza senza incertezze né timori:
«Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza» (v. 4).
Chi va col Signore anche nelle vali oscure della sofferenza, dell’incertezza e di tutti i problemi umani, si sente sicuro. Tu sei con me: questa è la nostra certezza, quella che ci sostiene. Il buio della notte fa paura, con le sue ombre mutevoli, la difficoltà a distinguere i pericoli, il suo silenzio riempito di rumori indecifrabili. Se il gregge si muove dopo il calar del sole, quando la visibilità si fa incerta, è normale che le pecore siano inquiete, c’è il rischio di inciampare oppure di allontanarsi e di perdersi, e c’è ancora il timore di possibili aggressori che si nascondano nell’oscurità. Per parlare della valle “oscura”, il Salmista usa un’espressione ebraica che evoca le tenebre della morte, per cui la valle da attraversare è un luogo di angoscia, di minacce terribili, di pericolo di morte. Eppure, l’orante procede sicuro, senza paura, perché sa che il Signore è con lui. Quel «tu sei con me» è una proclamazione di fiducia incrollabile, e sintetizza l’esperienza di fede radicale; la vicinanza di Dio trasforma la realtà, la valle oscura perde ogni pericolosità, si svuota di ogni minaccia. Il gregge ora può camminare tranquillo, accompagnato dal rumore familiare del bastone che batte sul terreno e segnala la presenza rassicurante del pastore.
Questa immagine confortante chiude la prima parte del Salmo, e lascia il posto ad una scena diversa. Siamo ancora nel deserto, dove il pastore vive con il suo gregge, ma adesso siamo trasportati sotto la sua tenda, che si apre per dare ospitalità:
«Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca» (v. 5).
Ora il Signore è presentato come Colui che accoglie l’orante, con i segni di una ospitalità generosa e piena di attenzioni. L’ospite divino prepara il cibo sulla “mensa”, un termine che in ebraico indica, nel suo senso primitivo, la pelle di animale che veniva stesa per terra e su cui si mettevano le vivande per il pasto in comune. È un gesto di condivisione non solo del cibo, ma anche della vita, in un’offerta di comunione e di amicizia che crea legami ed esprime solidarietà. E poi c’è il dono munifico dell’olio profumato sul capo, che dà sollievo dall’arsura del sole del deserto, rinfresca e lenisce la pelle e allieta lo spirito con la sua fragranza. Infine, il calice ricolmo aggiunge una nota di festa, con il suo vino squisito, condiviso con generosità sovrabbondante. Cibo, olio, vino: sono i doni che fanno vivere e danno gioia perché vanno al di là di ciò che è strettamente necessario ed esprimono la gratuità e l’abbondanza dell’amore. Proclama il Salmo 104, celebrando la bontà provvidente del Signore: «Tu fai crescere l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo coltiva per trarre cibo dalla terra, vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore» (vv. 14-15). Il Salmista è fatto oggetto di tante attenzioni, per cui si vede come un viandante che trova riparo in una tenda ospitale, mentre i suoi nemici devono fermarsi a guardare, senza poter intervenire, perché colui che consideravano loro preda è stato messo al sicuro, è diventato ospite sacro, intoccabile. E il Salmista siamo noi se siamo realmente credenti in comunione con Cristo. Quando Dio apre la sua tenda per accoglierci, nulla può farci del male.
Quando poi il viandante riparte, la protezione divina si prolunga e lo accompagna nel suo viaggio:
«Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni» (v. 6).
La bontà e la fedeltà di Dio sono la scorta che accompagna il Salmista che esce dalla tenda e si rimette in cammino. Ma è un cammino che acquista un nuovo senso, e diventa pellegrinaggio verso il Tempio del Signore, il luogo santo in cui l’orante vuole “abitare” per sempre e a cui anche vuole “ritornare”. Il verbo ebraico qui utilizzato ha il senso di “tornare”, ma, con una piccola modifica vocalica, può essere inteso come “abitare”, e così è reso dalle antiche versioni e dalla maggior parte delle traduzioni moderne. Ambedue i sensi possono essere mantenuti: tornare al Tempio e abitarvi è il desiderio di ogni Israelita, e abitare vicino a Dio nella sua vicinanza e bontà è l’anelito e la nostalgia di ogni credente: poter abitare realmente dove è Dio, vicino a Dio. La sequela del Pastore porta alla sua casa, è quella la meta di ogni cammino, oasi desiderata nel deserto, tenda di rifugio nella fuga dai nemici, luogo di pace dove sperimentare la bontà e l’amore fedele di Dio, giorno dopo giorno, nella gioia serena di un tempo senza fine.
Le immagini di questo Salmo, con la loro ricchezza e profondità, hanno accompagnato tutta la storia e l’esperienza religiosa del popolo di Israele e accompagnano i cristiani. La figura del pastore, in particolare, evoca il tempo originario dell’Esodo, il lungo cammino nel deserto, come un gregge sotto la guida del Pastore divino (cfr Is 63,11-14; Sal 77,20-21; 78,52-54). E nella Terra Promessa era il re ad avere il compito di pascere il gregge del Signore, come Davide, pastore scelto da Dio e figura del Messia (cfr 2Sam 5,1-2; 7,8; Sal 78,70-72). Poi, dopo l’esilio di Babilonia, quasi in un nuovo Esodo (cfr Is 40,3-5.9-11; 43,16-21), Israele è riportato in patria come pecora dispersa e ritrovata, ricondotta da Dio a rigogliosi pascoli e luoghi di riposo (cfr Ez 34,11-16.23-31). Ma è nel Signore Gesù che tutta la forza evocativa del nostro Salmo giunge a completezza, trova la sua pienezza di significato: Gesù è il “Buon Pastore” che va in cerca della pecora smarrita, che conosce le sue pecore e dà la vita per loro (cfr Mt 18,12-14; Lc 15,4-7; Gv 10,2-4.11-18), Egli è la via, il giusto cammino che ci porta alla vita (cfr Gv 14,6), la luce che illumina la valle oscura e vince ogni nostra paura (cfr Gv 1,9; 8,12; 9,5; 12,46). È Lui l’ospite generoso che ci accoglie e ci mette in salvo dai nemici preparandoci la mensa del suo corpo e del suo sangue (cfr Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,19-20) e quella definitiva del banchetto messianico nel Cielo (cfr Lc 14,15ss; Ap 3,20; 19,9). È Lui il Pastore regale, re nella mitezza e nel perdono, intronizzato sul legno glorioso della croce (cfr Gv 3,13-15; 12,32; 17,4-5).
Cari fratelli e sorelle, il Salmo 23 ci invita a rinnovare la nostra fiducia in Dio, abbandonandoci totalmente nelle sue mani. Chiediamo dunque con fede che il Signore ci conceda, anche nelle strade difficili del nostro tempo, di camminare sempre sui suoi sentieri come gregge docile e obbediente, ci accolga nella sua casa, alla sua mensa, e ci conduca ad «acque tranquille», perché, nell’accoglienza del dono del suo Spirito, possiamo abbeverarci alle sue sorgenti, fonti di quell’acqua viva «che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14; cfr 7,37-39).
(BENEDETTO XVI, UDIENZA GENERALE, Piazza San Pietro Mercoledì, 5 ottobre 2011)
Grande è il tuo amore, o Dio!
Tu vuoi aver bisogno di uomini
per farti conoscere agli uomini,
e così leghi la tua azione e la tua parola divine
all’agire e al parlare di persone
né perfette né migliori degli altri.
Grande è il tuo amore, o Dio!
Non hai timore della nostra fragilità
e neppure del nostro peccato: l’hai fatto tuo,
perché fosse nostra la tua vita
che guarisce ogni male.
Grande è il tuo amore, o Dio!
Ancora rinnovi la tua alleanza
grazie a chi tra noi spezza il Pane di vita,
a chi pronuncia le parole del perdono,
a chi fa risuonare annunci di vangelo,
a chi si fa servo dei fratelli,
testimoni del tuo amore infinito
che rendono visibile il Regno.
Ti preghiamo, o Dio: fa’ che queste persone
non vengano mai meno!
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno B, Milano, Vita e Pensiero, 2008.
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia, Milano, Vita e Pensiero, 2011.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.
PER L’APPROFONDIMENTO:
IV DOMENICA DI PASQUA (B)