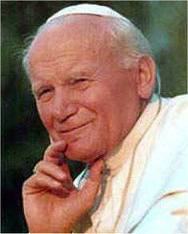intervista a Joaquin Navarro-Valls
«Sono seduto accanto a Gianni Agnelli, nella sede della Stampa estera. La segretaria mi porta un bigliettino scritto a mano: il Papa la vorrebbe vedere a pranzo. È uno scherzo. E quando sarebbe?
Subito, tra un’ora». Fu un’ora che sarebbe durata ventidue anni per Joaquin Navarro-Valls, il giornalista e medico psichiatra spagnolo che sarebbe stato fino alla sera dell’addio alla vita di Giovanni Paolo II, il Beato Wojtyla dal primo maggio prossimo, il decoder quotidiano fra l’eterno e il quotidiano, fra la santità e il giornalismo. Nessun altro, salvo monsignor Dziwisz, oggi cardinale, e le suore di pietra che vidi pregare accanto alla salma esposta nella Sala Clementina, avrebbe trascorso tanto tempo, diviso tanti silenzi, tanti segreti e tante parole con Karol Josef Wojtyla,
quanto Navarro-Valls. Una vita con il Papa, in perenne equilibrio tra la comunicazione pubblica e le stanze segrete, tra il sublime del messaggio e il purgatorio dei mass media.
Era il 1984.
«Davanti a me c’è il capo della Chiesa Cattolica, il successore di Pietro, di cui avevo letto alcuni testi ma che conoscevo soltanto da lontano, come giornalista. Mi chiede se avessi qualche idea per migliorare la comunicazione della Santa Sede».
In che lingua parlavate?
«In italiano. La vostra, anzi, la nostra lingua come aveva detto la sera della elezione, parlando dalla Loggia».
Lei che idee gli propose?
«Gli dissi che non sapevo che cosa dire, così, su due piedi. E lui, ridendo: e lei me lo dica lo stesso.
Lui taceva, mi studiava con il capo un po’ piegato, quei suoi occhi taglienti, ironici, allegri, lo sguardo che mantenne anche quando gli occhi furono imprigionati nella maschera della sofferenza».
Per due decenni, fino a quando l’infermiera suor Tobiana Sobodka riferì di avere sentito il Papa mormorarle all’orecchio in polacco «…pozwólcie mi odejsc do domu Ojca…», «lasciatemi tornare alla casa del Padre», nella sera del 2 aprile 2005, Navarro-Valls avrebbe guardato ogni giorno in quegli occhi, cercando di capire quello che lui stesso non poteva capire, il mistero di un Pontefice destinato al cielo delle beatitudini cristiane.
«Me lo domandavo, agli inizi, anche io chi fosse, che cosa fosse il mistero di Wojtyla. Ha cambiato la storia della politica e della diplomazia, senza essere né un politico né un diplomatico. Ha rivoltato le premesse della filosofia dominante senza esercitare più la professione del filosofo, ha affascinato il mondo dei media prendendo posizioni impopolari. Voleva appassionatamente attirare l’attenzione sul messaggio, ma il mondo sembrava ossessionato dal messaggero. Credevano di amare il cantante, e non si rendevano conto, o non volevano ammetterlo, che in realtà erano attratti dalla musica».
Una musica che all’orecchio del tempo sembrava stonata.
«Perché suonava alla rovescia rispetto agli spartiti dominanti dell’epoca: il pessimismo e la cupezza della nostra esistenza e della nostra condizione umana dietro il benessere materiale del nostro piccolo spicchio di mondo, Europa e Americhe. Il messaggio di Giovanni Paolo II è radicale, rivolta quegli spartiti. Diceva: voi uomini siete molto meglio di quanto la cultura moderna vi faccia credere, siete molto meglio di quanto voi stessi crediate di essere. Dunque non abbiate paura di essere ciò che siete, creature divine».
Invadeva i teleschermi, li “bucava”, occupava la televisione ormai divenuta satellitare, dunque globale. Lei non temeva, come curatore della sua immagine, di rischiare l’overdose?
«No, perché sapeva che il segreto per dominare la televisione e non lasciarsene dominare è semplicemente ignorarla, come scrisse il critico televisivo del New York Times quando andammo in America nel 1987. C’era il suo messaggio, c’erano le sue parole, e c’era la fusione tra la forza del suo messaggio e il vissuto esistenziale che si manifestava quando lo comunicava alla gente. Chi lo ascoltava sapeva che quanto diceva era vero. Il suo linguaggio e i suoi gesti esprimevano la verità».
Si preparava a questi eventi? Studiava le pose, gli angoli di ripresa, le luci, la scenografia e la sceneggiatura?
«Mai, neppure una volta. Per lui le telecamere, il trucco, le luci non esistevano. Questi atteggiamenti da personaggetti che si fanno spiegare come e dove devono guardare, se fissare l’obbiettivo o guardare fuori, se sorridere o sembrare seri, non lo sfioravano mai. I primi tempi mi preoccupavo, sapendo quanto la telecamera possa essere crudele. Ma per lui comunicare era far apparire la verità, non costruire un’apparenza».
La Curia diffidava?
«La Curia, come ogni organizzazione istituzionalizzata, può tendere alle volte a guardare verso il proprio interno. Lui la faceva guardare verso l’esterno».
Recalcitravano, le porpore?
«La Curia era non soltanto utile ma necessaria. E lui, come Papa, marcava la strada».
Una lunghissima strada. Duecento viaggi dentro l’Italia, poi in centosessanta nazioni fuori dall’Italia.
«Una volta mi disse una cosa che sembrava elementare: “Sa, nel passato era la gente ad andare in parrocchia. Oggi è il parroco che deve andare dalla gente”. Questa, così apparentemente semplice, era una un’illuminazione straordinaria che lui portava con sé da una lunga esperienza nel proprio Paese».
Lei che è un credente, un uomo dell’Opus Dei, si rendeva conto di vivere accanto a un santo?
«Lo andavo comprendendo standogli accanto giorno dopo giorno, non avevo dubbi. La fede non l’ho avuta da lui ma accanto a lui il contenuto della fede si “vedeva”, e lo metta tra virgolette perché questo andrebbe spiegato. Quello che cercavo di imparare era come la santità si sarebbe fatta carne in lui, in noi cristiani. Questo lo avrei scoperto soltanto nella convivenza quotidiana».
Per esempio?
«La preghiera. Per un credente, la preghiera spesso è un obbligo. Oppure il risultato di una convinzione fondata. Per lui era una necessità, un bisogno, come per noi respirare».
Aveva un preghiera preferita?
«Nutriva la sua preghiera con i bisogni degli altri. Gli arrivavano migliaia di messaggi di tutto il mondo, in tutte le lingue: una malattia, un problema famigliare, l’angoscia di un futuro senza futuro… L’ho visto in ginocchio per ore nella sua cappella con questi messaggi in mano: tutte le sofferenze umane come tema della sua conversazione con Dio. Penso che per se stesso non rimanesse alcuno spazio nella sua preghiera. Penso che lui non avesse delle “cose sue”. Solo cose
degli altri».
E c’era una costante nel parlare con Dio?
«Lui, che pure aveva riportato l’ottimismo nel mondo incupito e pessimista, custodiva un suo segreto. Era convinto che quello di cui veramente l’essere umano avesse più bisogno era la misericordia di Dio. Per questo la cerimonia di beatificazione avverrà il primo maggio, il giorno della Misericordia. Sembrerebbe un paradosso. Tanto fiducioso, tanto ottimista, lui che apriva orizzonti sterminati alla persona umana, eppure con il senso della limitatezza della creatura umana.
L’ultima messa, celebrata nella stanza in cui morì, era già la messa della domenica, la messa della Divina Misericordia».
Come psichiatra, lei, dottor Navarro, è mai caduto nella tentazione di guardare Karol Wojtyla come a un paziente?
«Non c’era materia per considerarlo un paziente. E non c’era tentazione, semmai deformazione professionale, come il sarto che vede un abito o il calzolaio che guarda le scarpe e le valuta, per abitudine. Mi impressionava il magnifico equilibrio interiore tra tutte le sue virtù. Virtù che, quando coabitano in una sola persona, possono anche impazzire. In lui, questa pazzia delle virtù non c’era.
Convivevano senza difficoltà. Per esempio: non sapeva perdere un minuto eppure non aveva mai fretta».
Neppure alla vigilia degli incontri più delicati?
«Nemmeno in queste occasioni. Semplicemente, metteva tutto se stesso nella preparazione di questi viaggi. Sapeva mortificarsi senza spettacolarità: rispetto al cibo, per esempio. Il rapporto con il cibo e con le bevande era di indifferenza, ne era quasi infastidito. Andavamo in paesi tropicali, caldissimi, umidi, come l’Indonesia. Era ovvia la disidratazione per il caldo. Il suo medico, io stesso, eravamo preoccupati per la perdita di liquidi. Lui, con straordinaria e discreta eleganza, ritardava di bere».
Dormiva bene, quando non soffriva?
«Voleva sempre che si viaggiasse di notte nei voli intercontinentali, per arrivare al mattino sul posto e avere così davanti a sé tutta una giornata di lavoro. Nel suo ultimo viaggio in Messico, e aveva ottant’anni, l’Alitalia gli aveva preparato un lettino dietro una tenda. Noi del seguito – laici, cardinali, monsignori – cercavamo di dormire almeno un po’, raggomitolandoci nei sedili. Quando atterriamo, l’incaricato della compagnia mi avvicina e mi dice: noi avevamo preparato il lettino per il Papa, ma abbiamo visto che è intatto. Era troppo stretto, era scomodo? Non si preoccupi, lo
rassicurai, è stato sveglio tutto il viaggio per prepararsi. Tredici ore di viaggio leggendo, studiando, pregando».
Mangiava anche poco?
«Non gli importava molto di ciò che aveva davanti. In certi periodi dell’anno faceva soltanto un pasto completo al giorno. E fino all’ultimo, il giorno prima di ordinare nuovi vescovi o sacerdoti, digiunava».
Potrebbe essere una definizione laica della santità il riuscire a vivere nell’equilibrio delle proprie virtù. Era questa serenità la radice, la causa del suo essere un uomo allegro, ironico? «Era un uomo allegro, è verissimo. L’ironia era il suo tratto caratteriale più evidente. Ma la sua gioiosità non era quella banale delle persone che non sanno fare a meno della risata da barzelletta.
Le fondamenta del suo carattere, che io definisco allegro, stanno tutte in due righe».
Di diari? Di confessioni?
«No, della Genesi. Dove si dice che siamo stati creati a Sua immagine e somiglianza. È chiaro che se ci credi, ma se ci credi davvero davvero, allora, qualunque cosa accada, anche la tragedia più spaventosa, anche Fukushima, non cambia il fatto che il mio fine ultimo di creatura è il lieto fine, l’happy end. Non ce ne possono essere altri. Dio non può tradire le creature fatte a propria immagine e somiglianza. Se hai questa certezza, anche la sofferenza ha un senso».
Lo sentiva scherzare?
«Molto. Amava scherzare, stuzzicare e prendere affettuosamente in giro anche i suoi collaboratori, i parroci e i preti diocesani delle parrocchie romane che andava a visitare. Incontrandoli la sera prima, voleva sapere quanti vecchi, quanti bambini, quante donne incinte, quanti malati gravi fossero sotto le loro cure, per poi trovarsi preparato a tutto. Ma come, Santità, gli disse un cardinale quando già stava poco bene, vuole andare a visitare un’altra parrocchia romana? Guardi eminenza che forse lei dimentica che io sono il vescovo di Roma».
Cercava sempre il contatto con la gente?
«C’era una grande fisicità in lui, baciava le donne in fronte e coccolava i loro bambini, prendeva sottobraccio i vecchi, afferrava le mani di chi gliele tendeva. “Ma sei proprio tu quello che ho visto in televisione?”, gli domandò un bambino colombiano sfuggito alla sorveglianza e corso sul palco del Papa. Prima che lo riacciuffassero, lui lo abbracciò e tolse al bambino quel dubbio – che a quella età doveva essere importante».
Un Papa prete, come sarebbe stato anche Luciani, da cui prese il nome, Giovanni Paolo. Aveva anche lui dubbi sulla morte improvvisa del suo predecessore, nel sonno, appena trenta giorni dopo l’elezione?
«No. Per lui, i sospetti erano letteratura, fiction, non lo interessavano. Mi raccontò invece di come ebbe la notizia della morte di Papa Luciani. Lo seppe dal suo autista, mentre quella mattina andava in visita pastorale a una parrocchia di Cracovia. Lui che era stato nel Conclave pochi giorni prima dovette sapere dall’autista che era morto il Pontefice che aveva eletto».
Come reagì?
«Sentì un’immensa tristezza invaderlo, poi lo assalì un’inquietudine enorme che lo scuoteva e che non riusciva a spiegarsi».
Forse un presentimento.
«Forse. Ma lui non ripartì per Roma, per il secondo Conclave in poche settimane, pensando di doverci restare come Papa. Non parlava mai di quei due Conclavi. Non disse mai se avesse ricevuto qualche voto anche nel Conclave che elesse Luciani».
Anche i santi si arrabbiano?
«Raramente, ma sì, se la ragione è giusta. Le uniche volte in cui l’ho visto arrabbiato, se arrabbiato è la parola corretta, erano sempre situazioni di violenza fisica o morale rivolta contro la gente, come la guerra nel Libano, o nei Balcani. Si tormentava, e tormentava noi chiedendoci che altro può fare il Papa per impedire una guerra. O come sarebbe poi stata l’invasione dell’Iraq, alla quale era molto contrario».
Lo disse pubblicamente.
«E anche privatamente. Quando incontrò George W. Bush, gli disse chiaramente: mister President, lei sa quale opinione ho della guerra in Iraq. Discutiamo di altro. Ogni violenza, contro uno o un milione, era una bestemmia diretta all’immagine e alla somiglianza di Dio. Non accettava che l’essere umano cercasse di risolvere le differenze con gli altri attraverso la violenza, come gli animali».
Molti grandi santi, antichi e moderni, hanno confessato di avere vacillato, di essere stati aggrediti da dubbi. Lo so che sembra una bestemmia, detta per un Papa e oggi un beato, ma Karol Wojtyla credeva davvero davvero, come dice lei, in Dio?
«Penso che possa rispondere qualsiasi persona che lo abbia visto e seguito. La sua fede la si vedeva.
Alla fine ormai della sua vita, nel 2005, quando dovettero praticargli una tracheotomia all’ospedale Gemelli per permettergli di respirare e quindi non poteva parlare, in sala post-operatoria fece un gesto. Sembrava voler dire qualcosa che non poteva dire. La suora capì. Gli portò un cartoncino con un pennarello. Lui ci scrisse sopra con decisione, a grandi lettere irregolari: TOTUS TUUS. Era mettere per iscritto la sua accettazione di quello che Dio voleva per lui anche in quel momento».
Era rassegnato.
«No, era convinto della propria totale appartenenza a Dio, attraverso l’intercessione di Maria. Ho detto convinto, perché questa era stata la motivazione profonda di tutta la sua vita di Papa. Non voleva vincere, voleva convincere, come lui stesso era stato convinto dallo Spirito quando era un giovanotto che giocava a calcio come portiere e remava sul suo adorato kayak in Polonia».
Ma il duello contro l’Urss, i regimi, le burocrazie comuniste lo aveva pur vinto.
«Vincere non era una parola che appartenesse alla sua filosofia, al suo orizzonte interiore».
Eppure fu costretto a una sfida che al mondo apparve un duello senza quartiere attorno alle sorti della sua Polonia, nel 1980. Il tempo di Solidarnosc e di Lech Walesa…
«In quei anni di tensione Ronald Reagan gli scriveva molto, gli mandava a Roma l’ambasciatore Vernon Walters, ex generale, uno dei pochi ambasciatori americani che parlassero le lingue, poi il consigliere per la sicurezza nazionale Bob McFarlane. Reagan parlava allora della Russia come “l’impero del male”: un’espressione che il Papa non avrebbe mai usato sapendo che il cristianesimo esisteva in Russia da mille anni prima. Era inevitabile vedere in loro due strade diverse. Il fine che muoveva Giovanni Paolo II non era l’America o l’anticomunismo, e neanche in fondo una qualsiasi
forma di società neo capitalistica e libertaria idealizzata, bensì la dignità assoluta e trascendente della persona umana che è capace di scegliere il proprio destino. La sua originalità era la potenza dei valori antropologici universali e la fede incrollabile nella persona umana in quanto tale».
Forse perché il Papa non ha divisioni corazzate, come diceva Stalin.
«Aveva una forza diversa e il Cremlino se ne accorse presto. Non è molto noto ma, in quel 1980, i satelliti spia e gli Awacs fotografavano i movimenti delle truppe della Germania comunista che si dispiegavano sul confine occidentale della Polonia, da dove sarebbe partita l’invasione che tutti temevamo. Io ero a Varsavia in quei giorni e andavo a dormire convinto che mi sarei svegliato con i carri sovietici in strada. Era dicembre e Giovanni Paolo II scrisse una lettera personale e privata a Leonid Breznev».
Come Leone Magno con Attila? Per ordinargli in nome di Dio di non toccare la Polonia?
«No, sarebbe forse stato un errore, avrebbe fatto infuriare il Cremlino e offeso l’orgoglio dei sovietici. Gli scrisse, con grande chiarezza e con la conoscenza diretta che aveva di quei regimi e della loro mentalità, solo per ricordargli che appena cinque anni prima, nel 1975, lui stesso, Breznev, aveva firmato a Helsinki un trattato solenne in cui l’Urss si impegnava a non interferire negli affari interni di ogni altra nazione europea. Dunque, se avesse invaso la Polonia avrebbe violato la sua stessa parola, la parola dell’Unione Sovietica».
E Breznev rispose?
«Sì, ma non con una lettera, né per via diplomatica. La sua vera risposta fu la rinuncia all’azione di forza. Eppure Breznev sapeva, come sapevamo tutti, che lasciare la Polonia al proprio destino sarebbe stata la fine per la stessa Unione Sovietica e che il sogno del Papa, che era un’Europa dall’Atlantico agli Urali, ma senza il dominio di una potenza, si sarebbe inesorabilmente avvicinato».
La lettera segreta di Giovanni Paolo II fece quello che le potenze militari e la Guerra fredda non avevano saputo fare.
«Quando andammo a Praga nel 1990, pochi mesi dopo la caduta del Muro di Berlino, il presidente Vaclav Havel ricevette il Papa all’aeroporto e, da buon letterato, gli disse: “Io non so se so che cosa è un miracolo. Ma oggi mi sembra di vedere un miracolo”».
Un miracolo politico, diplomatico, strategico. Il profeta disarmato che distrugge la massima potenza militare del mondo.
«Questo era chiaro, ma non si deve pensare a lui come a un leader politico in abito religioso, deciso a cambiare regimi e confini. Non salì sulla cattedra di Pietro per liberare l’Europa dell’Est dal comunismo, ma per diffondere il messaggio dell’assoluta centralità della persona umana, della creatura, che esiste come tale perché ha un creatore, e in quella verità deve ritrovarsi. Questa era l’essenza postmoderna, post-ideologica, post-esistenzialista, dunque implicitamente post-marxista e leninista, l’essenza cristiana della sua predicazione».
Ci fu però un’altra risposta, un anno dopo la resa sovietica di fronte alla Polonia. In Piazza San Pietro. Il giorno 13 maggio del 1981. Ali Agca.
«La sofferenza era già entrata nella sua vita da anni ma probabilmente quello fu il suo primo incontro, brutale, inaspettato, con il dolore fisico: uomo robusto e sano, non lo aveva davvero mai affrontato. La prima di una serie tremenda di prove».
La corsa all’ospedale Gemelli, destinato a diventare il “Vaticano 2”. Il complicato lavoro dei chirurghi sull’intestino, perforato da due dei quattro proiettili sparati dall’aggressore, con colostomia temporanea.
«Era ancora cosciente, sull’ambulanza. Perse i sensi arrivando in ospedale, per la perdita di sangue e il crollo della pressione sanguigna. Ma riuscì in un momento di lucidità a dire ai medici di lasciargli al collo lo scapolare, il rettangolo di stoffa dei carmelitani dedicato alla Vergine. Fu operato con lo scapolare addosso, quella volta e in tutti gli interventi successivi che dovette subire».
Ebbe la certezza dell’intervento provvidenziale, «materno» come lo definì, della Madonna per deviare le pallottole e non colpire organi vitali. Ci fu chi lo accusò di un peccato di superbia, per averlo pensato.
«È esattamente il contrario. Per una persona che ha il senso della totale dedizione alla Madonna, è
semmai un riconoscere di aver ricevuto un dono e di avere un debito».
Ma qualche dubbio doveva averlo.
«Non sull’attentato ma sul possibile collegamento dell’attentato con il terzo segreto di Fatima. Per questo prima di far pubblicare quel testo anni dopo, mandò il cardinale Tarcisio Bertone, allora segretario della Dottrina della fede sotto il cardinale Ratzinger, in missione da suor Lucia, l’ultima superstite dei tre bambini che videro la Madonna. Voleva essere certo, sapere se l’ultimo segreto fosse davvero la profezia dell’attentato al Papa. Bertone chiese a suor Lucia se questa interpretazione fosse coerente con quello che la Madonna le aveva rivelato. Suor Lucia rispose di sì; che era coerente con quanto lei aveva scritto con l’ingenuità di una bambina di allora dieci anni che lo aveva visto attraverso questa immagine. Fece inviare a Fatima il bossolo di un proiettile sparato da Agca che ora è incastonato all’interno della corona della Vergine nel santuario».
Credette dunque alla «mano materna che aveva deviato un’altra mano». Ma chi aveva mosso invece la mano assassina di Agca? I servizi segreti bulgari appaltati da Mosca utilizzando una marionetta turca? Il Papa lo pensava?
«Rispondo con quello che disse lui stesso andando per la prima volta in visita in Bulgaria dopo la fine del regime: non considero il carissimo popolo bulgaro responsabile collettivamente».
Era un uomo solo, come si dice tanto spesso dei potenti e dei veri grandi?
«No, non lo era né di fatto né per carattere. Raramente era da solo o con il suo segretario, durante i pasti. Riceveva vecchi amici, collaboratori, intellettuali… Erano occasioni stupende per conversazioni informali. C’era nella sua vita sempre ampio spazio per l’interazione. Giovanni Paolo II non era mai solo, perché non voleva esserlo. Però questa facilità nei contatti umani non lo privava della solitudine riflessiva, il pensare da solo».
Nessun amico, nessun cardinale, neppure l’amatissimo cardinale Ratzinger, nessun addetto stampa possono però mai essere tua madre, tuo fratello.
«Ricordo che quando una volta gli domandai chi lo avesse accompagnato il giorno in cui fu ordinato sacerdote, lui mi rispose: “A quell’età avevo già perso tutte le persone che avrei potuto amare”. Sul tavolino accanto al suo letto di morte c’era la piccola foto del padre e della madre che gli era stata regalata in uno dei viaggi all’estero».
L’incontro con la sofferenza morale era avvenuto molto presto, da ragazzo. La salita sul monte della sofferenza fisica sarebbe cominciata quel giorno in piazza San Pietro e non si sarebbe più fermata fino al morbo di Parkinson, l’umiliazione finale del suo messaggio, il male che colpisce la gestualità, l’espressività. Perché attendeste tanti anni, dodici, per ammettere che ne era stato colpito?
«Perché non ce n’era bisogno. Il Parkinson, con quel tremore incontrollabile alle mani e la rigidità dei muscoli facciali, è una malattia che qualunque studente di medicina del primo anno, qualunque persona che ne sia stata colpita o che abbia un parente che ne sia stato colpito, può diagnosticare guardando un minuto la persona che ne soffre. Lei pensa che è necessario presentare una persona incinta di sei mesi dicendo che è incinta? Lo si vede; è evidente. Anche nella patologia, Wojtyla non poteva e non voleva nascondere nulla».
Vedeste insieme, e a volte lei da solo, i cosiddetti grandi del mondo. Lei andò in missione a Mosca, poi a Pechino per coronare il sogno di un viaggio in Russia e in Cina… «Che non si fecero….». …e a Cuba dove invece riusciste.
«Parlai a lungo, dalle otto di sera alle due del mattino, con Fidel Castro, e così si sistemarono alcune precondizioni al viaggio del Papa. Nei colloqui privati non gli parlai mai della sua educazione presso i Gesuiti, fu lui a ricordarla a me».
Si rendeva conto, il Papa, che avrebbe celebrato messe in chiese in cui si mescolavano tranquillamente il cristianesimo con la santeria, le Madonne con i Serpenti di Mare?
«Lo sapeva benissimo. E questa conoscenza era una ragione in più per quel viaggio. La gente aveva bisogno delle sue parole, del suo insegnamento che non trovavano da nessuna parte per la scarsità del clero, l’isolamento cubano e le difficoltà di formarsi».
Le diceva tutto, sui suoi colloqui privati con capi di stato o di governo?
«Raccontava i termini dei colloqui e lasciava decidere che cosa era necessario dire all’opinione pubblica. Naturalmente faceva con tutti loro riflessioni profonde di carattere etico. Un giorno ricevette un capo di stato autocrate e violento. Uscendo, dopo il colloquio, commentò quasi tra sé: “Sembra quasi un agnellino”».
Come vedeva gli Stati Uniti, i suoi presidenti?
«Ammirava moltissime cose dell’America, l’apertura, la mobilità sociale, il senso religioso che pervade la vita e non solo la Costituzione. Ha conosciuto e incontrato cinque presidenti americani.
Si comportava allo stesso modo con tutti, con Carter, con Reagan, con Bush padre, con Clinton, con Bush figlio. Di Bush giovane apprezzava, per esempio, la legge che ritirava i finanziamenti pubblici alla ricerca sulle staminali embrionali, non le guerre».
Dunque non poteva apprezzare molto Clinton, che era dichiaratamente pro aborto.
«Il presidente Clinton aveva una certa simpatia naturale. E Clinton, che ammirava Wojtyla, ha scritto: “Non vorrei mai fare una campagna elettorale contro di lui”».
E con Reagan?
«Si sono incontrati diverse volte. Parlavano in profondità ma avevano due missioni diverse anche se alla fine storicamente hanno coinciso. Erano come due linee parallele: la diplomazia della forza e la forza delle virtù».
Come guardava all’Italia, alla vita politica italiana?
«Con enorme tenerezza. In Italia facemmo più di duecento viaggi, visite, pellegrinaggi, e quella sua scelta celebre di rivolgersi alla folla in Piazza San Pietro usando l’italiano…».
… se sbaglio mi coriggerete?
«…Appunto. Fu la testimonianza di quell’affetto, del riconoscimento all’Italia che aveva donato mezzo millennio di papi. Seguiva la politica italiana ma non le scaramucce quotidiane. L’ho detto, non era un politico. Quando andò in Parlamento si rivolse alla nazione italiana, non a questo o quel gruppo; parlò di valori, non di destra o sinistra. Guardava spesso i titoli dei telegiornali alla sera e poi basta. Ma il capitolo di una sua amicizia italiana è tutto da ricordare».
Sandro Pertini.
«Sì, il presidente Pertini. Nel giorno dell’attentato, Pertini si fece portare all’ospedale Gemelli e restò in attesa dell’esito dell’intervento, come un parente prossimo, tempestando di domande medici e infermieri, lui che non era credente. Restò fino alle rassicurazioni dell’équipe dei chirurghi. Soltanto dopo cinque ore tornò al Quirinale».
Wojtyla ricambiò questo gesto?
«Ci provò. Quando seppe che l’ex presidente stava morendo, nel 1990, il Papa andò discretamente nell’ospedale dove era ricoverato. Chiese di vederlo, di parlargli per un’ultima volta perché lui sapeva che Pertini lo avrebbe voluto salutare».
Forse sperava in una conversione sul letto di morte.
«Questo non lo so. Non conosco i pensieri del Papa né quelli di Pertini. Forse voleva soltanto confortare un moribondo, da uomo a uomo. Se avesse voluto anche il conforto religioso, il Papa sarebbe stato lì, il prete accanto al moribondo».
Riuscì a vederlo, prima che morisse?
«No. Non lo lasciarono entrare nella stanza dell’amico. Quando il Papa si sentì negare il permesso, chiese soltanto che gli portassero una sedia. Se la fece sistemare nel corridoio sul quale dava la stanza del Presidente e rimase a pregare in silenzio e in solitudine, per il vecchio amico che se ne stava andando. Dopo parecchio tempo si alzò e disse che tutto era già fatto. E, altrettanto discretamente, tornò in Vaticano. Non volle dare nessuna pubblicità alla cosa».
C’era, anche in tanti che avrebbero voluto ascoltare la sua voce, la delusione per il suo conservatorismo dottrinale e inflessibile in materia di amore, di sesso, di omosessualità, di sacerdozio femminile, di celibato sacerdotale. Sembrava stridere così violentemente con la sua persona pubblica, con la fisicità di cui abbiamo parlato. Eppure era entrato in seminario a diciannove anni, dunque aveva visto e conosciuto la vita.
«Concordo con il giudizio di tanti studiosi – dentro e fuori la geografia cattolica – che il più originale contributo del pensiero di Wojtyla è la sua concezione della persona umana. Ne parlammo molto.
Prima ancora di parlare di peccato, di legge divina, di morale, Wojtyla vedeva la natura umana, della quale tutti siamo portatori. Oggi, “natura umana” è un’espressione politicamente scorretta, si tende di più a parlare di “genere”, di “costruzione sociale” come antagonista alla natura. Ma anche se la cultura prende origine nell’azione, questo non vuole dire che non sia naturale. E la natura umana ha una sua eloquenza evidente».
Negarlo sembra la negazione della libertà morale, dunque della salvazione?
«Giovanni Paolo II pensava che all’essere umano – e soltanto all’essere umano – appartiene anche il dover essere. Questo fa dell’uomo una “persona”. Anche gli animali sono, ma non devono essere niente altro di ciò che sono; la loro perfezione è biologica. Nell’uomo la perfezione non è di natura biologica ma morale. Naturalmente si può rifiutare la questione del “dover essere” ma in questo caso l’uomo sta rifiutando se stesso, sta rifiutando di essere ciò che è».
Era quella intransigenza che i critici avvertivano dietro la sua personalità, la sua figura così affascinante?
«Non c’era nessuna contraddizione, se ci pensiamo. L’intransigenza morale, sui principi che hanno a che vedere con la verità, che non era intellettualmente negoziabile, si accompagnava sempre alla sua infinita, illimitata pietas, alla comprensione, alla tolleranza per la persona. La discussione è sulle idee e, alla fine, sulla verità; la persona merita di più che la discussione. E questo lo portava esattamente a quello di cui l’essere umano aveva per lui un bisogno assoluto: la misericordia, soprattutto quella divina».
Ma prima la devi accettare, questa misericordia?
«Certo e la puoi rifiutare, ma allora si entra nel vuoto della solitudine assoluta, nel buio più completo. Quando lo sentivo parlare, si vedeva insieme la profondità della sua fede e la ricchezza del suo pensiero. O se si vuole, della enorme ragionevolezza della religione e della fede».
Un uomo allegro che predicava non il diritto a non soffrire, come scrive oggi la scienza, ma quasi il dovere di soffrire?
«Direi piuttosto, l’inevitabilità della sofferenza. Con un realismo ottimista ma non ingenuo, pensava che imparare a vivere è anche imparare a soffrire. La sofferenza è l’ambito dell’umano, è la condizione del nostro essere, è ciò di cui abbiamo paura. Non soltanto la sofferenza fisica, ma quella spicciola, quotidiana, il figlio che ti fa penare, il sogno che non si avvera, l’amico che ti tradisce, il mondo che sembra impazzire, tutto quello che ci fa soffrire ma che non ci farà mai andare da un medico perché nessun medico può curare o lenire queste cose».
Eppure l’insegnamento della Chiesa sembra essere così spaventato da questo nostro corpo, dalle sue pulsioni, dai suoi desideri.
«Non per Wojtyla. E io penso nemmeno per la Chiesa. Non aveva nessuna paura del corpo.
Accarezzava e benediva la pancia delle donne incinte, faceva sport – quando poteva, e cioè non con la frequenza necessaria – lottava tenacemente per tenere in funzione il proprio corpo anche quando era logoro e già non rispondeva agli impulsi. Amava il corpo perché con il corpo l’essere umano si inserisce nella storia: nella storia umana e in quella della salvezza. Ma a questo amore per il corpo si aggiungeva il rispetto che un corpo – il proprio e quello degli altri – merita proprio perché non è un ammasso di cellule ma la condizione storica della persona. Di tutto questo rimane un suo magnifico libro – Uomo e donna lo creò – che è già un classico non soltanto della letteratura cristiana ma anche del pensiero umano».
Anche a rischio di apparire crudeli, ingenerosi, verso chi risponde ad altri richiami, a chi vorrebbe scegliere la propria fine?
«Anche a rischio di questo perché la più terribile delle crudeltà sarebbe ingannare trattando gli altri come cose anziché come persone».
Un rischio che il successore, Papa Ratzinger, corre anche di più, non mostrando quella fisicità, quella corporeità che Wojtyla esprimeva.
«Ma questo è soltanto l’aspetto esteriore. Si dovrebbe riflettere su quanto profonda fosse la sintonia fra questi due uomini pur tanto diversi fra loro. Era stato lui a chiedere a Ratzinger, nel 1981, di venire a Roma, e poi a trattenerlo anche dopo l’età del pensionamento quasi, direi, contro la sua volontà».
Aveva bisogno di lui?
«Probabilmente, sì».
Si può parlare di un capolavoro del pontificato di Wojtyla?
«Per me, il suo capolavoro è stato quello che verrà confermato nella sua beatificazione. Il capolavoro che, con l’aiuto di Dio, lui ha compiuto in se stesso: aver detto di sì fino all’ultimo momento a tutto quello che Dio gli chiedeva. La sua totale disponibilità ad essere quello che Dio gli domandava che fosse, sia quando era un giovane uomo vigoroso sia quando non ce la faceva più.
Quando voleva parlare alla finestra e non ci riusciva e si agitava prima di calmarsi. Totus tuus, non ce la faccio più, e subito dopo Totus tuus. Questo era il presagio di santità che vedevo in lui, come mi avevate chiesto all’inizio, fino al momento in cui si arrese all’ultima volontà divina, che era quella di tornare alla casa del Padre. Non scelse di morire. Scelse – ancora una volta nella sua vita – di accettare quello che un Altro aveva scelto per lui».
Erano le 21,37 del 2 aprile 2005, quando il tracciato cardiografico si appiattì e il dottor Buzzonetti, medico pontificio, certificò la fine. Alla finestra della sua stanza nel Palazzo apostolico, fu accesa la piccola candela della tradizione polacca per i morti. Suor Tobiana gli posò la mano sulla testa.
Attorno al letto di morte del Papa, «senza che ci fosse stato prima un accordo» dice ora Joaquin Navarro-Valls, suore, infermieri, preti cominciarono a intonare il Te Deum laudamus, non una nenia funebre, ma l’inno cristiano più solenne e trionfale del ringraziamento. Ringraziamento non per una morte, ma per tutta la vita straordinaria nell’ordinario quotidiano che l’aveva preceduta.
La piazza, là sotto, era piena, ma silenziosa. Le voci del «Santo subito» avrebbero presto riempito quel silenzio.
in “la Repubblica” del 24 aprile 2011
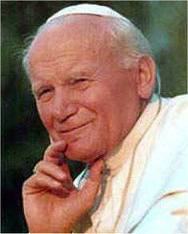
ARTICOLI CORRELATI
Wojtyla beato di Massimo Faggioli in Europa del 30 aprile 2011
“questa beatificazione è anche la presa d’atto che il pontificato di Giovanni Paolo II ha ridetto il cattolicesimo contemporaneo, che non si lascia ridurre ad un’unica ed esclusiva dimensione teologica o ideologica: con buona pace degli atei devoti, dei lefebvriani di complemento à la de Mattei, e dei chierici del dissenso di Micromega”
- La verità di Wojtyla intervista a Joaquìn Navarro-Valls a cura di Aldo Maria Valli in Europa del 30 aprile 2011
Anticipiano alcuni stralci dell’intervista di Aldo Maria Valli con Joaquín Navarro-Valls che apparirà nel fascicolo di maggio della rivista “Studi cattolici”. “Lui diceva loro che erano molto superiori alle ipotesi che la cultura moderna offriva su loro stessi. Sapeva aprire loro orizzonti antropologici e religiosi che nessuno osava proporre ai giovani.”
“Domani tutti costoro… guarderanno – mi domando – in alto e penseranno che una storia umana si è definitivamente conclusa e c’è un altrove? Penseranno alla beatitudine di Giovanni Paolo II? A cos’altro penseranno? «Sta in silenzio davanti al Signore e spera» recita l’inizio del Salmo 36. È un Salmo bellissimo, colmo di conforto. Ma anche colmo di vuoto, nella semplicità di questo versetto, per i cristiani. Perché i cristiani devono credere e sperare in cose impossibili…”
“Un’opzione rischiosa ma al contempo feconda è stata quella scelta da Alberto Melloni… che ha individuato «Le cinque perle di Giovanni Paolo II» (Mondadori), cioè «i gesti di Wojtyla che hanno cambiato la storia», come recita il sottotitolo… mi sembra che la «perla» chiave che ha in sé la capacità di suscitare le altre sia proprio la prima: la valorizzazione del Vaticano II…”
“da Papa Wojtyla può venire un messaggio anche per la festa del lavoro. Per cui si può ben immaginare e auspicare un filo diretto che da Piazza S. Pietro giunge a Piazza S.Giovannni.”
“Tra i motivi di grande attualità dell’azione svolta da Giovanni Paolo II c’è soprattutto il tema dell’accoglienza. (…) Una lezione tanto piu utile e necessaria oggi che anche nella comunità ecclesiale, sul tema immigrazione, non tutte le sensibilità sono armonizzate, vista anche la contiguità, assai discutibile, con alcune posizioni politiche. (…)
29 aprile 2011
Per “essere in comunione con Roma”, “essere presenti”, “rendere omaggio” o semplicemente “dire grazie a Giovanni Paolo II” … numerosi momenti di preghiera e celebrazioni ritrasmesse su grandi schermi… Dediche di vie, centri pastorali, vetrate di chiese… statue (di m. 1,30 a Neudorf, m. 1,80 a Aix, di m. 3 a Fourvière, di m. 3,80 a Parigi…) … e anche un flash-mob di danza…
Gli “anni di Giovanni Paolo II” restano per molti cattolici sinonimo di dinamismo e fierezza. “Beatificando rapidamente Giovanni Paolo II, il Vaticano si sforza di riattivare quel momento di grazia che si è da allora assopito, sottolinea Portier. Bisogna ricordarsi che, dopo il pontificato depressivo di Paolo VI, quello di Giovanni Paolo II ha mostrato che la Chiesa poteva ancora essere piena di vitalità, sicura di se stessa, capace di guadagnare punti sullo scacchiere demografico e politico”
“Almeno in due campi – predicazione della pace e rapporto con le religioni non cristiane – Papa Wojtyla è andato in avanscoperta, oltre le indicazioni che erano venute dal Vaticano II. Quando i due temi coincidevano – come nelle tre «giornate» interreligiose di Assisi: 27 ottobre 1986, 9-10 gennaio 1993, 24 gennaio 2002 – egli si affidava al genio dei gesti simbolici.”
“Il malessere della Chiesa si è aggravato a causa del fatto che essa non ha accettato di cambiare. Piuttosto essa è regredita nell’utero materno, si è aggrappata alla Roccia Polacca per non avere le vertigini. Il rischio è che questa beatificazione si trasformi, nella gestione di alcuni settori cattolici identitari, in un tentativo di riprodurre il wojtylismo e dunque il nuovo regime di cristianità oltre Wojtyla, bloccando ulteriormente i cambiamenti. A meno che Benedetto XVI non trovi il coraggio di rovesciare il piatto”
28 aprile 2011
“i santi, tutti i santi, sono uomini e come tali non possono essere perfetti”. Sbaglia dunque il Vaticano che da tempo cerca di staccare Wojtyla dal suo pontificato: “Impossibile staccare l’uomo dalle sue azioni” e per questo Wojtyla va beatificato.
Il 1 Maggio Giovanni Paolo II verrà beatificato: due voci opposte a confronto. ” Io considero Karol Wojtyla il più grande oscurantista del XX secolo. …. Il nemico è l’illuminismo: questo è il filo rosso di tutta la sua predicazione. La presunzione, mostruosa secondo lui, che l’uomo prenda in mano il proprio destino prescindendo dall’obbedienza a Dio”(Flores D’Arcais “Nella memoria popolare,…, non attecchisce l’idea del papa oscurantista. Ha aperto nuovi orizzonti al cattolicesimo. Il rapporto con gli ebrei: …. Ha posto con forza la questione dei diritti sindacali sul finire del secolo XX, specie dopo la caduta del comunismo… L’autocritica sugli errori del passato …”(Politi)
“C’è chi dice che è stato fatto beato troppo presto. Concorda? «aspettare uno o due anni in più non avrebbe molto significato. Esiste nei confronti di Wojtyla un certo revisionismo: la sua grandezza scandalizza la stretta misura sia di alcuni laici sia di alcuni ecclesiastici. Per altro verso, lui si è sempre sentito un uomo del Concilio Vaticano II, come è evidente anche dal suo testamento»”