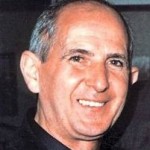La trasformazione del pianeta in “villaggio globale”, accelerata dall’esperienza della realtà virtuale consentita dall’universo multimediale e dal “web”, incide anche sulla sfera religiosa e spirituale.
Fenomeni come il New Age o Era dell’Acquario, dall’impatto vastissimo soprattutto nella cultura nord- e sud-americana sembrano rispondere al bisogno di rassicurazione prodotto dall’accelerazione dei cambiamenti attraverso una sorta di “gnosi” per il popolo, in cui le sub-culture prodotte dalla dipendenza mediatica trovano garanzie psicologiche e consolazioni a buon mercato, convenienti alle finalità delle grandi agenzie di consenso economico e politico del pianeta.
Ecco perché diventa urgente individuare come il cristianesimo – nella varietà dei contesti e delle sue tradizioni confessionali e specialmente nella pienezza della sua espressione cattolica – debba contribuire a costruire in rapporto ad esse un’umanità più giusta e felice, più unita e conforme al progetto divino di salvezza.
Tre ambiti di impegno si lasciano riconoscere come ineludibili per tutte le Chiese e per il loro cammino comune: la risposta da dare al nuovo bisogno di spiritualità, l’urgenza emergente della cattolicità e l’impegno al servizio della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato.
Si può dire che la riflessione della fede del terzo millennio si giocherà intorno alla martyrìa allakoinonìa e alla diakonìa, vissute dai cristiani. La via della martyrìa corrisponde a una ritrovata esigenza di spiritualità emersa dalla parabola dell’epoca moderna: c’è bisogno di una teologia più teologica, più collegata al vissuto spirituale.
La modernità aveva separato, se non addirittura contrapposto, il momento razionale e il momento esperienziale della vita, producendo quel divorzio fra riflessione e spiritualità, che aveva reso anche la teologia piuttosto arida e intellettualistica e la spiritualità piuttosto sentimentale e intimistica.
L’epoca post-moderna spinge a saldare nuovamente questi due ambiti: l’alternativa della fede all’astrattezza dell’ideologia sta nella possibilità di sperimentare un rapporto personale con la Verità, nutrito di ascolto e dialogo con il Dio vivo. La Verità non è qualcosa che si possiede, ma Qualcuno dal quale lasciarsi possedere.
Secondo la critica di moda negli anni dell’ideologia rampante, la dimensione contemplativa della vita sembra offrirsi come riserva di integralità umana e di autentica socialità. Si può quindi supporre che il futuro del cristianesimo o sarà più spirituale e mistico, e ricco di esperienze del Mistero divino, o potrà ben poco contribuire alla crisi e al cambiamento in atto nel mondo. La ricerca di un nuovo consenso intorno alle evidenze etiche domanda ai cristiani una risposta a partire dalla testimonianza specifica della loro fede nel Dio di Gesù Cristo, anche per evitare il rischio non indifferente di “riduzione al minimo comun denominatore”, che sembra emergere in alcuni approcci interreligiosi alla questione etica.
Accanto alla via della martyrìa, quella della koinonìa corrisponde alla nostalgia di unità che si affaccia nella “globalizzazione” del pianeta. In particolare, in Europa – culla delle divisioni fra i cristiani – la disgregazione seguita al crollo del muro di Berlino e l’emergere violento di regionalismi e nazionalismi sfidano le Chiese a porsi come segno e strumento di riconciliazione fra loro e al servizio dei loro popoli.
Sul piano teologico è significativo che la riflessione ecumenica, dopo aver dedicato una privilegiata attenzione alle forme sacramentali, si concentri sul tema della koinonìa, che esprime non solo un’esigenza di ripensamento ecclesiologico riguardo alla struttura e alla vita interna delle Chiese, ma anche un’attenzione alla sfida che il bisogno di unità emergente dalle nuove divisioni pone alle comunità cristiane.
Emerge una nuova, diffusa attenzione alla “cattolicità”, intesa sia secondo il suo significato di universalismo geografico, reso più che mai attuale proprio dai processi di “globalizzazione” del pianeta, sia secondo il senso di pienezza e totalità, che rimanda all’integralità della fede e della attualizzazione della memoria del Cristo.
Non sorprende allora che in ambito ecumenico si dedichi nuova attenzione all’unità universale nella Chiesa. Un contributo notevole alla riscoperta della cattolicità, come esigenza e condizione della missione cristiana, viene da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI: il loro pontificato, caratterizzato da un’itineranza apostolica, ha evidenziato la ricchezza della “regionalizzazione” della Chiesa e ha ribadito le esigenze dell’unità dottrinale e pastorale sul piano universale.
La rilevanza di quest’azione è stata palese in alcuni cambiamenti storico-politici, come quello della crisi del “socialismo reale”, ma va considerata soprattutto nella sua specificità spirituale di riproposizione del Vangelo come messaggio di vita e salvezza per le singole situazioni culturali e per la crescita nell’unità e nella pace della famiglia umana. La prima decade del Terzo Millennio indica questa direzione proponendola come un itinerario di conversione e rinnovamento per tutti i credenti, chiamati a far memoria dei doni di Dio, ma anche a riconoscere le proprie colpe, personali e collettive, e a ripensare la propria identità e missione di fronte alle sfide del nuovo millennio cristiano, specialmente in chiave ecumenica e nell’ottica del dialogo interreligioso. Una teologia ecclesialmente responsabile e aperta alle esigenze della cattolicità sembra più che mai necessaria.
Infine, la testimonianza evangelica della carità come diakonìa, nell’impegno per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato, appare come il terzo grande campo di azione per il cristianesimo degli inizi del Terzo Millennio in tutte le sue espressioni confessionali: le sfide della giustizia sociale sono oggi interconnesse con i rapporti internazionali di dipendenza e con la questione ecologica.
Lo stretto intreccio appare con grande chiarezza quando si considerino i processi in atto nella “globalizzazione”, superando visuali regionalistiche, a volte troppo chiuse: il cristianesimo, religione universale diffusa nei contesti storici e culturali più diversi, appare qui soggetto privilegiato per tener desta una coscienza critica attenta a difendere la qualità della vita per tutti e capace di farsi voce specialmente di chi non ha voce e fronteggiare, con un impatto morale e spirituale di grande portata, le logiche esclusive ed egoistiche delle grandi agenzie mondiali di potere economico e politico.
Di fronte alla crisi mondiale e all’avidità da cui essa è stata generata la testimonianza del primato della carità è una sfida e una promessa. I credenti devono contare solo sulla vitalità della loro fede e l’operosità evangelica: tuttavia, il patrimonio spirituale che si esprime nella vastissima rete di opere di volontariato e di solidarietà che la Chiesa ha espresso con creatività, anche nel nostro tempo di mutamenti rapidi e spesso drammatici, costituisce al tempo stesso un contributo e una proposta all’umanità intera per l’edificazione di un “villaggio globale” che sia più a misura umana.
È significativo che la Chiesa sia intervenuta in termini inequivoci con l’Enciclica di Benedetto XVI Caritas in veritatesull’attuale forma in cui si presenta la questione sociale. I cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni del secolo richiedono però a tutte le Chiese di far propria la denuncia del sistema di dipendenze che regge i rapporti specialmente fra il Nord e il Sud del mondo. A tutti è domandato di contribuire a individuare una via economico-politica che superi le rigidità del collettivismo e dei suoi fallimenti storici, e gli egoismi miopi di un capitalismo assolutista e accentratore. Una teologia “militante” nel servizio della carità e della ricerca di una più grande giustizia appare qui come compito e sfida ineludibile.
di Bruno Forte
da AVVENIRE 10/7/12