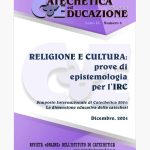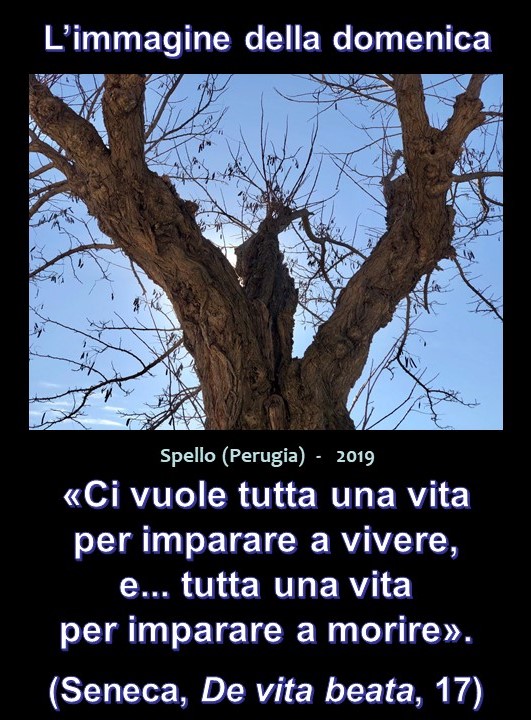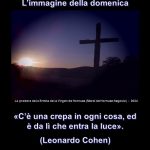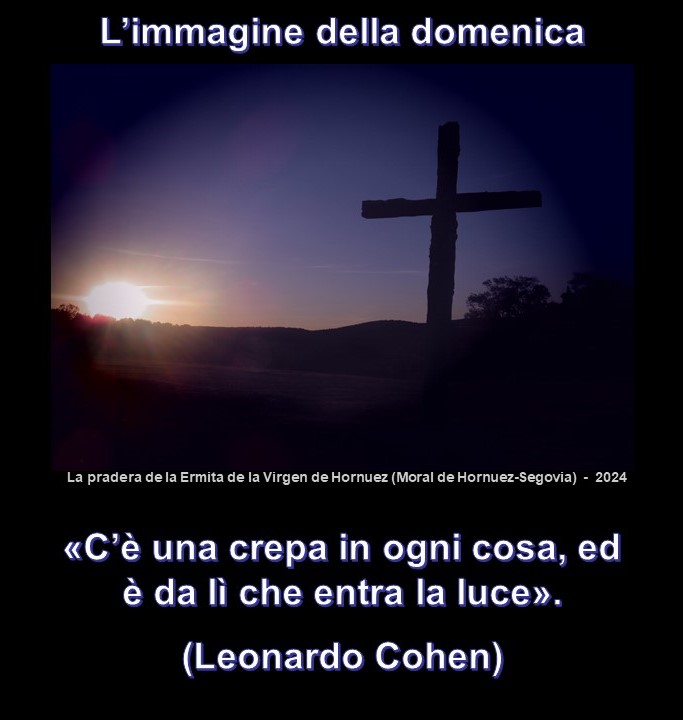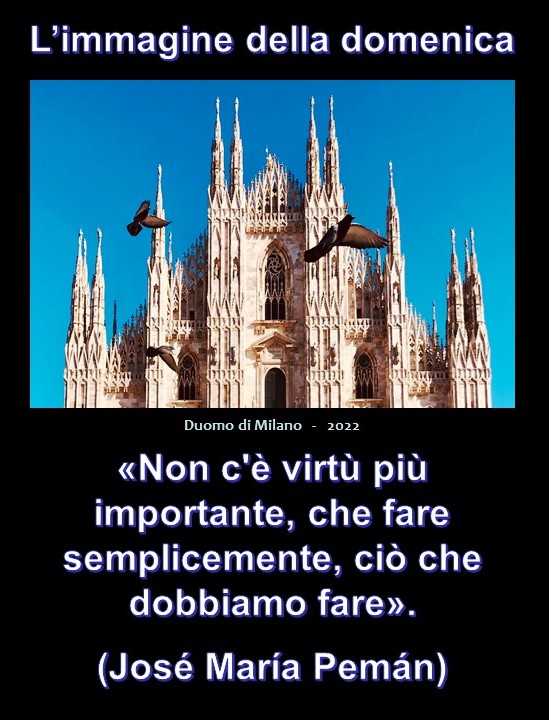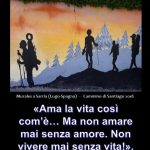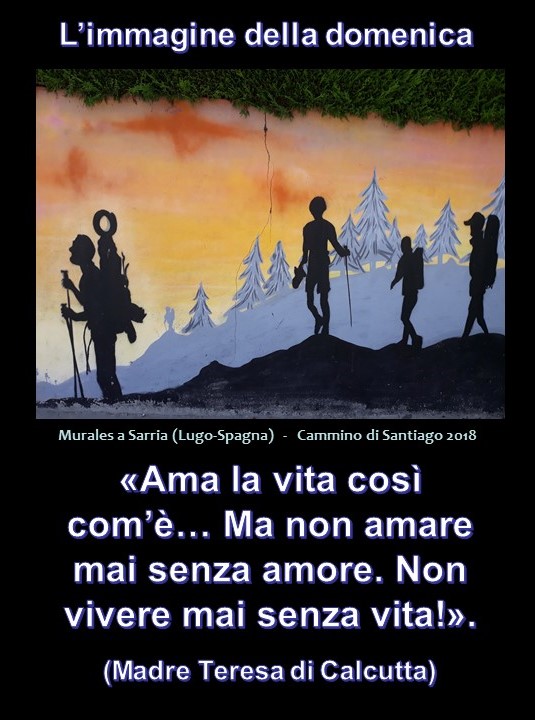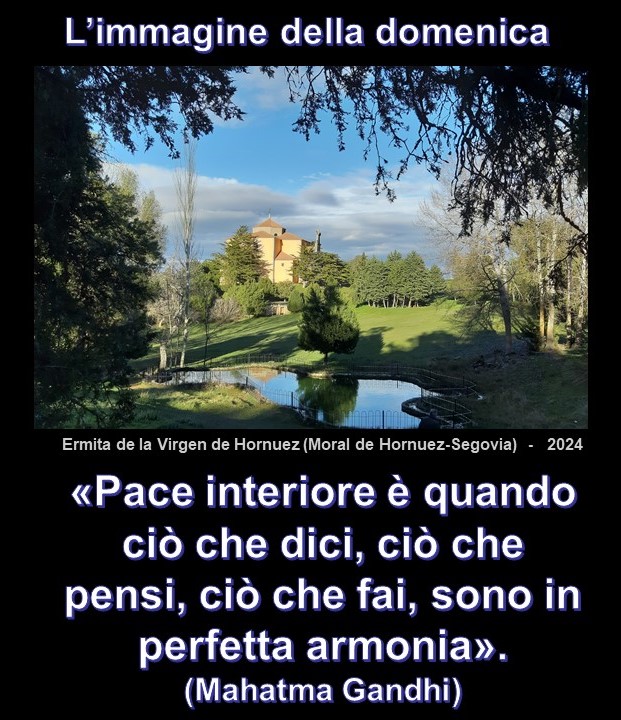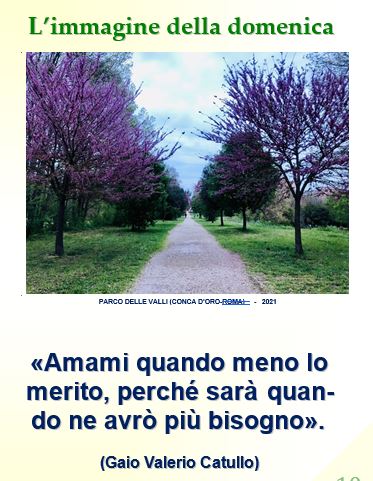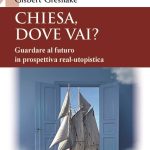Lectio – Anno C
Prima lettura: Giosuè 5,9-12
| In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto». Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al quattordici del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, àzzimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli Israeliti non ebbero più manna; quell’anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. |
- Aria di novità, di ‘riconciliazione’ si respira nella prima lettura. Si conclude la lunga esperienza di permanenza nel deserto e si prepara l’ingresso nella Terra Promessa. È come un ritorno a casa, un incontrare Dio in modo rinnovato. Il capitolo inizia con la circoncisione di tutto il popolo: Giosuè lo vuole preparare al passo decisivo.
La lettura inizia con una proclamazione ufficiale di avvenuta riconciliazione, perché Dio dice a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto». È conclusa la ‘lunga quaresima’ della peregrinazione; è stato un tempo di purificazione e di esperienza di Dio. Il popolo, ora rinnovato e riconciliato da Dio stesso, può celebrare la Pasqua nella terra promessa. Un mistico abbraccio unisce nuovamente Dio al suo popolo.
Un segno concreto è dato dalla possibilità di mangiare «i frutti della terra di Canaan», la loro nuova terra. Si apre un nuovo periodo, una nuova epoca, di cui la Pasqua segna l’avvio.
Seconda lettura: 2 Corinzi 5,17-21
| Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. |
- Il tema della riconciliazione domina anche la seconda lettura e si inserisce perfettamente nella liturgia odierna.
Dopo una premessa in cui Paolo ribadisce di operare rettamente perché sta sempre alla presenza di Dio, e dopo il rifiuto di cercare ancora una raccomandazione, passa ora a trattare un tema teologico di primaria importanza, quello della riconciliazione.
Nell’affrontare l’argomento, Paolo indica due principi ispiratori che sono anche due guide: il principio cristologico e il principio ecclesiologico. Con il primo si afferma che tutto viene da Dio in Cristo, con il secondo che a Paolo e agli apostoli («noi», 5,19) è affidato il ministero della riconciliazione.
È bello constatare che all’inizio della trattazione sta una attestazione di amore di Cristo: pensando a lui, morto per tutti gli uomini, si imposta correttamente il tema preso in esame. La morte di Cristo apre una certezza di vita che si fonda sulla sua risurrezione: «Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro» (5,15). Prima di offrire agli altri il dono preziosissimo della riconciliazione, Paolo sente di goderne come di un beneficio grande che ha trasformato la sua vita. Ogni altra conoscenza deve scomparire, per lasciare posto all’esperienza di un inserimento nel Cristo pasquale. L’appartenenza a Cristo genera una inedita condizione di vita, bene espressa dal concetto di «creatura nuova»; il greco, a differenza della lingua italiana, usa un termine proprio per indicare una novità qualitativa (kainós) distinguendola da una novità puramente cronologica (néos).
Se è Dio «che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo» (5,19), a lui spetta ogni precedenza e l’iniziativa della riconciliazione. Si esclude così ogni possibilità di appropriazione da parte dell’uomo, beneficiario del dono di Dio. Ma è lo stesso Dio a chiedere collaborazione agli uomini, cosicché il principio teologico-cristologico sfocia in quello ecclesiale: «Era Dio infatti […], affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta» (5,19-20).
La necessità della riconciliazione suppone la peccaminosità dell’uomo. Un compito dell’apostolo sarà appunto di richiamare le strutture di peccato che impediscono all’uomo di costruire una nuova personalità con Cristo: la riconciliazione, infatti, è un atto creativo che risistema una creatura fragile e vittima del peccato. Occorre prendere coscienza del proprio stato e aprirsi all’amore di Dio manifestato in Cristo; questo significa l’accorato appello: «Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (5,20).
Vangelo: Luca 15,1-3.11-32
| In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». |
Esegesi
L’introduzione dei vv. 1-3 fornisce una preziosa chiave ermeneutica al cap. 15 in generale e al nostro testo in particolare. Essi denunciano l’atteggiamento ostile dei farisei che non comprendono perché Gesù sia così accogliente con i peccatori. La parabola è una splendida icona del comportamento di Dio che si riflette puntualmente nel comportamento di Gesù.
Da un punto di vista organizzativo del materiale, osserviamo che dopo una introduzione che mette in scena i personaggi (vv. 11-12), la parabola si articola in due atti di due scene ciascuno, il primo dominato dal figlio minore e dal padre (vv. 13-24), il secondo dal figlio maggiore e dal padre (vv. 25-32); nel secondo atto si rivelerà molto importante se non addirittura decisiva la relazione fratello-fratello.
Introduzione: il padre e due figli (vv. 11-12). Un inizio sobrio ed essenziale presenta i personaggi, il padre e i suoi due figli. I tre creano due tipi di relazioni, la prima quella di padre-figlio sdoppiata in padre-figlio minore e padre-figlio maggiore e la seconda quella di fratello-fratello, relazione non espressa se non verso la fine del racconto e tuttavia di capitale importanza. Dopo i personaggi, ecco l’antefatto che causa il tutto: la richiesta del figlio più giovane di entrare in possesso anzitempo del patrimonio paterno. Il padre, inspiegabilmente, accondiscende, senza reagire negativamente e senza opporre resistenza. Sembrerebbe un uomo indifferente e distaccato. Poiché il seguito mostrerà esattamente il contrario, dobbiamo concludere che egli ha un rispetto sommo del figlio, anche prevedendo un suo sbaglio.
Atto primo: il Padre e il minore (vv. 13-24). Questa parte, sebbene dominata dalle azioni del figlio, ha come sottofondo la presenza del padre.
Prima scena: il minore si allontana e ritorna dal Padre (vv. 13-20a). L’autore della parabola racchiude la prima scena tra un partire (v. 13) e un tornare (v. 20a), due verbi che esprimono un opposto movimento fisico, ma che riveleranno pure due momenti contrastanti nell’animo del giovane. La partenza per un paese lontano vuole significare la distanza dal padre, perfino la sottrazione ad una sua possibile influenza. Il figlio va all’estero (in Israele non si allevavano i porci, cf. invece il v. 15). La partenza avviene all’insegna delle più lusinghiere prospettive perché il figlio minore possiede gli elementi che solitamente la gente considera gli ingredienti della felicità: giovinezza, ricchezza e libertà (intesa qui negativamente come capacità di compiere tutto ciò che si vuole). Sciupato malamente il capitale, subentra l’imprevisto della carestia e quindi della fame. Il lavoro vergognoso per la mentalità ebraica e il disinteresse generale (cf. v. 16) fanno scattare nel giovane un pensiero di ritorno per avere il pane. Il bisogno materiale mette in moto un meccanismo, responsabile di due tipi di ritorno, uno morale e l’altro fisico:
— Il ritorno morale fatto di riconoscimento del proprio errore e di coscienza di aver perso il rapporto padre-figlio. Qui troviamo la grandezza morale di chi è capace di riconoscere e di ammettere il proprio sbaglio, con lucidità e senza reticenze; è lo slancio sincero e umile del giovane che si assume tutta la propria responsabilità; è la umile ammissione del suo errore che fa da contrappunto alla sfacciata presunzione che lo aveva spinto ad allontanarsi.
— Il ritorno materiale, fatto di risoluta decisione maturata alla luce di una riflessione che integrava la vita in una visione meno miope. La prima scena termina con questo ritorno alle persone e alle cose abbandonate, anche se con la coscienza di non possederle più come prima. Il ritorno motivato dal bisogno materiale rivela un atteggiamento di fiducia nel padre che — così egli spera — lo accoglierà come garzone e gli garantirà il sostentamento. Pur con tutto il bagaglio di esperienze negative e di sbagli che il giovane porta con sé, egli dimostra un aspetto non consueto che lo rende grande, in quanto è disposto a riconoscere il proprio errore e ad assumere tutte le conseguenze, prima fra tutte la perdita del suo rapporto di figlio.
Seconda scena. Incontro tra padre e figlio minore (vv. 20b-24). L’iniziale impressione di un padre insensibile o indifferente che lascia partire il figlio senza una parola o un estremo tentativo per trattenerlo, rivela ora tutta la sua infondatezza. Il padre era in attesa, segno che l’amore non si arrende mai, che crede nella vittoria del bene sul male, che spera nel fiorire dei buoni principi insegnati. Solo a questo punto inizia a svelarsi la vera attitudine del padre che con la sua sollecitudine nel correre incontro al figlio indica che lui viveva in perenne attesa che lo portava a sperare e a scrutare continuamente l’orizzonte. Merita speciale attenzione il termine tradotto in italiano con «compassione » (cf. lo stesso verso in Lc 7,33 e 10,33). La parola esprime una compassione profonda che interessa tutta la persona, una tenerezza materna: ecco perché manca la figura della madre: il padre è al contempo anche madre! A questo punto il giovane si esprime con le parole che aveva preparato e manifesta la sua convinzione che, dopo quello che è successo, non è più degno di essere chiamato figlio. Il padre rimane padre, forse lo è ancora di più in questo momento di accoglienza, ma lui non può rimanere figlio perché il suo passato grava su di lui come un’onta incancellabile. Egli vive più di passato che di presente o futuro. Il padre lascia parlare il figlio perché la confessione che esprime il pentimento fa bene, ha benefico effetto liberatorio. Non accetta però le conclusioni proposte dal figlio e non lo lascia terminare: il «Trattami come uno dei tuoi salariati» il figlio non riesce a dirlo, ovviamente perché interrotto dal padre che è attento più al presente e al futuro che non al passato, ora cancellato dal pentimento. Egli non rimprovera, non richiama il passato, perché sarebbe un’inutile riacutizzazione di una ferita non ancora rimarginata. Se il figlio ha maturato e dimostrato il suo pentimento, che bisogno c’è di insistere? La punizione più grave e il rimprovero più severo se li è dati il figlio che accetta di essere non-figlio.
Alle parole del figlio, il padre risponde con una serie di gesti che valgono assai più delle parole. Si rivolge ai servi perché si prendano cura del figlio, come avveniva per il passato, anzi, ancora di più. Il vestito bello (in greco stolè cioè il vestito lungo delle grandi occasioni) indica la situazione di solennità, i calzari che in quel tempo portavano solo poche persone, la dignità, l’anello sul quale era impresso il sigillo di famiglia, l’autorità, e infine l’uccisione del vitello e lo stare insieme a mensa, la gioia, della festa e della condivisione. Tale accoglienza, a dir poco trionfale, necessita una spiegazione: il padre ha lasciato partire il figlio e ora riceve tra le braccia questo mio figlio; aveva visto partire un giovane presuntuoso e arrogante e ora vede ritornare un uomo maturato dal dolore, dalla lontananza e dal pentimento. Nel padre si sprigiona la gioia per il figlio «cresciuto» e la festa che segue valorizza la nuova maturità raggiunta, il nuovo rapporto tra padre e figlio. In questa scena la parola figlio ritorna tre volte e sempre in crescendo: al v. 21 «figlio» appartiene al racconto, poi diventa «non tuo figlio» sulla bocca del giovane, per trasformarsi infine in «questo-mio-figlio» nelle parole del padre. Forse risulta non del tutto comprensibile il comportamento del padre, ma a lui Pascal presterebbe il suo celebre pensiero: «Il cuore ha delle ragioni che la ragione non riesce a comprendere».
Atto secondo: il padre e il maggiore (vv. 2 5-32): fa la sua comparsa l’altro figlio, il maggiore, che movimenta tutto il secondo atto rivelando i suoi sentimenti verso il padre e verso il fratello. Tuttavia anche in questo atto, come nel precedente, il ruolo principale spetterà al padre.
Prima scena: Il ritorno a casa del maggiore (vv. 25-28). Il figlio maggiore che torna a casa sente musica e danze. Interrogato un servo, viene a sapere del ritorno del fratello. La notizia, lungi dal procurargli gioia come era avvenuto per il padre, lo stizzisce: come è possibile che per quello scapestrato spendaccione si organizzi una festa? E più ancora, come è possibile che per lui sia stato ammazzato il vitello che veniva ingrassato per qualche grande occasione, in molti casi proprio per le nozze del primogenito? La sua è una reazione di ostilità e di rottura: «si indignò, e non voleva entrare». Incontriamo ora la seconda annota-zione psicologica, l’ira del maggiore, che contrasta con la commozione del padre nel riavere il figlio minore. Il ritorno del giovane provoca due reazioni contrastanti, la commozione per il padre, ira per il maggiore. La famiglia rimane ancora frantumata dal sentimento di isolamento e di rifiuto di uno dei mèmbri che non intende prendere parte alla festa.
Seconda scena: incontro tra padre e figlio maggiore (vv. 28-32). Il padre va incontro a lui come era andato incontro al minore. È sempre il padre a prendere l’iniziativa e a muovere il primo passo per raccorciare le distanze. Il figlio rivendica i suoi diritti proprio come il minore che chiedeva la parte di patrimonio per andarsene. Nelle sue parole si legge la orgogliosa sicurezza del suo perbenismo, la sua incondizionata e assoluta fedeltà, con un non troppo velato rimprovero al padre considerato come «padrone» dal pesante verbo «ti servo», tipico degli schiavi. Il lavoro, più che collaborazione e compartecipazione, sembra sia stato vissuto come servile dipendenza. Dopo l’accusa al padre, il discorso prosegue attaccando duramente il minore. Egli parla al padre di «questo tuo figlio», incapace di riconoscere l’altro come fratello che demolisce ritornando a un passato ormai sepolto per il padre. Questi riconosce le ragioni del maggiore: quanto egli afferma non è né falso né esagerato, perché di fatto egli ha sempre lavorato in casa. Le ragioni ci sono, d’accordo, ma non devono diventare pretesto per alzare palizzate di divisione. Il padre lo ascolta e poi gli rivolge la parola chiamandolo «figlio», ricordandogli così quella relazione di comunione che il maggiore ha sempre vissuta, forse senza capirla pienamente, sicuramente senza apprezzarla se ora, in un momento di tanta gioia, egli si estranea e mai si rivolge al padre chiamandolo con questo nome. «Figlio, tu sei sempre con me»: il padre difende la posizione privilegiata del maggiore; è una comunione di persone che si travasa naturalmente in una comunione di beni: «tutto ciò che è mio è tuo». Le parole del padre hanno smantellato la pretesa sicurezza del figlio, hanno messo a nudo che neppure lui ha compreso il padre perché non ne condivide i sentimenti e si estranea alla festa della comune riconciliazione. Le sue ragioni valgono, ma nel momento e nel modo in cui vengono rivendicate manifestano la intrinseca debolezza di relazione con il padre.
La festa autentica ci sarà quando il maggiore riconoscerà e accetterà l’altro non come «questo tuo figlio», bensì come «questo mio fratello». Se ciò avviene, non è detto, e la parabola rimane ‘aperta’ come monito per i farisei di tutti i tempi (cf. v. 2).
Meditazione
Una luce particolare, che emerge dai testi scritturistici di questa domenica, orienta il nostro sguardo verso un punto focale che dà unità alle varie tematiche che si intrecciano nella liturgia della Parola: si tratta del volto misericordioso di Dio, un volto che, attraverso il perdono, comunica la gioia della comunione ritrovata con l’uomo peccatore. «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20) è l’appello accorato che risuona in questa domenica. Dio allontana dal suo sguardo l’umiliazione che la schiavitù del peccato imprime sul volto dell’uomo, perché nel suo cuore prevale la compassione. Assicurando Giosuè della sua fedeltà al popolo di Israele, Dio dice: «oggi ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto» (Gs 5,9a). E così il padre della parabola di Lc 15, 11-32, riabbracciando il figlio che si era allontanato, lo rassicura del suo amore dicendo: «portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare…» (v. 22). Mediante il suo perdono, Dio ridà all’uomo la dignità perduta, la dignità del figlio: dal volto di questo figlio perduto, cercato, atteso, ritrovato, scompaiono le ferite che ne deturpano il volto e riappare la fiducia e la libertà dei figli. Solo la gioia della festa può dare compimento e voce a questa comunione ritrovata: «bisognava far festa e rallegrarsi…» v. 32); è l’invito del padre al figlio maggiore per il fratello che è ritornato a casa. Il vitello grasso che il padre fa ammazzare per preparare il banchetto al figlio minore (v. 23) è il simbolo di quella Pasqua che viene celebrata al termine del lungo e faticoso cammino di liberazione del popolo di Israele dall’Egitto (Gs 5,10-12) ed è un’anticipazione del compimento nella Pasqua del Cristo, vero agnello immolato che riconcilia l’uomo con Dio: «tutto questo però – ci ricorda l’apostolo Paolo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo…» (2Cor 5,18).
Nella liturgia della Parola di questa domenica, il testo che lascia trasparire con stupenda luminosità il volto compassionevole di Dio è sicuramente la parabola di Luca. È come un’icona, poiché Luca ha la capacità, nel suo racconto, di renderci quasi protagonisti di una vicenda allo stesso tempo squisitamente umana e paradossalmente divina. E, come protagonisti, siamo chiamati ad aprire lo sguardo per poter contemplare, attraverso questa parabola, il volto stesso di Dio, un volto che spesso ci illudiamo di conoscere, ma che continuamente richiede da noi un cammino di conversione per scoprirlo in tutta la sua inaudita bellezza. Accostarsi a questa parabola, significa lasciarsi catturare da un volto: «da qualsiasi angolatura si guardi questo racconto, ci si accorge che al centro c’è la figura del padre: lui davanti ai suoi i figli e i due figli davanti a lui. Il padre è la figura che dà unità all’intera narrazione. Le due vicende si scontrano con l’originalità della sua paternità» (B. Maggioni). E allora rileggiamo brevemente le due vicende tenendo fisso lo sguardo sul volto del padre: «un uomo aveva due figli…» (v. 1).
Il bisogno di autonomia, di indipendenza e libertà nei confronti del padre, orienta le scelte del figlio più giovane. Ma questo desiderio, in sé molto umano e tipico per un giovane, si intreccia con una pretesa: «dammi la parte di patrimonio che mi spetta» (v. 12). E la pretesa di ciò che di fatto è un dono e che solo nella gratuità di una comunione (con quel padre che vuole dargli tutto ciò che ha) è possibile renderlo occasione di libertà e di vita. Possedere un dono (Luca usa un’espressione significativa ed emblematica per esprimere questo bisogno di avere per sé: «raccolte tutte le sue cose», v. 13) significa renderlo sterile e infecondo, ed è questo il risultato della vita di quel giovane. E Luca non manca di descrivere con precisione un fallimento in qualche modo annunciato (cfr. vv. 13-16): dissipazione, solitudine e lontananza che gradualmente conducono a una perdita della libertà, della dignità e, alla fine, della propria identità. Fuori metafora, tutto questo processo è la degradazione a cui conduce il peccato come lontananza dal volto di Dio. La domanda che Dio rivolge al primo uomo in Gen 3,9 – «dove sei?» – è l’interrogativo pungente che può aprire un cammino di ritorno: «Uomo dove sei? Uomo, dov’è il tuo luogo più vero, più profondo, dove puoi sentirti a casa? Dove cerchi la verità della tua vita, la verità del tuo volto?». L’uomo, quando distoglie il suo volto da Dio, perde il suo volto più autenticamente umano. In questo figlio lontano dal padre, distrutto e sfigurato nella sua dignità, ritorna il ricordo della casa del padre, della vita che in essa conduceva: «Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò… non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati» (vv. 18-19). Conversione? Non ancora. È un primo passo verso questo cammino.
C’è nostalgia, c’è vergogna, c’è la memoria di una certa felicità perduta; ma in questo figlio, che non si sente tale, manca ancora un ricordo o, meglio, una scoperta. Quella più importante: il ricordo e la scoperta del volto del padre. E questo avviene come dono da parte del padre: «quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò (v. 20). Quella lontananza che sembrava incolmabile e che, con la paura di essere rifiutati e giudicati, pesava nel cuore di quel figlio proprio nell’ultimo tratto di strada da percorrere, all’improvviso scompare. Ma è il padre che ha il coraggio di annullare quella distanza e lo fa con l’impazienza di chi a lungo ha atteso un incontro. La conversione del figlio è proprio questa: scoprire questo volto e sapere che di fronte ad esso lui, il figlio perduto e ritrovato, non ha mai cessato di esser tale, figlio amato. «Facciamo festa… e cominciarono a far festa» (vv. 23-24): la gioia è l’atteggiamento che traduce il cuore del padre di fronte a questo figlio, gioia gratuita e autentica non tanto per un figlio riavuto (non c’è possesso in questo padre) ma per un figlio amato.
La tristezza è invece ciò che caratterizza l’altro figlio, quello maggiore. Tristezza che si trasforma in rabbia covata, in indignazione e rifiuto, in incapacità di comprendere la gratuità del padre. «Ecco io ti servo da tanti anni…» (v. 29): in queste dure parole piene di pretesa, è riflesso il volto di questo figlio. È un servo che, nonostante una vita passata con il padre, non ha mai potuto conoscerne il volto. Ha servito attendendo di essere ripagato («non mi hai mai dato un capretto…»: v. 29); ha obbedito convinto di guadagnarsi una qualche giustizia. In fondo non ha amato il padre perché non lo ha mai sentito come tale.
Ma anche di fronte a questo figlio si rivela lo stesso volto di misericordia del padre. E questa rivelazione avviene anzitutto attraverso una parola: «Figlio…» (v. 31): davanti a questo padre, non c’è un servo, non c’è uno che è oppresso, ma c’è un figlio che è chiamato a gioire per un fratello ritrovato. E questo figlio che non si sente tale deve capire due cose: «tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo» (v. 31). È l’amore del padre, il suo dono, quella gratuità che diventa trasparenza nella festa per il figlio ritrovato, a rivelare il volto del padre e trasformare in figli quei due giovani che si sentivano solo servi. Questo deve diventare il cuore della loro conversione, perché, pur con percorsi differenti, tutti e due questi figli sono chiamati a conoscere chi è il loro padre.
Attraverso questa parabola, siamo orientati con forza alla gioia pasquale, perché è nella Pasqua di Cristo che ci viene rivelata, nella sua massima trasparenza, la compassione del volto di Dio. La veste più bella, l’anello al dito, i calzari, i segni del figlio, ci verranno donati nella notte in cui celebreremo la vittoria di Cristo sulla morte; e in questa notte l’agnello ucciso per far festa, per celebrare la liberazione, ci comunicherà tutta la gioia di un Padre che nel Figlio vuole essere in comunione con noi. Per ora si tratta di continuare questo cammino di ritorno, non dimenticando però, alla luce di questa parabola, che la vera conversione, la vera svolta nella nostra vita è anzitutto riscoprire il volto di un Padre che ci ama e, alla sua luce, essere consapevoli di ciò che possiamo diventare grazie a questo vol-to: «se uno è in Cristo è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2Cor 5,17).
Don Bosco commenta il Vangelo
IV domenica di Quaresima
Sono un figlio prodigo?
“Il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto” (Lc 15,13).
Nell’istruzione sulla confessione che si trova nel Cattolico provveduto, don Bosco sviluppa una serie di considerazioni su questa parabola “per eccitarci alla compunzione”:
Il figliuol prodigo è un’immagine del peccatore, il quale lascia la casa di Dio, suo padre, per abbandonarsi ai desideri delle sue passioni. Si allontana dalla presenza di Dio, e rinunzia al diritto della divina figliolanza, e lontano da Dio dissipa i doni di natura e di grazia, che aveva da esso ricevuti (OE19 408).
Di conseguenza il peccato è miseria e il peccatore è un infelice, secondo il racconto che ne fa don Bosco nella sua Storia sacra: “In quel medesimo paese sopraggiunta una grande carestia, fu costretto dalla miseria di darsi ad un padrone, che lo mandò a pascere i porci nella sua villa. Quivi l’infelice desiderava di cibarsi delle ghiande che quegli animali mangiavano, e non poteva averne onde sfamarsi” (OE3 175s).
Nel Cattolico provveduto troviamo poi questo commento allegorico sulle conseguenze nefaste del peccato:
Quanto bene e al vivo è qui dipinto lo stato miserevole dell’anima, la quale abbandona il suo Dio! Ella mancando del nutrimento dei SS. Sacramenti, del principale conforto celeste, piglia servizio presso crudelissimi padroni, cioè gli spiriti infernali, i quali le danno a pascere degli animali schifosi, ossia le sue brutali passioni, e con tutto ciò non le forniscono alcuno di quei piaceri che ella bramerebbe. Ma una nobile e spirituale creatura potrà forse essere appagata di sensuali piaceri? (OE19 409s).
Dopo tante miserie e disillusioni il figlio più giovane pensò finalmente di tornare a casa dicendo a sé stesso:
Vedi che male è mai l’offendere Iddio! che hai tu guadagnato coll’abbandonare un padrone sì buono? quali consolazioni ricevi ora dalle creature? qual pace hai trovata da che ti sei ribellato al tuo creatore? e valeva la pena per piaceri così vili, così brevi, così vergognosi voltare le spalle a Gesù tuo Salvatore, rinunziare al paradiso, perdere la grazia divina e la pace dell’anima? Ritorna al tuo Padre (OE19 411).
E il Padre accoglie il peccatore con grande trasporto di gioia.
Tra i “tratti particolari della Sacra Scrittura usati da Dio verso i peccatori”, citati nel secondo giorno del suo Esercizio di divozione alla misericordia di Dio, don Bosco menziona l’accoglienza del figlio prodigo da parte del padre suo:
Se poi osserviamo la condotta del nostro divin Salvatore nel Vangelo, oh! come risplende la sua misericordia per l’uomo peccatore! […] Si presenta qual tenero padre, il quale con grande trasporto di gioia accoglie il suo figlio scialacquatore che ritorna alla casa paterna. Tutti questi modi di dire del nostro buon Dio mostrano il desiderio grande che il Signore ha di usare misericordia a tutti, ma specialmente al peccatore (OE2 130s).
Nel capitolo poi in cui descrive “l’amorevolezza con cui Iddio accoglie il peccatore”, don Bosco sottolinea il fatto che Dio è “quel padre il quale vedendo ritornare il figlio perduto gli corre all’incontro; e prima che quegli parli l’abbraccia, lo bacia teneramente, e quasi vien meno di tenerezza per la consolazione che prova” (OE2 148).
Ed ecco in fine la meditazione offerta nel Cattolico provveduto:
Così pure Iddio accoglie il peccatore che si ravvede. Gli va incontro, gli dà il bacio di pace, ne dimentica i peccati, lo riceve di nuovo nella sua grazia, e di nuovo lo dichiara suo figlio, gli riempie il cuore di dolci consolazioni, e invita gli angeli ed i santi tutti a festeggiare il suo ritorno; e lo fa sedere a mensa insieme cogli altri suoi figliuoli, porgendogli in cibo e bevanda il corpo sacratissimo e il sangue preziosissimo del suo stesso divin Figliuolo (OE19 412).
(Morand Wirth)
Tra parentesi il lettore troverà i riferimenti principali dei testi citati nelle opere di o su don Bosco: – nei 38 volumi delle Opere edite di G. Bosco (OE1-38, a cura del Centro Studi Don Bosco dell’Università Pontificia Salesiana); – nei 19 volumi delle Memorie biografiche di don G. Bosco (MB1-19, a cura di G.B. Lemoyne, A. Amadei e E. Ceria); – nelle sue Memorie dell’Oratorio (MO, a cura di A. Giraudo); – nei 10 volumi del suo Epistolario (E1-10, a cura di F. Motto). La seconda cifra indica la pagina del volume.
L’immagine della domenica
| CAMMINO DI SANTIAGO – 2018 |
«Togli ad un viaggiatore
la speranza di arrivare
e gli avrai tolto anche
la forza di camminare»
(Guglielmo di S. Thierry)
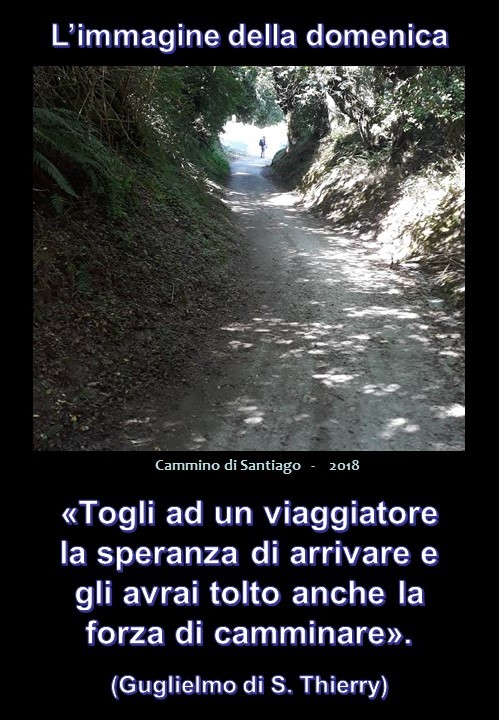
Preghiere e racconti
Accetto i miei errori?
La condizione umana è una condizione di debolezza, ecco perché ci sono le gommine sulle matite. Tutti compiono errori. Dio ha fornito solo animali e uccelli di istinti infallibili. Noi esseri umani dobbiamo imparare molte cose dalle prove e dagli errori.
Un vecchio saggio disse una volta: “Impara dagli errori degli altri: non vivrai abbastanza per compierli”.
Molti di noi danno per scontato che, se non avessimo mai compiuti errori, probabilmente non avremmo mai fatto scoperte. Certo, l’unico vero errore è quello dal quale si è imparato nulla. Gli errori sono esperienze istruttive. Dunque, benvenuti nel club!
Così come avviene per molte virtù, lo spirito di comprensione e tolleranza incomincia a casa propria. In un modo o nell’altro molti di noi devono giungere alla disperazione, prima di poter offrire a se stessi comprensione e gentilezza. Dobbiamo toccare il cosiddetto fondo prima di poterci di nuovo rialzare.
E allora, devo domandarmi: a che punto sono? Mi sono liberato dall’abitudine di rivangare gli errori del passato? Mi sono liberato dei sentimenti di imbarazzo per le mie colpe e le mie lamentele? Posso dire con onestà e in pace: “Questa è la persona che abitualmente ero, il mio vecchio io; non è la persona che sono ora, l’io nuovo e attuale?” Molti di noi non capiscono di aver imparato dagli errori passati, e di avere superato grazie ad essi alcune immaturità. Mi rendo conto che il “vecchio io” ha insegnato molte cose al “nuovo io”?
La trappola, qui, consiste nell’identificarmi con il lato oscuro della mia personalità e con i miei errori passati, nel pensare a me stesso com’ero una volta. Quasi come quella persona che da piccola era grassa, ma che da grande è diventata snella.
La domanda fondamentale è: penso a me stesso come grasso o come magro? Chiaramente, crescere significa cambiare, e cambiare significa “lasciar perdere”. È una cosa difficile o facile per te? Ricorda, dobbiamo cominciare con un’onestà spietata, o non potremo mai giungere alla verità. E senza verità, non c’è crescita né gioia.
(John POWELL, Esercizi di felicità, Effatà Editrice, 2004, Cantalupa (TO), 25-26).
Una Conversione possibile
«L’amore del Padre non è un atto di costrizione. Sebbene il Padre voglia guarirci da tutte le nostre tenebre interiori, siamo sempre liberi di fare la nostra scelta, di rimanere nelle tenebre o di entrare nella luce dell’amore di Dio. Dio è là. La luce di Dio è là. Il perdono di Dio è là. L’amore sconfinato di Dio è là. Ciò che è sicuro è che Dio è sempre là, sempre pronto a donare e perdonare, in modo assolutamente indipendente dalla nostra risposta. L’amore di Dio non dipende dal nostro pentimento o dai nostri cambiamenti ulteriori o esteriori.
Che io sia il figlio minore o il figlio maggiore, l’unico desiderio di Dio è di portarmi a casa. Arthur Freeman scrive: “Il padre ama ogni figlio e da ad ognuno la libertà di essere ciò che vuole, ma non può dar loro la libertà che non si sentiranno di assumere o che non comprenderanno adeguatamente. Il padre sembra rendersi conto, al di là dei costumi della società in cui vive, del bisogno dei propri figli di essere se stessi. Ma egli sa anche che hanno bisogno del suo amore e di una “casa”. Come si concluderà la storia dipende da loro. Il fatto che la parabola non abbia un finale garantisce che l’amore del padre non dipende da una conclusione appropriata del racconto. L’amore del padre dipende solo da lui e fa esclusivamente parte del suo carattere. Come dice Shakespeare in uno dei suoi sonetti: “L’amore non è amore se muta quando trova mutamenti”».
(H.J.M. NOUWEN, L’abbraccio benedicente, Brescia, Queriniana, 2004, 114-115).
Il lungo cammino verso casa
«Una delle più grandi provocazioni della vita spirituale è ricevere il perdono di Dio. C’è qualcosa in noi, esseri umani, che ci tiene tenacemente aggrappati ai nostri peccati e non ci permette di lasciare che Dio cancelli il nostro passato e ci offra un inizio completamente nuovo. Qualche volta sembra persino che io voglia dimostrare a Dio che le mie tenebre sono troppo grandi per essere dissolte. Mentre Dio vuole restituirmi la piena dignità della condizione di figlio, continuo a insistere che mi sistemerò come garzone. Ma voglio davvero essere restituito alla piena responsabilità di figlio? Voglio davvero essere totalmente perdonato in modo che sia possibile una vita del tutto nuova? Ho fiducia in me stesso e in una redenzione così radicale? Voglio rompere con la mia ribellione profondamente radicata contro Dio e arrendermi in modo così assoluto al suo amore da far emergere una persona nuova? Ricevere il perdono esige la volontà totale di lasciare che Dio sia Dio e compia ogni risanamento, reintegrazione e rinnovamento. Fin quando voglio fare anche soltanto una parte di tutto questo da solo, mi accontento di soluzioni parziali, come quella di diventare un garzone. Come garzone posso ancora mantenere le distanze, ribellarmi, rifiutare, scioperare, scappare via o lamentarmi della paga. Come figlio prediletto devo rivendicare la mia piena dignità e cominciare a prepararmi a diventare io stesso il padre».
(H.J.M. NOUWEN, L’abbraccio benedicente, Brescia, Queriniana, 2004, 78-79)
Lasciarsi amare dal Padre
Un padre ama i figli e li perdona solo perché sono i suoi figli, non perché sono buoni. I padri aspettano con ansia i figli, se questi un giorno lo abbandonano. E se così si comportano i padri terreni, quanto grande sarà il perdono e l’immensa misericordia del Signore? Dio è amore e generosità assoluta e gratuita. Fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti, e allestisce un banchetto memorabile, perché un figlio ingrato e scapestrato è tornato alla casa del Padre. Perciò, sappi che è importante amare Dio e tenerlo con te nel tuo cuore, ma che è ancor più importante lasciarsi amare da Dio ed essere nel suo cuore.
(Clemente Arranz Enjuto).
Si levò e venne da suo padre
II figlio lontano si levò e venne da suo padre (Lc 15,20). Venne non attraverso un cammino del corpo, ma attraverso un cammino spirituale. Non ebbe bisogno di percorrere un lungo cammino, perché aveva trovato una via di salvezza più breve. Non ebbe bisogno di cercare il padre divino percorrendo molteplici strade, lui che lo cercò con la fede e lo trovò ovunque accanto a sé. Si levò e venne da suo padre. Quando era ancora lontano […] In che modo è lontano colui che viene? È lontano perché non è ancora arrivato. Viene, si incammina verso la conversione, ma non giunge ancora alla grazia; viene alla casa del padre, ma non giunge ancora alla gloria della sua condizione e del suo onore di prima. Il padre lo vide ed è per questo che il figlio poté slanciarvi verso di lui. Lo sguardo del padre rischiarò gli occhi del figlio e dissipò tutta l’oscurità che ravvolgeva a causa della colpa. Le tenebre della notte non sono nulla a confronto delle tenebre che nascono dalla confusione generata dal peccato […].
Il padre gli corse incontro non con un movimento fisico, ma in uno slancio di tenerezza. Gli si gettò al collo con il peso dell’amore, non con quello del corpo. Gli si gettò al collo non con un movimento delle viscere, ma con la passione delle viscere. Gli si gettò al collo per innalzare colui che giaceva a terra. Gli si gettò al collo per togliere con il peso dell’amore, il peso dei peccati. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi. Prendete sopra di voi il mio giogo che è leggero (Mt 11,28-30). Il figlio è aiutato da questo peso del padre, non ne è schiacciato. Gli si gettò al collo e lo baciò. È così che il padre giudica, è così che corregge, è così che copre di baci il suo figlio, non di percosse. La forza dell’amore non vede le colpe e perciò il padre con un bacio cancella i peccati, lo circonda con il suo abbraccio, non vuole mettere a nudo i crimini di suo figlio, non vuole disonorarlo. È così che il padre guarisce le ferite del figlio, in modo che nel figlio non restino nessuna cicatrice, nessun segno. Beato, dice il salmista, colui al quale sono perdonate le colpe e i cui peccati sono stati ricoperti [Sal 31 (32), 1].
(PIETRO CRISOLOGO, Discorsi 3,1-3, CCL 24, pp. 26-28).
Dio perdona con una carezza, un abbraccio una festa
Un padre aveva due figli. Ogni volta questo inizio, semplicissimo e favoloso, mi affascina, come se qualcosa di importante stesse di nuovo per accadere. Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa la struttura stessa del nostro vivere con Dio, con noi stessi, con gli altri. L’obiettivo di questa parabola è precisamente quello di farci cambiare l’opinione che nutriamo su Dio.
Io voglio bene al prodigo. Il prodigo è legione ed è storia. Storia di umanità ferita eppure incamminata. Felix culpa che gli ha permesso di conoscere più a fondo il cuore del Padre. Se ne va, un giorno, il più giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità. La casa non gli basta, il padre e il fratello non gli bastano. E forse la sua ribellione non è che un preludio ad una dichiarazione d’amore. Quante volte i ribelli in realtà sono solo dei richiedenti amore.
Cerca la felicità nelle cose, ma si accorge che le cose hanno un fondo e che il fondo delle cose è vuoto. Il prodigo si ritrova un giorno a pascolare i porci: il libero ribelle è diventato un servo, a disputarsi il cibo con le bestie. Allora ritorna in sé, dice il racconto, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pane…) Ci sono persone nel mondo con così tanta fame che per loro Dio non può avere che la forma di un Pane (Gandhi).
Non torna per amore, torna per fame. Non torna perché pentito, ma perché ha paura e sente la morte addosso. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo. L’uomo cammina, Dio corre. L’uomo si avvia, Dio è già arrivato. Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro… E lo perdona prima ancora che apra bocca, di un amore che previene il pentimento. Il tempo della misericordia è l’anticipo.
Si era preparato delle scuse, il ragazzo, continuando a non capire niente di suo padre. Niente di Dio, che perdona non con un decreto, ma con una carezza (papa Francesco). Con un abbraccio, con una festa. Senza guardare più al passato, senza rivangare ciò che è stato, ma creando e proclamando un futuro nuovo. Dove il mondo dice “perduto”, Dio dice “ritrovato”; dove il mondo dice “finito”, Dio dice “rinato”.
E non ci sono rimproveri, rimorsi, rimpianti. Il Padre infine esce a pregare il figlio maggiore, alle prese con l’infelicità che deriva da un cuore non sincero, un cuore di servo e non di figlio, e tenta di spiegare e farsi capire, e alla fine non si sa se ci sia riuscito. Un padre che non è giusto, è di più: è amore, esclusivamente amore. Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita.
Diventare “creature nuove”
Sembra semplice e lineare la celeberrima parabola del “figliol prodigo”, o del Padre misericordioso, o ancora del Padre prodigo d’amore, come di volta in volta rettificano gli esegeti, per puntare giustamente il focus su quello che viene definito come il vero protagonista della parabola, il Padre appunto.
Eppure, a ben guardare, il protagonista è sì il Padre, ma non il Padre in se stesso, bensì visto in relazione con i due figli. A tale relazione fa da specchio e da rimando quella di Gesù con i peccatori nei fondamentali versetti che introducono il racconto di Luca: una relazione improntata ad accoglienza e condivisione paritaria del cibo, che suscita la reazione scandalizzata dei perbenisti di ogni tempo e di ogni chiesa: “Questo qua accoglie i peccatori e mangia con loro!”.
Che ci piaccia o no, Gesù non aspetta che prostitute e funzionari corrotti si convertano, per sedersi a conversare e per spezzare il pane con loro. Prima si siede accanto a loro, ne riconosce la dignità guardandoli in volto, e poi chissà, forse si convertiranno proprio perché Lui è passato in mezzo a loro, come a casa di Zaccheo.
Ecco, in genere questa parabola suscita sempre delle resistenze: quando si pone l’accento sulla misericordia del Padre in attesa trepidante, che copre la distanza che lo separa dal figlio con una corsa e un abbraccio, prevenendo qualsiasi sua giustificazione, c’è sempre qualcuno che ha bisogno di sottolineare come in realtà il figlio si è pentito e la prova consisterebbe nel fatto che è “rientrato in se stesso” ed è tornato a casa.
Una lettura un po’ più attenta e scevra da pregiudizi rivela facilmente, invece, che il figliol prodigo torna a casa perché si trova nel bisogno e nella solitudine più disperante, ridotto a mangiare carrube come gli animali più impuri per gli Ebrei e, per di più, a mangiarle da solo, perché non incontra nessuno che abbia compassione di lui e gliele offra. Nella sua dissipazione materiale e spirituale, il giovane si è tagliato fuori non soltanto dalla relazione col padre, ma finanche dal consorzio degli uomini. Ha perso la sua identità di uomo, prima ancora che quella di figlio.
Nessun pentimento profondo, dunque, verso quel padre fatto soffrire ingiustamente, benché il figlio intenda rivolgergli parole che suonano di circostanza, alla luce della considerazione che i servi di suo padre mangiano meglio e più di lui. L’approccio ermeneutico di chi sottolinea a tutti i costi che il figlio si è pentito sottende a ben guardare la nostra mentalità retributiva, per cui il perdono lo si deve comunque meritare, e finisce col collocarci sulla linea del figlio maggiore, personaggio interessantissimo e stranamente oscurato dal ben più noto fratello minore.
Il fratello maggiore è, in effetti, colui con il quale è molto più facile identificare noi stessi: è, in fondo, una persona perbene, seria, che ha sempre lavorato (il testo non dà alcun motivo di dubitare delle sue parole) e vissuto senza colpi di testa.
Si è giustamente sempre sottolineato che anche lui, come l’altro, non ha capito nulla dell’amore immenso e liberante del Padre, e, così come lo scialacquatore suggerisce al padre di trattarlo come uno dei suoi servi, allo stesso modo il maggiore dice che lo ha sempre “servito” e non ha mai trasgredito a un suo comando. Dunque egli trova inconcepibile che per l’altro figlio (che non chiama mai “mio fratello”), il padre si prodighi in feste, banchetti e ricompense.
C’è una frase interessante e rivelativa del cuore del fratello maggiore: egli non addita il minore come colui che si è ridotto a mangiare le ghiande coi porci, condizione che, come osservavamo prima, lo fa uscire da qualsiasi relazione, anche la più degradata, con altri uomini. Per evocare il fratello, egli agita agli occhi del Padre solo lo spettro del “peccato sessuale”: suo fratello minore è, per lui, quello “che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute”.
Con queste parole, in cui moralisticamente rinfaccia il peccato, il fratello maggiore cerca di muovere l’indignazione del Padre, rinfocolando, invece, soltanto la propria. Egli tenta di coprire con la censura morale la sua acrimonia verso il fratello, di cui sembra invidiare la capacità di osare, di staccarsi da casa, e il risentimento verso il Padre, di cui certo invidia la bontà infinita e senza calcoli (cfr. Mt 20,15).
Alla gioia fremente del Padre fa da contraltare la sua tristezza da contabile dell’amore, che si ferma sulla soglia della porta, perché, da perfetto invidioso, non riesce a sostenere la vista e la presenza del peccatore perdonato e divenuto “una creatura nuova”, come indicano i sandali, simbolo dell’uomo libero, perché “le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove” (2 Cor 5, 17: la seconda lettura).
(Valentina Chinnici)
Preghiera
Nella mia vita ho sperimentato molte bene quanto è difficile per me confidare di essere amato ed avere fiducia che l’intimità in cui ho bisogno e che desidero ardentemente è lì pronta per me. Più spesso vivo come se dovessi meritarmi l’amore, fare qualcosa e poi forse ottenere qualcosa in cambio. Questo atteggiamento abbraccia l’intera questione di ciò che nella vita spirituale viene chiamato “amore preveniente”. Credo davvero di essere amato anzitutto, indipendentemente da ciò che faccio o da ciò che compio? È una questione importante, perché fino a che penso che quello di cui ho bisogno me lo devo conquistare, meritare e ottenere con un duro lavoro, non riuscirò mai ad avere ciò di cui ho più bisogno e che desidero di più, che è un amore che non può essere guadagnato ma che è donato gratuitamente. Pertanto il mio ritorno è la mia disponibilità ad abbandonare la tendenza a ragionare in questo modo e a vivere sempre più secondo la mia vera identità di figlia o figlio prediletto di Dio.
Aiutami ad amare gli altri così come sono, o Signore, nello stesso modo in cui tu hai donato il tuo amore a me.
(H.J.M. NOUWEN, Dalla paura all’amore. Riflessioni quaresimali sulla parabola del figlio prodigo, Brescia, Queriniana, 2002, 59-60).
La Settimana con don Bosco
23-29 marzo
23. (S. Turibio di Mogrovejo) – “Eravi un fanciullo di nove anni Peruviano e discendente degli Incas, antichi re del paese”, e mentre Pio IX lo stava guardando, “il ragazzo in lingua spagnola, lingua che egli parla assai bene, gli disse: Santissimo Padre, datemi la benedizione” (OE23 121).
24. “Non sono molte le mie cognizioni; quella però che mi piacerebbe e desidero si è scire Jesum
Christum et hunc crucifixum” (MB5 883).
25. (Annunciazione del Signore) – In questo giorno si festeggia “il memorabile annunzio di Gabriele alla gran Vergine di Nazareth”, e ci si rallegra “dell’ineffabile dignità di Madre di Dio, toccata all’umile Ancella del Signore” (OE18 459).
26. “Io so solamente che quell’animale [il cane Grigio] fu per me una vera provvidenza in molti pericoli in cui mi sono trovato” (MO 206).
27. “Agli altri perdona tutto, a te nulla” (MB3 617).
28. “Del prossimo parlar bene o tacere affatto” (OE3 352).
29. “Oh quanta roba vecchia c’è da togliere! Mio Dio, distruggete in me tutte le mie cattive abitudini” (MO 101).
(Morand Wirth)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– M. FERRARI, monaco di Camaldoli, «Oggi di è adempiuta questa scrittura». Tempo di Quaresima e Tempo di Pasqua, Milano, Vita e Pensiero, 2013.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.