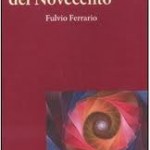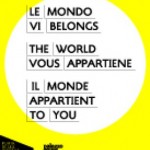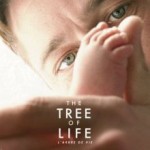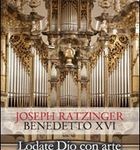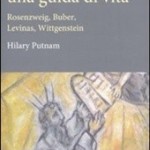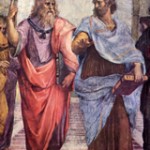intervista a Sylvie Germain, a cura di François Thuillier
Dove sono finiti gli scrittori cristiani, in questo periodo in cui la loro voce sembra più che mai necessaria? Dove sono finiti i loro appelli alla giustizia e all’indipendenza, o, più modestamente, alla bellezza e all’intelligenza?
Sicuramente, l’epoca di scrittori, romanzieri, poeti, filosofi come M. Barrès, C. Péguy, F. Mauriac, G. Bernanos, J. Green, P. Claudel, G. Marcel, M. Blondel, E. Gilson, J. Maritain, ecc. è superata.
Ma questo cambiamento nel modo di esprimere la fede, sia che essa venga affermata o interrogata, non significa una totale scomparsa.
In Francia ci sono grandi pensatori del cristianesimo, e anche grandi romanzieri, poeti, drammaturghi. Nessuno fa “opera confessionale”, ma, ognuno a suo modo (magari con una certa distanza, o in grande libertà, o in maniera a volte parodistica) mantiene un legame con il pensiero cristiano.
L’appello “alla giustizia e all’indipendenza, alla bellezza e all’intelligenza”, di cui comunque i cristiani non detengono l’esclusiva, certo non è più diretto come in Péguy, Bernanos o Claudel, ha perso quegli accenti forti, focosi, lirici che quegli scrittori sapevano far risuonare, ma tuttavia perdura. La voce della letteratura cambia nel corso del tempo. Il timbro, il colore, l’intensità si modificano incessantemente.
La voce della letteratura “cristiana” parla ora con toni molto più bassi, in maniera più indiretta e discreta. E se si mettesse di nuovo a parlare forte, con foga e combattività, non è certo che ci sarebbero orecchie per ascoltarla; c’è perfino il rischio che le orecchie dei nostri contemporanei si chiudano ulteriormente, tanto è cresciuta la diffidenza, l’avversione, verso qualsiasi discorso “religioso” espresso in maniera troppo ardente.
E poi, nel gran frastuono della nostra epoca, dove tanti clamori si scontrano, forse è più facile farsi sentire, almeno un po’, da qualcuno, parlando (scrivendo) in toni più pacati.
Questo pone il problema del nostro essere “presenti al mondo”, affrontato nel suo ultimo libro. Che cosa significa per lei essere “presente all’altro”?
Essere presente, significa “esserci, restare davanti”; restare attenti, nel mondo e davanti al mondo, e davanti all’altro, ad ogni altro. Significa considerare il mondo e gli altri. La dimensione spaziale del “qui” si accompagna alla dimensione temporale: adesso, in questo momento. Significa essere attenti
e vigilanti, qui e adesso.
Ma questa pienezza della presenza/coscienza/attenzione all’altro non deve farsi opaca e diventare ostacolo – per un eccesso di affermazione, per uno sviamento dell’attenzione in indagine, in impudicizia, per una tentazione di controllo e dominazione.
Questa pienezza deve essere una posizione di fronte all’altro, senza dominio su di lui. Anch’essa ha il suo doppio: di oblio – a sé; o piuttosto, è opportuno distinguere l’“io” cosciente, responsabile, che assume l’atto di presenza, e l’“io” centripeto che tende a ricondurre tutto a sé.
È veramente possibile, o è ancora solo un problema di credenza, di fede nel volto dell’altro?
Non c’è esclusione, per opposizione; aver “fede nel volto dell’altro” non è un’illusione che uno cerca di darsi per consolarsi dell’impossibilità di essere presente all’altro. Questa fede si fonda sull’intuizione profonda rielaborata per innalzarla a sapere, per quanto questo sapere possa restare incompleto e fluido. E l’intuizione dell’importanza vitale del volto dell’altro, che io devo riflettere, si presenta, in un unico movimento, nel bisogno vitale che io provo che anche l’altro mi rifletta.
I pensieri di odio, di disprezzo verso un’altra persona, hanno come finalità la sua perdita, in quanto tendono ad imprigionarla non nel suo vero volto, ma, all’opposto, in una caricatura di volto, in un rifiuto a riconoscergli la dimensione di volto, di alterità, di piena dignità di vivente. Tutto dipende dal modo di pensare l’altro, dalla qualità di questo pensiero: chiuso o aperto, malevolo o benevolo, mortifero o vivificante. Più si pensa l’altro liberamente, senza nulla “che pesi o immobilizzi”, su uno sfondo di un vuoto luminoso aperto a tutte le possibilità, e più questo pensiero si fa benefico. E questo non riguarda solo il nostro pensiero dei vivi, ma anche quello dei defunti, perché perfino nella morte l’altro deve essere pensato nell’apertura e nel movimento, considerando l’immensa parte di ignoto che lo circonda, e di insospettato, forse, che lo abita.
Questa presenza non può prescindere dal corpo. E il corpo, questo “mezzo”, che è stato usato da Dio una volta per tutte, non è molto semplicemente il messaggio?
Nessuna religione ha attribuito al corpo tanto riconoscimento, dignità e valore quanto quella dell’Incarnazione. Purtroppo la Chiesa, nel corso della sua storia, ha spesso, e drammaticamente, perso di vista questo messaggio, distorcendolo, tradendolo, schernendolo. Il senso profondo dell’Incarnazione è stato salvaguardato nell’aspetto della cura, della cura per l’altro sofferente, affamato, nel bisogno… e questa dimensione di misericordia attiva, di fraternità operante, è fondamentale. Ma dal lato del godimento e della gioia, del corpo in festa, assurdamente, e scandalosamente, c’è stato il rifiuto, come se ogni piacere ed ogni gioia fossero subito confusi con la sregolatezza, l’oscenità, la depravazione.
No, non si può mai prescindere dal corpo; la meraviglia e la radicale singolarità della rivelazione cristiana risiedono nella piena accettazione del corpo, nella comprensione della sua complessità fatta di pesantezza e di grazia, di fragilità e di forza, della sua folle capacità sia di soffrire che di godere e gioire. E l’ascesi praticata da Cristo (digiuni, lunghe veglie di preghiera, frugalità del modo di vivere) non significa mai disprezzo e rifiuto del corpo, ma padronanza e disciplina del corpo in vista della partecipazione ad un fantastico movimento di liberazione di tutto ciò che ostacola e appesantisce gli uomini. L’uomo Gesù è stato sensibile ad ogni segno di ospitalità, di delicatezza, perfino di sensualità, che gli è stato prodigato. E incessantemente ha guarito i malati, che si trattasse di problemi fisici o psichici, ridando a ciascuno la sua integrità corporale e mentale.
Il corpo deve essere assunto e vissuto pienamente, ai suoi albori, nel suo pieno mezzogiorno, al suo crepuscolo, e fino all’estremo limite della sua notte. Così fu la Passione, un assoluto di tenebre penetrato nel corpo e nell’anima. Ma prima c’è stato lo splendore della Trasfigurazione, e dopo,
l’invisibile bagliore della Resurrezione.
Ecco, come sperimenta, una scrittrice come lei, la povertà e il buio? Nel rapporto con le parole o piuttosto nella vita quotidiana?
L’esperienza della povertà e del buio la si prova nel quotidiano, in maniera confusa, spesso, e a volte diventa acuta, in un certo istante, in un pensiero che si sfilaccia, che sbatte contro un ostacolo, che può essere di comprensione (di un’idea che ci sfugge, che ci eccede) o può sorgere mentre si parla con altre persone (dalle quali non si riesce a farsi capire e/o che non si riescono a capire).
Povertà dell’intelligenza, quindi; della capacità di comprensione del mondo, sia sul piano scientifico che su quello metafisico, che resta sempre limitata, per quanto possa essere vasta; della comprensione degli altri, per quanto essi siano intimi e per quanto profonda sia la nostra empatia, e anche di noi stessi (che abbiamo dentro tante ombre e chiaroscuri, segreti, bugie, ferite nascoste, paure inconfessate, desideri clandestini, cedimenti della volontà, ma anche begli imprevisti…).
Questa esperienza si intensifica quando si scrive. Bisogna incessantemente inseguire le parole, raggirarle, a volte litigarci. Le parole sono i nostri attrezzi, insieme sublimi e risibili, per andare incontro agli altri e incontro a noi stessi, per esplorare il tempo, per affrontare l’avventura della vita e l’ignoto della morte, per interrogare il mondo, senza fine, e per vegliare sulla soglia del mistero più estremo, quello di Dio. Soglia dove il linguaggio si esaurisce, confina nel silenzio, e dove culmina l’esperienza della nostra povertà.
intervista a Sylvie Germain, a cura di François Thuillier
in “Témoignage chrétien” n° 3450 del 23 giugno 2011 (traduzione: www.finesettimana.org)