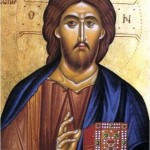
|
XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO |
Lectio – Anno A
Prima lettura: 1 Re 3,5.7-12
|
In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?». Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te».
|
v Nella scena rievocata in questo brano (1 Re 3,3-15) ci troviamo agli inizi del regno di Salomone, quando ancora non si ha nessun indizio della perversione che secondo il racconto biblico successivo caratterizzerà il resto della sua vita (1 Re 11). Qui il giovane re ci viene presentato come un modello di uomo saggio, che chiede come supremo dono da Dio il giusto discernimento per poter governare bene il suo popolo. La saggezza di Salomone, caratterizzata altrove anche per una vasta conoscenza di carattere enciclopedico (cf 1 Re 5,9-14), viene qui qualificata come capacità di comprendere i propri limiti, e nello stesso tempo di sentire la necessità dell’aiuto del Signore per «distinguere il bene dal male» (v. 9).
Ciò è possibile col dono del «cuore docile» (lett. in ebraico «cuore che ascolta»), definito poi come «un cuore saggio e intelligente» (v. 12). Così, non si tratta tanto di una saggezza quantitativa, ma qualitativa. È interessante notare come la sapienza preferita in questa preghiera da Salomone sia contrapposta agli altri beni di carattere più mondano che pure sono considerati importanti nell’Antico Testamento: vita lunga, ricchezza e, specialmente per un re, morte dei nemici.
Proprio diverse, rispetto a questo ultimo punto, erano state le raccomandazioni di Davide al figlio prima della morte (1 Re 2,5-9). Inoltre, Salomone ha riconosciuto prima la fedeltà del Signore alla promessa fatta a Davide, per cui ringrazia il suo Dio per aver ereditato il trono di suo padre (v. 6).
Seconda lettura: Romani 8,28-30
|
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.
|
v In questi tre brevi versetti anche Paolo ci offre un suo abbozzo del tema del regno di Dio, più caratteristico dei vangeli sinottici. Egli ci vede coinvolti in esso, in quanto corrisponde al «disegno» di Dio per noi. Giunto alla conclusione della sua esposizione della storia della salvezza che costituisce l’argomento della Lettera ai Romani, Paolo contempla in anticipo il suo compimento nella glorificazione finale insieme a Cristo, dopo che si sono percorse le tappe intermedie della elezione, della chiamata e della giustificazione. Tenendo presente tutto questo, egli può dire prima che «tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono chiamati secondo il suo disegno».
Nel v. 28 abbiamo in Paolo uno dei pochi casi in cui il verbo amare ha Dio come oggetto e l’uomo come soggetto (gli altri casi si hanno in 1 Cor 2,9; 8,3; Ef 6,24). Ma anche in questo caso non si deve dimenticare che ci troviamo inseriti in un processo nel quale l’iniziativa è esclusivamente di Dio che chiama. Del resto prima Paolo ha parlato chiaramente dell’amore con cui Dio ci ha preceduto facendoci dono del suo Spirito: «La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (5,5). Questo concetto è ancora ribadito in 1 Giov 4,10: «Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati».
Vangelo: Matteo 13,44-52
|
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
|
Esegesi
Possiamo distinguere in questo brano evangelico tre brevi sezioni:
1) Il tesoro nascosto e la perla preziosa (vv. 44-46)
La forza evocatrice di queste due brevi parabole balza immediatamente agli occhi attraverso le due qualifiche abbastanza simili che le riassumono emblematicamente: tesoro, (perle) preziose. Queste due condizioni mettono in moto l’interesse di chi è capace di apprezzarle. Ma il contesto umano presupposto alle due immagini è diverso. Il tesoro na-scosto è scoperto per caso da chi lavora un campo non proprio per conto di estranei, mentre le perle preziose riguardano un mercante che lavora professionalmente per cercarle. Nell’un caso come nell’altro, ciò che conta è il capire che si è di fronte ad un’occasione da non perdere.
Le due parabole, nella loro brevità, sono formulate in una maniera parallela, giacché in entrambi i casi si ripetono i quattro verbi fondamentali: trova/trovata, va, vende tutti i suoi averi, compra. Solo nel primo caso, trattandosi di una scoperta non prevista, si accentua il senso della sorpresa aggiungendo «pieno di gioia». In realtà, le situazioni evocate dalle due parabole sono un po’ diverse e servono bene a sottolineare due atteggiamenti spirituali differenti nei confronti del regno di Dio. Nel caso del contadino che lavora come salariato, c’è la sorpresa per una scoperta non prevista, ma ciò nonostante egli sa essere abbastanza tempestivo nel prendere le decisioni giuste per non perdere l’occasione di un insperato vantaggio. Nel mercante di perle preziose questa disposizione è più esplicita e in qualche modo più scontata.
Anche di fronte al regno di Dio il nostro segreto desiderio di scoprirlo può presentare prima dell’incontro diversi gradi di consapevolezza, i quali conducono comunque ad un certo punto al passo decisivo dell’impegno personale e di una svolta di vita.
2) La rete gettata nel mare (vv. 47-50)
A proposito di questa parabola si deve ripetere quanto abbiamo osservato per quella che parlava del grano e della zizzania. Anche qui si parla di un elemento negativo, i pesci cattivi o scadenti da gettare via, i quali però non costituiscono l’oggetto principale di tutta l’operazione, ma solo una condizione necessaria per la realizzazione della finalità specifica della pesca, la raccolta dei pesci buoni. Usando lo stesso simbolo, suggerito allora dal suo mestiere. Gesù aveva detto a Pietro: «Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di uomini» (Lc 5,10).
La conclusione della parabola (vv. 49-50) è simile a quella precedente relativa alla spiegazione aggiunta alla parabola del grano e della zizzania (vv. 41-42): angeli, fornace ardente, pianto e stridore di denti.
3) Il vero scriba (vv. 51-52)
Gli scribi, esperti della Scrittura ebraica e della tradizione, rappresentano in Matteo una categoria di persone che, accanto ai sommi sacerdoti e ai farisei, sono menzionati molte volte in modo negativo e polemico, in quanto sono incapaci di comprendere la novità del messaggio di Gesù. Solo qui e in Mt 23,34 («Perciò ecco, io vi mando profeti, sapienti e scribi; di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città») sembra che vengano visti in senso positivo. Ma nel nostro passo si dice chiaramente che si tratta di uno scriba convertito, che è divenuto «discepolo del regno dei cieli». Così il riscatto della sua figura avviene attraverso il suo superamento, per ribadire che il vero scriba è ormai quello che si fa discepolo, in analogia con quanto si è detto in Mt 11,11 : «In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è il più grande di lui». Ma nello stesso tempo si sottolinea un elemento di continuità tra l’antica e la nuova economia in armonia con quanto è stato detto ancor prima: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto per abolire, ma per compimento» (Mt 5,17).
Se lo scriba offre qui un modello positivo che si può adattare al discepolo, è in forza di una qualità che gli era riconosciuta come caratteristica: la riflessione sui sacri testi della tradizione che può essere integrata con le osservazioni tratte dalla vita di ogni giorno; di tale atteggiamento si ha un esempio molto significativo proprio nelle parabole.
In realtà, questo detto sullo scriba-discepolo suggella per Mt tutto il suo capitolo delle parabole, quasi a voler suggerire l’analogia che c’è tra il procedimento del discorso parabolico e l’attività esegetica dello scriba, che diventa feconda quando non si cristallizza sulle conoscenze del passato, ma si sa aprire agli orizzonti dischiusi dalla nuova rivelazione di Dio anche attraverso gli eventi della vita quotidiana.
Meditazione
La sapienza fa l’unità tra prima lettura e vangelo. Sapienza di Salomone che si esprime nel suo pregare, nel suo chiedere a Dio un cuore capace di ascolto, ovvero il discernimento per giudicare e governare, sapienza di Gesù che si esprime nel suo parlare in parabole ma anche sapienza dei protagonisti delle parabole del tesoro e della perla (Mt 13,44-45) che emerge nel loro discernimento e nella loro pronta decisione, e infine sapienza dello scriba divenuto discepolo del Regno che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche (Mt 13,52). La sapienza non è manichea, non elimina l’antico a esclusivo favore del nuovo e non resta ostinatamente attaccata all’antico per timore del nuovo, ma fa del nuovo la reinterpretazione dell’antico e dell’antico il fondamento del nuovo.
La sapienza è l’arte di orientarsi nella vita, l’arte di governare il timone della nave: «l’uomo sapiente terrà saldamente il timone» (Pr 1,5 LXX). È l’arte del traghettatore, di chi governa, di chi istruisce. Ma è anzitutto l’arte di chi governa se stesso. Arte che si ottiene mediante la faticosa conoscenza di sé: «Il vero inizio per crescere in virtù è conoscere se stesso. Colui che si conosce è il solo padrone di sé e, senza avere un regno, è veramente un re» (Ronsard). È l’arte di cui oggi, nello smarrimento e nel disorientamento in cui viviamo, abbiamo grande bisogno. «Tu il tesoro, Tu la perla preziosa; o Signore, Tu hai incontrato me, non io ho trovato Te; Tu hai conquistato e afferrato me, non io ho acquistato Te; o mio Tu, io sono tuo». Questa antica invocazione suggerisce che il vero soggetto delle parabole di Mt 13,44-46 non è il mercante che ha acquistato la perla e nemmeno il bracciante che ha acquistato il campo che prima ha lavorato, ma proprio il tesoro, la perla preziosa: essi sono la luce che da nuovo senso e orientamento alla vita e in nome e in vista di cui si può vendere tutto, abbandonare tutto.
E si può lasciare tutto nella gioia. La radicalità cristiana è autentica se sigillata dalla gioia. Anzi, la gioia è costitutiva di tale radicalità, perché questa va vissuta come grazia e nel rinnovarsi di una quotidiana gratitudine. Noi siamo grati di essere nella gioia.
L’esperienza di chi trova il tesoro e vende tutto per esso è in realtà l’esperienza di chi sente la parola di Dio che gli dice: «Tu sei prezioso ai miei occhi e io ti amo; io do uomini e popolazioni in cambio di te» (Is 43,4). È questo amore il segreto della gioia della radicalità di una vita cristiana, è questo amore il bene prezioso da custodire e salvaguardare, è questo amore del Signore e per il Signore che può rinnovare vite tentate da vecchiezza, stanchezza, insensibilità, cinismo, indifferenza. A noi che nella preghiera diciamo al Signore: «Sei tu il mio Signore, nessun bene per me al di fuori di te» e «Sei tu il mio unico bene» (Sal 16,2) e ancora «In te, o Dio, gioisce il mio cuore, esulta il mio intimo» (Sal 16,9), è chiesto di metterci alla prova se Cristo abita in noi (cfr. 2Cor 13,5). E questo perché noi abitiamo là dov’è il nostro tesoro: è il tesoro che ci colloca, che ci situa. Se Cristo abita in noi, noi dimoriamo in Cristo e allora possiamo gioire di gioia indicibile nel cammino verso il Regno. C’è solo da riscoprire ogni giorno la preziosità del dono ricevuto combattendo la tentazione del banale, dello scontato, del «tutto è dovuto».
Sia l’uomo che ha trovato la perla nel campo sia il mercante che ha trovato la perla di gran valore sono accomunati, nel loro agire coraggioso, forse anche folle e poco prudente («vendere tutto per acquistare una sola cosa»), dell’osare la propria gioia. La preziosità di una cosa e di una persona è relativa alla gioia che suscita in noi. La scelta dei due protagonisti delle parabole, così assimilabile alla radicalità cristiana (cfr. Mt 19,21: «Vendi i tuoi beni e dalli ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi»), avviene nella gioia procurata dalla scoperta, prosegue nella gioia di procurarsi il bene prezioso, e custodisce nella gioia anche il momento della vendita di tutto, della privazione di ciò che si possedeva. Ma soprattutto, è promessa di gioia anche per il futuro. A differenza di ciò che avviene al giovane ricco che resta nella tristezza (Mt 19,22).
Il Vangelo commentato in immagini
Preghiere e racconti
La perla
La perla di gran prezzo
giace nascosta giù nel profondo.
Come un pescatore di perle,
anima mia, tuffati,
tuffati profondo,
tuffati ancora più profondo e cerca!
Può darsi che non trovi nulla
la prima volta,
Come un pescatore di perle, anima mia,
senza stancarti, persisti e persisti ancora,
tuffati profondo, sempre più profondo,
e cerca!
Quelli che non conoscono il segreto
si prenderanno gioco di te
e tu ne sarai rattristata.
Ma non perderti di coraggio,
pescatore di perle, anima mia!
La perla di gran prezzo
è proprio nascosta là
nascosta proprio in fondo.
E’ la tua fede
che ti aiuterà a trovare il tesoro,
è essa che permetterà
che ciò che era nascosto
sia finalmente rivelato.
Tuffati profondo,
tuffati ancora più profondo,
come un pescatore di perle, anima mia,
e cerca, cerca senza stancarti.
(Swami Parmánanda).
Trovare-andare-vendere-comprare
«Un uomo» e «un mercante» nei loro confronti compiono le stesse azioni: trovare-andare-vendere-comprare. Diverse invece sono le strade attraverso le quali incontrare il tesoro, raggiungendo la propria piena autorealizzazione: per il primo si tratta di «fortunata scoperta», per il secondo di un faticoso cammino di ricerca. A tutti e due viene comunque chiesto totalità e radicalità. Non basta aver trovato, occorre andare-vendere-comprare. E questo è quanto si chiede a tutti. Ciò che si deve vendere è tutto quello che si possiede, poco o molto che sia. Il Vangelo richiede un distacco totale, non per spirito di sacrificio, ma per la preziosità del bene trovato. E si vende tutto senza rimpianti. In fondo, essere santi è un vero affare perché si trova la piena realizzazione di sé… in modo inaspettato o a lungo cercato. In ogni caso, si tratta di una occasione unica. È folle allora non chi va-vende-compra ma esattamente chi agisce in modo diverso.
La realizzazione di sé, quale pienezza di vita, è frutto dell’aver trovato, dell’esperienza di un incontro che allarga il cuore. Per questo il vero cristiano non dice: «Ho lasciato», ma: «Ho trovato». Non dice: «Ho venduto il campo», ma: «Ho trovato un tesoro». L’uomo che si autorealizza nel fascino della santità parla molto non di ciò che ha lasciato, ma di ciò che ha trovato. Dinanzi al tesoro o alla perla preziosa tutto il resto perde valore: «Tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo» (Fil 3,8).
(CISM, Protesi verso il futuro…per essere santi, Roma, Il Calamo, 2003).
Dal perdere al trovare
Il discepolo è provocato ad assumere un duplice atteggiamento: da una parte, svincolarsi pian piano da tutto ciò che lo tiene legato e gli impedisce di seguire in piena libertà il Signore e, dall’altra, sperimentare che, tutto ciò che deve abbandonare, è pur sempre poca cosa nei confronti di ciò che gli viene donato.
«In certi momenti il Vangelo è duro, impopolare, perché duri sono i cuori degli uomini – i nostri, a volte, più di quelli degli altri -, bisognosi di essere ricondotti sulla via della vita per aprirsi al dono di una vita nuova e più piena umanità».
(CEI, Comunicare il vangelo in un mondo che cambia, 35).
Per ora, nascondi il tuo tesoro
Hai trovato un tesoro: il tesoro dell’amore di Dio. Sai ora dov’è, ma non sei ancora pronto a possederlo pienamente. Tanti affetti continuano ad agitarti. Per possedere pienamente il tuo tesoro, dovresti nasconderlo nel campo dove l’hai trovato, andare lietamente a vendere ogni cosa che possiedi e poi tornare a comprare il campo.
Puoi essere davvero felice di aver trovato il tesoro: ma non devi essere così ingenuo da pensare di possederlo già. Soltanto quando avrai rinunciato a ogni altra cosa, il tesoro potrà essere completamente tuo. Aver trovato il tesoro ti pone in una nuova ricerca del tesoro stesso. La vita spirituale è una ricerca lunga e spesso ardua di quello che hai già trovato. Puoi cercare Dio soltanto quando lo hai già trovato. Il desiderio dell’illimitato amore di Dio è il frutto dell’essere stati toccati da quell’amore.
Dato che trovare il tesoro è soltanto l’inizio della ricerca, devi stare attento. Se esponi il tesoro ad altri senza possederlo pienamente, potrai far del male a te stesso e persino perdere il tesoro. Un amore appena trovato ha bisogno di essere nutrito in uno spazio tranquillo e intimo. La sovraesposizione lo uccide. Per questo devi nascondere il tesoro e spendere le tue forze nel vendere la tua proprietà, affinché tu possa comprare il campo dove lo hai nascosto.
Questa è spesso un’impresa dolorosa, perché il senso di chi sei è così intimamente legato a tutte le cose che possiedi: successo, amici, prestigio, denaro, titoli, e così via. Ma tu sai che nulla se non il tesoro stesso può veramente soddisfarti.
Trovare il tesoro senza essere ancora pronto a possederlo pienamente ti renderà inquieto. È l’inquietudine della ricerca di Dio. È la via verso la santità. È la strada per il regno. È il cammino verso il luogo in cui potrai riposare.
(H. J.M. NOUWEN, La voce dell’amore, Brescia, Queriniana, 2005, 148-149).
I frutti nuovi insieme agli antichi
II tesoro «nel quale si trovano nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza» (Col 2,3) è la Parola di Dio che sembra nascosta nella carne di Cristo, oppure le sante Scritture nelle quali riposa la conoscenza del Salvatore […]. Le belle perle sono la Legge e i Profeti e la conoscenza dell’Antico Testamento, ma esiste una perla unica, la più preziosa, la conoscenza del Salvatore, il mistero della sua passione, il segreto della sua risurrezione. E quando il mercante l’ha scoperta come l’apostolo Paolo disprezza come immondizia e spazzatura tutti i misteri della Legge e dei Profeti e tutte le antiche osservanze, nelle quali era vissuto in maniera irreprensibile, per guadagnare Cristo.
Non che la scoperta della nuova perla sia la condanna di quelle antiche, ma perché, paragonata a questa, ogni altra gemma ha minor valore […]. «Avete capito tutte queste cose?. Gli risposero: Sì?». Questo discorso si indirizza specialmente agli apostoli ed è a loro che viene detto: «Avete capito tutte queste cose?» (Mt 13,51). Vuole che non si accontentino di ascoltare come il popolo, ma che capiscano perché saranno loro i maestri. «Per questo ogni scriba ammaestrato in ciò che riguarda il regno dei cieli è simile a un padre di famiglia che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52). Gli apostoli, gli scribi e i segretari del Salvatore, che scrivevano sulle tavole dei loro cuori di carne le sue parole e i suoi precetti, conoscevano i misteri del regno dei cieli. Le ricchezze del padrone di casa li rendevano potenti, perché attingevano nel tesoro della loro conoscenza cose nuove e cose antiche. E così tutto quello che predicavano nel vangelo, lo confermavano con la testimonianza della Legge e dei Profeti. Da qui le parole della sposa nel Cantico dei cantici: «Mio amato, ho custodito i frutti nuovi insieme agli antichi» (Ct 7,13 Vg).
(GIROLAMO, Commento a Matteo 2,13,44-46.51-52, SC 242, pp. 288-292).
Le prove di Dio nella nostra vita
Ho spesso pensato che la causa più comune del tumulto intimo negli esseri umani sia il conflitto di desideri, in quanto le nostre aspettative più alte e i nostri desideri più profondi sono sempre in lotta con la realtà. Il fatto è che concepiamo i nostri desideri, facciamo i nostri progetti, e poi speriamo che ci sia una bella strada spianata che conduce dritti alla realizzazione; purtroppo, però, spesso questo successo non rientra nel copione. Incespichiamo e non riusciamo nell’intento, perdiamo la lotta che con tutte le nostre forze desideriamo vincere, e dobbiamo rinunciare alle cose che vorremmo così tanto tenere. Davanti a tale considerazione, mi sono chiesto di frequente come sarebbe se io desiderassi solo la volontà di Dio, se prendessi Gesù sul serio, se avessi realmente la benedizione di essere povero di spirito, se le mie mani fossero aperte e protese in segno di disponibilità all’abbandono, se … “è davvero meglio la Perla di Grande Valore oppure darla via?”.
(J. POWELL, Perché ho paura di essere pienamente me stesso, Milano, Gribaudi, 2002, 97-98)
Racconto
«Una volta, un monaco mentre era in viaggio trovò una pietra preziosa e la prese con sé. Un giorno incontra un viaggiatore e, quando aprì la borsa per condividere con lui le sue provviste, il viaggiatore vide la pietra e gliela chiese. Il monaco gliela diede immediatamente. Il viaggiatore partì, pieno di gioia per l’inaspettato dono della pietra preziosa che sarebbe stata sufficiente a garantirgli il benessere e la sicurezza per il resto della vita.
Ma pochi giorni dopo tornò indietro alla ricerca del monaco e, trovatolo, gli restituì la pietra dicendogli: “ora dammi qualcosa di più prezioso di questa pietra, qualcosa di pari valore. Dammi ciò che ti ha reso capace di donarmela”»
(Anthony de Mello)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Lezionario domenicale e festivo. Anno A, a cura della Conferenza Episcopale Italiana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007.
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 92 (2011) 5, 42 pp.
– COMUNITÀ DI BOSE, Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno A, Milano, Vita e Pensiero, 2010.
– Fernando ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità, Anno A, Padova, Messaggero, 2001.











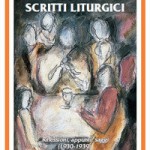




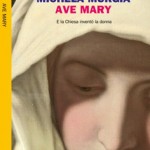


 Sarebbe improprio voler estrarre da questi testi, il cui fine è più pastorale che dottrinale, una ricognizione sistematica e comparativa, tra ieri e oggi, a proposito del ruolo della donna nella vita religiosa, benché il Papa non esiti in alcune circostanze a sollevare, anche a tal riguardo, problemi importanti, come quando afferma che le donne, pur essendo escluse dal sacerdozio ordinato, hanno avuto e hanno un ruolo peculiare nella Chiesa, grazie ai carismi di cui sono spesso gratificate dallo Spirito Santo. Si riferisce specialmente ai doni della visione e della “capacità a discernere i segni dei tempi”, cioè di profetizzare per il bene del popolo cristiano, come fecero nel medioevo Ildegarda di Bingen e Brigida di Svezia. Alcune delle sante donne, di cui Benedetto XVI analizza e presenta qui la vita, avevano però superato le fratture tradizionali riguardanti le specializzazioni dei ruoli tra uomini e donne. È il caso, per esempio, di Ildegarda, che fu autorizzata da Eugenio III sia a rivolgersi ai fedeli e al clero per riportarli a una vita migliore sia a predicare a Colonia contro i catari.
Sarebbe improprio voler estrarre da questi testi, il cui fine è più pastorale che dottrinale, una ricognizione sistematica e comparativa, tra ieri e oggi, a proposito del ruolo della donna nella vita religiosa, benché il Papa non esiti in alcune circostanze a sollevare, anche a tal riguardo, problemi importanti, come quando afferma che le donne, pur essendo escluse dal sacerdozio ordinato, hanno avuto e hanno un ruolo peculiare nella Chiesa, grazie ai carismi di cui sono spesso gratificate dallo Spirito Santo. Si riferisce specialmente ai doni della visione e della “capacità a discernere i segni dei tempi”, cioè di profetizzare per il bene del popolo cristiano, come fecero nel medioevo Ildegarda di Bingen e Brigida di Svezia. Alcune delle sante donne, di cui Benedetto XVI analizza e presenta qui la vita, avevano però superato le fratture tradizionali riguardanti le specializzazioni dei ruoli tra uomini e donne. È il caso, per esempio, di Ildegarda, che fu autorizzata da Eugenio III sia a rivolgersi ai fedeli e al clero per riportarli a una vita migliore sia a predicare a Colonia contro i catari. 