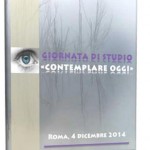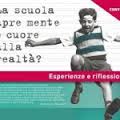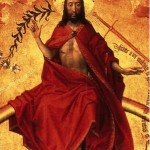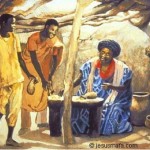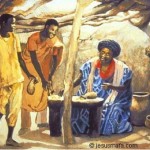
Prima lettura: Proverbi 31,10-13.19-20.30-31
|
Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città.
|
Il Libro dei Proverbi è una collezione di detti sapienziali, riguardanti il retto comportamento di tutte le categorie umane, dal tempo di Salomone (10,1-22,26:25-29) fino a dopo l’esilio (circa il 500 d.C.): vi si esprime la saggezza del popolo ebreo, ispirandosi nei più antichi, preferibilmente alla concezione sapienziale profana degli orientali, nei recenti più esplicitamente all’etica della religiosità javistica. A quest’ultima categoria appartiene sia il Prologo (cc. 1-9), sia l’epilogo (31,10-31); il quale è un piccolo poema in versi acrostici (ognuno dei quali, cioè, inizia con una lettera dell’alfabeto ebraico): ha come tema l’elogio della donna veramente «saggia» dal punto di vista morale, sociale, religioso. Qui vengono riportati i versi più significativi.
v. 10: «Una donna forte chi potrà trovarla?».
L’interrogativo enfatico mette in risalto il valore di una donna che ha in sé tutte le qualità di cui il poeta sta per tessere l’elogio: è inestimabile come «le perle preziose»!
v. 11 : «In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto». Spiega in che consiste la sua preziosità: contribuisce al benessere della famiglia ed è fonte di gioia per il suo sposo.
v. 13-19: «Si procura lana e lino… Stende la sua mano alla conocchia».
Esemplifica la sua cooperazione: confeziona tele e vesti, compra campi e vi coltiva vigne, vende i prodotti, ne fornisce i suoi di casa.
v. 20: «Apre le sue palme al misero».
Come nel v. 13 essa si prodiga per la felicità del suo consorte, così ora estende la sua generosità ai concittadini più poveri, in piena sintonia col consiglio dei sapienti: «chi ha l’occhio generoso sarà benedetto, perché dona del suo pane al povero» (22,9.22-23).
v. 30: «Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare».
In conclusione viene in risalto la dote specifica che la rende degna della lode più grande, cioè la rettitudine delle sue opere: agisce con solerzia e accortezza (vv. 14-19.25), parla con prudenza e bontà (v. 26), veste se stessa e i suoi con decoro (vv. 21.25); realizza quella che è la vera «sapienza» in armonia col timore santo del Signore. Ha molto di più
che la semplice avvenenza femminile. La sua fama non resterà circoscritta tra i rioni; arriverà alle «porte della città», dove si radunano i notabili e gli uomini di affari; ne sarà coinvolto anche suo marito (v. 23): «le sue opere la lodino alle porte della città».
Seconda lettura: 1 Tessalonicesi 5,1- 6
|
Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà: «C’è pace e sicurezza!», allora d’improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri.
|
In questa lettera S. Paolo si intrattiene con i Tessalonicesi (Macedoni, che egli aveva evangelizzato da poco) sulle liete notizie che ha ricevuto attraverso Timoteo riguardanti la loro fede e il loro affettuoso ricordo (3,6-10). La presenza ostile dei Giudei in mezzo a loro gli aveva procurato serie preoccupazioni (3,14-15). Adesso ringrazia di cuore il Signore. Arriva a esclamare: «voi nostra gioia e nostra corona!» (2,19). Col medesimo affetto nella seconda parte (cc. 4-5) richiama le fondamentali esortazioni per una vita autenticamente cristiana: perseveranza nelle norme dateci dal Signore Gesù, purezza di costumi, sincera carità fraterna, laboriosità, pace con tutti, e in particolare vigilanza serena (4,13-18) e costante per quanto riguarda «il giorno del Signore» (5,1-6).
v. 1 : «Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva». Dopo aver risposto, pare, a una preoccupazione dei Tessalonicesi sulla risurrezione dei defunti prima della Parusia, Paolo si premura di rassicurarli su un aspetto fondamentale riguardante quel giorno: la sua assoluta imprevedibilità (era ormai un dato risaputo: Mt 24,36.43; Ap 16,15), e insieme la sua ineludibilità: nessun essere umano ne potrà sfuggire, «nessuno scamperà» (v. 3).
v. 3: «E quando la gente dirà: «C’è pace e sicurezza!», allora d’improvviso la rovina li colpirà». Gli uomini un giorno potranno illudersi di aver raggiunto nelle loro realizzazioni l’apice dell’efficienza e della stabilità e si esalteranno come i costruttori della torre di Babele, o azzarderanno previsioni apocalittiche, ma il credente in Cristo guarderà alle loro affermazioni con indomabile scetticismo, «Il cielo e la terra passeranno, ma non le mie parole» (Mt 24,35).
v. 6: «Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri». È la logica conclusione, a cui si devono attenere costantemente «i figli del giorno», i discepoli del maestro divino e del suo fedelissimo apostolo: perseverare in tutte le virtù già ricordate (4,9-12) e attendere con fiducia e gioia l’ora della palingenesi finale.
Vangelo: Matteo 25,14-30
|
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».
|
Esegesi
Gesù ha parlato della grande tribolazione all’avvicinarsi del suo ritorno glorioso sulla terra (24,1-35), ha messo in guardia i discepoli perché si trovino pronti, con le lampade accese, in quel fatidico incontro con lo sposo divino (24,36-25,13); occorreva quindi precisare il compito che si esigeva da loro per essere giudicati degni di partecipare alla gloria del suo regno (valorizzazione dei doni ricevuti, opere di vero amore per i fratelli – 25,31-46).
Il discorso originario probabilmente risale a una situazione più generica, forse in risposta a quei seguaci che, salendo con lui da Gerico — città di Lazzaro — verso Gerusalemme si interrogavano sull’imminenza del suo regno (Lc 19,11-13): badate, avrà detto Gesù, a eseguire fedelmente i compiti che vi avrà affidato il Signore supremo; è importante che egli vi trovi solerti e efficienti in qualunque tempo vorrà apparire; saprà ricompensare abbondantemente chi gli è stato fedele e manderà a mani vuote o punirà chi non avrà adempiuto il suo volere. Era un avvertimento per tutti, sia i discepoli sia gli amici di Lazzaro (i farisei), che dopo la conversione di costui lo accompagnavano (Lc 19,1-10).
Matteo, inserendo il racconto nell’ultimo discorso del maestro, lo rende più solenne menzionando «i talenti» (somma ingente di fronte alle «mine» di cui parla Luca 19,13), e più chiaro del parallelo di Mc 13,34 e finisce per applicarlo alla comunità cristiana forse un po’ in crisi, ma ricca di carismi e di nuove possibilità di espansione.
v. 15: «A uno diede cinque talenti, a un altro due … secondo le capacità di ciascuno». Un talento sarebbe computato 6.000 dracme greche, corrispondenti a 6.000 denari ebraici; e, poiché un denaro equivaleva alla paga di una giornata lavorativa, 5 talenti risulterebbero una somma per allora ingente: il compenso di 30.000 giornate lavorative; mentre una mina sarebbe solo 1/60 di talento, che era la somma consegnata a ciascuno dei servi in Lc 19. L’intento del donatore è quello di far fruttare le sue proprietà durante la sua assenza, e perciò fa affidamento sull’abilità dei suoi collaboratori: consegna di più a chi può rendere di più; di meno agli altri, in proporzione.
vv. 16-17: «Colui che aveva ricevuto cinque talenti…ne guadagnò altri cinque…».
I primi due comprendono bene il progetto del loro padrone e si danno da fare per raddoppiare la loro somma. Il testo non dice nulla sulle modalità seguite per raggiungere il loro scopo. Al narratore importava piuttosto mostrare la solerzia di quei due per rispondere al desiderio del loro signore. «Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone» (v. 18).
v. 19: «Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò… a chi aveva guadagnato altri cinque talenti disse: “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto».
Il padrone dimostra al primo e al secondo servo che hanno raddoppiato i talenti tutta la sua compiacenza. Sono stati leali e fedeli, ciascuno in proporzione del denaro ricevuto e della loro abilità, «il poco»: saranno ricompensati tutti e due nel «molto» con grandi onori e promozioni.
v. 24: «Colui che aveva ricevuto un solo talento disse: “Signore, so che sei un uomo duro… Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra».
Il terzo servitore espone anzitutto il giudizio che ha del suo padrone. Lo ritiene un personaggio esoso e intransigente, «che miete dove non ha seminato» e che sarebbe stato capace di esigere il suo talento anche nell’eventualità di una qualsiasi perdita. Non ha quindi osato trafficarlo. Altro che servo abile e devoto!
v. 26: «Il padrone gli rispose: Servo malvagio… avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri».
Non ha tenuto conto del suo desiderio e della sua fiducia. Non ha osato correre il minimo rischio per accontentarlo. Si è lasciato guidare solo dal suo egoismo e dalla paura; era così semplice mettere a frutto la sua somma presso un fidato banchiere per ricavarne almeno gli interessi!
v. 28: «Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti». Un simile uomo, dice quel signore, non è più degno di essere al mio servizio; sia privato del talento ricevuto, che sarà consegnato in premio a chi si è impegnato generosamente per il mio piano; lui sia ormai dimesso dalla mia azienda. Fuori metafora è chiaramente descritta la situazione dei credenti che attendono l’incontro finale col loro supremo Signore.
v. 29: «Perché a chiunque ha, verrà dato… E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti».
Gesù dice: ai suoi seguaci sono stati conferiti grandi doni di grazia e di luce: i suoi esempi e i suoi sublimi insegnamenti, i carismi dello Spirito, «i preziosi talenti», da mettere a frutto nella loro vita e in seno alla comunità; era suo desiderio che si adoperassero con impegno in santità e testimonianza evangelica. Non tutti però si sono premurati di compiacerlo. Chi per paura, chi per ignavia, molti si sono contentati di crogiolarsi nei belli sentimenti e di tenere solo per sé il luminoso messaggio dell’eterna salvezza. Saranno esemplarmente ripagati: gli uni ammessi in quel giorno all’immensa gioia del loro Signore, gli altri espulsi dove è tenebra e strider di denti.
Meditazione
Il legame tra prima lettura e vangelo emerge se si considera che il testo di Proverbi non descrive solamente il tipo di donna che il sapiente, al termine del percorso di formazione e studio, delinea per i suoi allievi come moglie ideale, ma se si coglie quella figura femminile nella sua valenza simbolica per cui designa a un tempo la sapienza e il sapiente, ovvero, il dono e il frutto che tale dono suscita nell’uomo. Al cuore del ritratto della donna forte vi è la responsabilità. Responsabilità che si configura, tra l’altro, come affidabilità (Pr 31,11), laboriosità (31,13.19), vigilanza (31,27), generosità (31,20). E responsabilità è anche parola chiave per cogliere la differenza di comportamento tra i due tipi di servi nella parabola evangelica: il servo buono e fedele (Mt 25,21.23) e il servo malvagio e pigro (Mt 25,26). La responsabilità cristiana è coscienza del dono ricevuto e fedeltà ad esso. Anzi, più radicalmente, fedeltà al Donatore.
Secondo Ireneo di Lione, il denaro affidato dal padrone ai suoi servi significa il dono della vita accordato da Dio agli uomini. Dono che è anche compito e che chiede di non essere sprecato o ignorato o disprezzato, ma accolto con gratitudine attiva e responsabile. Paolo scrive: «Che cosa hai che non hai ricevuto?» (1Cor 4,7). Potremmo aggiungere che non solo ciò che abbiamo, ma anche ciò che siamo è dono di Dio. Noi siamo dono.
In questa luce vi è un aspetto del giudizio che incombe su chi non ha fatto fruttare i talenti ricevuti che non ha a che fare anzitutto con la prospettiva escatologica (Mt 25,30), ma già qui e ora con il rischio di sprecare la vita, di non viverla, di sciuparla «fino a farne una stucchevole estranea» (Constantinos Kavafis). Il rischio è quello di una vita insignificante, di una vita non vissuta.
L’idea essenziale che unifica i tre casi di servi che ricevono talenti in misura diversa è che in ogni caso, per ciascuno, all’origine vi è un dono che proviene da un altro, e che ciascuno riceve secondo la propria capacità. Si tratta dunque di un dono «personalizzato». Il dono affidatemi mi rivela a me stesso. Entrare nella logica del paragone e magari nella recriminazione, distoglie l’uomo dall’unica attività veramente sensata: conoscere se stesso e conoscere Dio, il Donatore, riconoscendo e accogliendo i doni ricevuti.
È una finezza psicologica la sottolineatura che è il servo che ha nascosto il denaro per paura è quello che ha ricevuto meno degli altri. Questi fatica ad accettare la propria minore forza-capacità rispetto ad altri è maggiormente esposto al rischio di cadere nell’invidia e nel risentimento. L’adesione al principio-realtà, ovvero, l’accettazione della realtà così come si presenta, in noi e fuori di noi, è allora misura salvifica umanamente e spiritualmente.
Investire il denaro ricevuto significa esporsi al rischio di perdite che dovrebbero poi essere rimborsate al padrone: la paura del servo, che lo ha paralizzato, è anche paura del rischio. Ed essendo evidente che questa parabola non vuole insegnare l’uso del denaro e non può essere usata per un’apologia di un sistema economico che assolutizzi il profitto, ecco che la paura di eventuali perdite va intesa come paura della vita che nasce da un’immagine di Dio distorta. Il desiderio di sicurezza, la paura di spendersi, il timore del giudizio altrui, hanno neutralizzato in quest’uomo la volontà di Dio che era che egli cercasse un guadagno (Mt 25,27) con il denaro ricevuto: e quel cercare un guadagno avrebbe significato anche un suo vivere, lavorare, rischiare, gioire e soffrire, insomma, un suo dare senso all’esistenza.
Dio vuole che l’uomo viva e cerchi la felicità, che osi la propria unicità e la propria umanità, che non si lasci paralizzare da paure e da immagini di Dio distorte. Il dono impegnativo che Dio affida all’uomo è anche la sua fiducia nei confronti dell’uomo.
Contrario di fedeltà (Mt 25,21.23) nella parabola, è pigrizia (Mt 25,26). Il pigro è colui su cui non si può fare affidamento, colui che delega, che spreca il proprio tempo, l’irresponsabile, colui che non assume la vita e la fede come compito di cui rispondere a Dio.
Preghiere e racconti
La misura del nostro coraggio
Come nella parabola dei talenti (Mt 25,14-30), la paura determina uno stile fallimentare – ieri, oggi e in ogni tempo – davanti ai doni di Dio. Anche oggi la paura paralizza l’uomo, paralizza la società, fa ingigantire i problemi: Tanto nell’ambito sociale, come può essere, per fare un esempio, rispetto all’accoglienza degli immigrati, quanto nella sfera personale, segnata dalle nostre paure psicologiche…
I talenti della parabola, sono la misura del nostro coraggio, della nostra disponibilità ad agire secondo l’amore.
Mettono in luce la nostra capacità di dire:
”Riconosco, Dio, quanto mi hai dato,
riconosco le mie forze,
investo i tuoi doni,
investo i talenti perché voglio farli fruttare”
Questo passaggio, questo atto di riconoscimento,
è la risposta di chi crede nella vita,
di chi ha fede…
E’ la fede che permette al nostro cuore
di guardare oltre l’ostacolo…
Anche chi ha un solo talento, può,
se crede, farlo fruttare.
Nel Dio che ce l’ha donato possiamo trovare
la forza di farlo fruttare,
di condividerlo,
per andare oltre la nostra paura,
oltre le nostre paure.
”Colui che aveva ricevuto un solo talento,
allontanandosi scavò una buca nel terreno
e vi nascose il denaro…”
Ecco questo è il punto:
l’isolamento accresce la paura…
la relazione la fa diminuire e ci aiuta a rischiare…
E’ sommando i nostri doni,
le nostre potenzialità
che possiamo vincere la paura,
liberare il nostro amore,
costruire segni vivi di speranza.
(Giancarlo Maria Bregantini, Parole condivise, Fondazione talenti).
Ognuno di noi è un originale fatto da Dio
C’è una vecchia trazione giudeo-cristiana secondo la quale Dio manda ognuno di noi in questo mondo con un messaggio speciale da consegnare, con uno speciale atto d’amore da compiere. Il tuo messaggio e il tuo atto d’amore sono affidati soltanto a te, il mio è affidato soltanto a me. Se questo messaggio debba raggiungere solo poche persone o tutti gli abitanti di una città o il mondo intero dipende esclusivamente dalla scelta di Dio. L’unica cosa importante è essere convinti che ognuno di noi è adeguatamente equipaggiato: tu hai i doni giusti per consegnate il tuo messaggio ed io ho i doni appositamente scelti per consegnare il mio.
Un aspetto particolare della verità di Dio è stato messo nelle tue mani, e Dio ti ha chiesto di condividerlo con ognuno di noi, e lo stesso vale per me. Proprio perché tu sei unico, la tua verità è data soltanto a te e nessun altro può dire al mondo la tua verità, o compiere per gli altri il tuo atto d’amore. Solo tu hai tutti i requisiti per essere e fare ciò che devi essere e fare. Solo io ho tutto ciò che è necessario per portare a termine il compito per cui sono stato inviato in questo mondo.
Sarebbe inutile e anche sciocco confrontare me stesso con te. Ognuno di noi è unico, non esistono fotocopie o cloni di nessuno di noi. Un simile confronto significherebbe la morte dell’accettazione di sé. Guarda la tua mano: le dita non sono di uguale lunghezza. Se lo fossero, tu non potresti di fatto afferrare una mazza da baseball o lavorare ai ferri. Allo stesso modo, alcuni sono alti e altri bassi, alcuni hanno un talento e altri un dono diverso. Tu sei fatto su misura per realizzare il tuo compito, e così tu non sei me e io non sono te. E questo è bene, è meraviglioso. Noi dobbiamo non solo accettare, ma anche esaltare le nostre differenze. Il mondo custodisce gelosamente gli originali, e ognuno di noi è un originale fatto da Dio.
(J. POWELL, Esercizi di felicità, Cantalupa, Effatà, 1995, 23-24).
Utilizzare tutti i miei talenti
Nel II secolo d.C., sant’Ireneo scrisse che «la gloria di Dio è una persona che vive in pienezza». Non ti è mai capitato di fare un regalo a qualcuno e poi venire a sapere che l’altro non l’ha mai usato? Forse avresti voluto chiedere: «Non ti è piaciuto il mio regalo? Perché non l’hai usato?». Forse Dio desidera porci qualche domanda sui doni che ci ha fatto. Quando diciamo nel Padre Nostro: «Sia fatta la tua volontà!», sono certo che parte di questo volere è che io mi sforzi di utilizzare tutti i miei talenti. So che Dio vuole che io sviluppi i miei sensi, le mie emozioni, la mia mente, la mia volontà ed il mio cuore nel modo più completo. «La gloria di Dio è una persona che vive in pienezza».
Qualcosa dentro di me sa con certezza che il nostro amore per Dio viene sicuramente misurato dal nostro impegno nel compiere queste due cose: amare gli altri come amiamo noi stessi e fare la volontà di Dio in ogni cosa.
(J. POWELL, Esercizi di felicità, Cantalupa, Effatà, 1995, 70).
Racconto
Ricordo spesso un lungo racconto che si trovava, ai miei tempi nell’antologia delle medie: è la storia di un ragazzo che nella scuola, la vecchia media o forse addirittura il vecchio ginnasio, era un fallimento totale. La sua incapacità, ad esempio, di distinguere i verbi transitivi da quelli intransitivi, scoraggiava il suo professore di lettere, che ci vedeva il segno di una radicale incapacità intellettuale. Poi, mortogli il padre, quel ragazzo abbandonò la scuola e se lo risucchiò la vita. Qualche anno dopo il vecchio professore fu preso dal capriccio di farsi lui un po’ di vino, di vero vino di uva e si recò al mercato all’ingrosso per comperare appunto quella partita di uva che gli abbisognava. Ma qui scoprì quanto inetto egli fosse in cose di questo genere e quanto poco gli valesse il suo latino ad affrontare le cose concrete della vita. E qui gli capitò di imbattersi proprio in quel ragazzo, ormai uno splendido giovanotto, che subentrato al padre nella gestione di un suo commercio, sul mercato era di casa e ci si moveva come un pesce nell’acqua: conosciuto il problema se ne prese cura lui e quello che non era riuscito al vecchio professore con tutto il suo sapere, riuscì in pochi minuti all’allievo fallito nella scuola ma riuscito nella vita. E prima di lasciarlo si prese persino lo sfizio di una innocente ironia: “Professore – gli chiese – mi tolga una curiosità, i verbi transitivi sono quelli che passano o che non passano?”
Nessuno dica: «Ho un solo talento e non posso fare niente»
Nella parabola dei talenti quelli che presentano i guadagni riconoscono con animo grato ciò che è loro e ciò che è del padrone. L’uno dice: «Signore mi hai dato cinque talenti» (Mt 25,20) e l’altro: «due» mostrando che avevano ricevuto da lui la possibilità di lavorare, che gliene erano molto grati e attribuivano tutto a lui. Che disse allora il padrone? «Bene, servo buono – è proprio di una persona buona mostrare interesse per il prossimo – e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone» (Mt 25,21); con queste parole mostrò tutta la beatitudine. L’altro servo non si comportò così; come si comportò? «Sapevo che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; per paura ho nascosto il tuo talento: ecco qui il tuo (Mt 25,24-25). Che cosa disse allora il padrone? «avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri» (Mt 25,27), cioè avresti dovuto parlare, esortare, consigliare. Ma non danno ascolto. Questo non ti riguarda. Che cosa ci potrebbe essere di più mite? […]
Ascoltiamo queste parole. Finché c’è tempo, diamoci cura della nostra salvezza, prendiamo l’olio per le lampade, mettiamo a frutto il talento. Se siamo inoperosi, se viviamo nella pigrizia, nessuno là in alto avrà compassione di noi, per quanto ci lamentiamo. Condannò se stesso chi aveva le vesti immonde e nulla gli fu d’aiuto. Chi aveva un solo talento restituì quello che aveva ricevuto in deposito e così fu condannato. Le vergini supplicarono, si presentarono e bussarono alla porta, ma tutto fu inutile e vano. Sapendo questo, offriamo denaro, impegno, aiuto, ogni cosa per renderci utili al prossimo. I talenti qui indicano le possibilità di ciascuno per quanto riguarda l’aiuto, il denaro, l’insegnamento o altre cose del genere. Nessuno dica: «Ho un solo talento e non posso fare niente». Anche con un solo talento puoi farti onore. Non sei più povero di quella vedova (cfr. Lc 21,2), né più incolto di Pietro e di Giovanni che erano ignoranti e illetterati, ma poiché diedero prova di zelo e fecero tutto nell’interesse comune, conquistarono il cielo. Nulla è così caro a Dio quanto vivere per il bene comune. Per questo Dio ci ha dato mani, piedi, forza fisica, mente e intelligenza, per servirci di tutto questo per la nostra salvezza e a utilità del prossimo.
(GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento sul vangelo di Matteo, om. 78,2, PG 58,713-715).
L’amore è il più grande talento umano
«Per coloro che non hanno amato, la vecchiaia è un inverno di solitudine. L’amore, il più grande talento umano, era stato sotterrato perché non si perdesse, e alla fine andò perduto davvero. Nessuno venne o se ne prese cura. Rimase soltanto una persona priva di amore e sola nell’attesa della morte.
Per coloro che hanno amato, la vecchiaia è il momento del raccolto. I semi di amore piantati con così grande cura tanti anni prima, sono maturati col tempo. La persona che ama è circondata, al tramonto della vita, dalla presenza e dall’affetto degli altri. Il bene ripaga sempre. Ciò che era stato donato in modo così spontaneo e gioioso, è stato restituito con gli interessi».
(J. POWELL, Esercizi di felicità, Cantalupa, Effatà, 1995,69).
I talenti
E perché tu comprenda bene, colui al quale furono affidati cinque talenti è un maestro; colui a cui ne fu affidato uno è un discepolo. Ma se il discepolo dicesse: «Sono un semplice discepolo, non corro pericoli», e nascondesse la parola, comune e spoglia, ricevuta da Dio, e non pensasse di ammonire, di parlar con franchezza, di rimproverare, di correggere, se possibile, ma la nascondesse in terra: è davvero terra e cenere questo cuore che seppellisce la grazia di Dio! Se dunque la nascondesse per pigrizia o per malvagità, non lo scuserebbe nulla il dire: «Ho un solo talento». Hai un solo talento? Dovevi aggiungerne un altro e raddoppiare il tuo talento; se ne avessi aggiunto un altro, non saresti rimproverato. A colui che presentò due talenti, infatti, non fu detto: «Perché non ne porti cinque?», ma fu ritenuto degno degli stessi premi dati a colui che ne presentò cinque. E perché? Perché fece fruttare ciò che aveva e pur avendo ricevuto meno di quello che ne aveva avuti cinque, non per questo si abbandonò all’infingardaggine usando il poco che aveva per ozieggiare. Non dovevi guardare i due talenti; piuttosto dovevi guardare a lui che, avendone due, imitò quello che ne aveva cinque, e così tu devi imitare quello che ne aveva due. Se per chi è ricco e non fa parte delle sue ricchezze sta già preparato il castigo, per chi può esortare quanto vuole e non lo fa, non ci sarà forse un castigo maggiore? In quel caso si nutre il corpo, in questo l’anima: ivi si impedisce la morte temporanea, qui la morte eterna.
(Cfr. GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sulla lettera agli ebrei, 30,2).
Ogni uomo semplice
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se davvero tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
(Dal film Fratello sole, sorella luna, di F. Zeffirelli)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004;2007-.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– Comunità domenicana di Santa Maria delle Grazie, La grazia della predicazione. Tempo ordinario – Parte prima, in «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 95 (2014) 5, pp. 36.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Tempo ordinario anno A, Milano, vita e Pensiero, 2010.
– F. ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità. Anno A, Padova, Messaggero, 2001.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– Fernando ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità, Anno A, Padova, Messaggero, 2001.
PER APPROFONDIRE:
XXXIII DOM TEMP ORDINARIO (A)