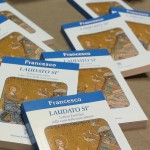Prima lettura: Giobbe 38,1.8-11
|
Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano: «Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e due porte dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?»
|
Il libro di Giobbe può essere diviso in tre parti. La prima parte (1-2) introduce i personaggi; la seconda parte (3-42,6) contiene il dialogo tra gli attori nel quale viene esposto il grande problema della sofferenza del giusto; la terza parte (42,7-17) riferisce la sentenza di Dio al termine dell’azione.
Il brano della lettura si trova nella seconda parte, ed è costituito dall’inizio del primo discorso di Dio, il quale proclama la sua onnipotenza e trascendenza con queste parole in mezzo al turbine: «Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e due porte dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?» (Gb 38,1.8-11). Per comprendere questo testo occorre avere presente il contenuto dell’azione precedente. Giobbe, uomo giusto, viene colpito dalla sventura; dapprima è colpito nei beni e nei figli, poi nella sua stessa carne, con una malattia dolorosa e ripugnante. Egli rimane sottomesso a Dio. Tre suoi amici vengono a consolarlo. Dapprima si tratta di una conversazione a quattro; in tre cicli di discorsi Giobbe e gli amici confrontano le loro concezioni riguardo alla giustizia divina. I tre amici difendono la tesi della retribuzione terrena; se Giobbe soffre, ciò vuol dire che egli ha peccato; e se anche egli è giusto ai propri occhi, non lo è agli occhi di Dio. Giobbe sostiene la propria innocenza e gli altri si irrigidiscono nelle loro posizioni.
Ad essi Giobbe contrappone la propria esperienza dolorosa e la ingiustizia di cui il mondo è pieno. Egli si scontra con il mistero di Dio il quale permette che il giusto sia afflitto. Giobbe alterna momenti di sottomissione a Dio a momenti di protesta della sua innocenza. In questo movimento entra in scena Dio stesso «in mezzo al turbine», cioè nello scenario delle teofanie. Dio riprende Giobbe o meglio, Dio rifiuta di dare risposta alle domande di Giobbe perché l’uomo non ha diritto di mettere Dio sotto inchiesta in quanto Dio è l’infinitamente sapiente e l’onnipotente che non può essere misurato dalla debolezza dell’intelligenza e dalle sue categorie di giustizia. Giobbe riconosce di avere parlato da insipiente e dà ragione a Dio. Il brano della lettura sta nell’inizio dell’intervento di Dio. In esso Dio espone la sua attività creatrice, nella quale si esplica l’infinita sapienza e l’onnipotenza. Di fronte all’opera di Dio non si può che ammirarne la bellezza e grandezza. L’onnipotenza di Dio viene esaltata attraverso la rievocazione della creazione del mare; il mare è una creatura che esprime essa stessa una immensa potenza, ma Dio ha posto dei limiti precisi alla potenza del mare e il mare non può trasgredirli. Questa descrizione esaltante della signoria divina incute riverenza, timore, sottomissione, che sono atteggiamenti non soltanto della volontà ma anche dell’intelligenza.
L’uomo moderno ha esplorato con grande acume e capacità la creazione, lo spazio, l’universo, ha scandagliato le profondità del mare e ha cercato di spiegare i segreti del cosmo. Il vero saggio, tuttavia, pur avendo raggiunto una tale conoscenza del mondo e capacità di dominarlo, non ne prova orgoglio, al contrario si sente piccolo e sempre superato dai feno-meni della natura e sa di essere ancora impotente di fronte a tanti suoi segreti. Nasce spontanea la domanda: se la creazione è così inesauribile e inafferrabile nella moltitudine e profondità dei suoi segreti, che cosa sarà il Creatore?
Seconda lettura: 2 Corinzi 5,14-17
|
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove.
|
Il passo della lettura si trova nella prima parte della epistola in continuazione con il testo della precedente domenica. San Paolo parla dell’amore di Cristo e della conoscenza di Cristo: «L’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,14-17). La prima affermazione: Cristo è morto per tutti, rivela che Gesù ha compiuto il sacrificio in nome di tutti come capo che rappresenta l’intera umanità. Ciò che ha valore davanti a Dio in questa morte è l’obbedienza di amore che manifesta il sacrificio di una vita interamente donata a Dio. Dice san Paolo di Gesù ai Filippesi: «Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato» (Fil 2,8-9) e ancora ai Romani: «Come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti» (Rm 5,19). I fedeli, resi partecipi di questa morte di Gesù con il sacramento del battesimo che li immerge in essa, devono ratificare questa oblazione del Cristo con la loro vita, devono attuare ciò che dice san Paolo nella presente lettura subito dopo: quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per lui che è morto ed è risuscitato per loro (2 Cor 5,15). Poi l’apostolo viene al tema della conoscenza di Cristo: «se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così» (2 Cor 5,16). Paolo non dice che ha conosciuto personalmente Gesù di Nazaret, afferma che tutti, anche quelli che hanno potuto conoscerlo, devono rinunciare a dare importanza alla affinità carnale con Gesù, alla conoscenza di lui secondo la carne: legame di parentela, legame di consuetudine familiare e di nazionalità. Conclude scrivendo: «se uno è in Cristo, è una nuova creatura» (2 Cor 5,17). Dio che aveva creato tutte le cose per il Cristo, ha restaurato la sua opera, sconvolta dal peccato, ricreandola nel Cristo. Il centro di questa nuova creazione che interessa tutto l’universo, è l’uomo nuovo, che è stato creato nel Cristo, per una vita nuova di giustizia e di santità: «Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti con lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). Perciò: «Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l’uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera» (Ef 4,23-24). Così l’uomo nuovo, ricreato nel Cristo, che è l’immagine di Dio ritrova la rettitudine primitiva nella quale aveva avuto origine e giunge alla pienezza della imitazione di Gesù e quindi alla pratica della esistenza morale.
Vangelo: Marco 4,35-41
|
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».
|
Esegesi
Il tratto della lettura nella prima parte del vangelo di Marco, ove è descritto il ministero di Gesù nella Galilea. Racconta il prodigio della tempesta sedata con lo stile caratteristico di Marco: «In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?» (Mc 4,35-41). Il racconto del vangelo sulla tempesta nel lago sedata da Gesù culmina nel tema della fede e mostra Gesù nella sua potestà sulla natura e sui suoi elementi. L’episodio evoca, nei confronti di Gesù, ciò che nella Scrittura è detto di Dio nei riguardi della natura: «Tu fai tacere il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti» (Sl 65,8). «Tu domini l’orgoglio dei mari, tu plachi il tumulto dei suoi flutti» (Sl 89,10). «Ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare, si rallegrarono nel vedere la bonaccia, egli li condusse al porto sospirato» (Sl 107, 29-30).
Tale è l’acclamazione finale nell’episodio evangelico; a Gesù anche il vento e il mare obbediscono; la sua potenza è come quella di Dio sulla natura. Gesù nelle parole rivolte ai suoi discepoli sottolinea la necessità della fede: «Non avete ancora fede?» (Mc 4,40). La fede che Gesù richiede fin dall’inizio della sua attività: «Credete» (Mc 1,15) e che richiederà incessantemente è un movimento di fiducia e di abbandono per il quale l’uomo credente rinuncia a fare affidamento sui propri pensieri e sulle proprie forze per rimettersi alle parole e alla potenza di colui nel quale crede. Gesù richiede la fede particolarmente in occasione dei miracoli. Al centurione che gli chiedeva di guarire il suo servo dice, dopo averne ammirato la fede: «Vai e sia fatto secondo la tua fede» (Mt 8,13). Alla donna che pativa flusso di sangue, dice: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha guarito» (Mt 9,22). Ai ciechi che gli chiedono: «Figlio di Davide abbi pietà di noi» (Mt 9,27) Gesù dice: «Credete voi che io possa fare questo? Gli risposero: Sì, Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse: sia fatto a voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi» (Mt 9,27-30). In tale modo i miracoli sono atti che offrono il segno della missione di Gesù e il segno della presenza del regno dei cieli. Gesù non può compiere miracoli se non trova la fede che deve dare ad essi il loro vero significato; a Nazaret, infatti, «non fece molti miracoli a causa della loro incredulità» (Mc 13,58). Esigendo un sacrificio dell’intelligenza e della volontà e di tutto l’essere, la fede è un atto non facile di umiltà che molti rifiutano di compiere, particolarmente in Israele, o lo compiono solo in modo imperfetto, come il padre dell’epilettico indemoniato, il quale dopo avere chiesto a Gesù la guarigione del figlio e avere ascoltato da Gesù: «Tutto è possibile a chi crede» (Mc 9,23) dice: «Credo, aiutami nella mia incredulità» (Mc 9,24). I discepoli stessi di Gesù, che pure gli aderiscono di cuore, mostrano le difficoltà della fede perché sono lenti a credere e sono spesso rimproverati da Gesù per la loro poca fede; nell’episodio raccontato nella lettura Gesù dice: «Non avete ancora fede?» (Mc 4,40). Quando è forte la fede opera meraviglie: «Se avete fede pari a un granellino di senapa potrete dire a questo monte: spostati di qua e là, ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile» (Mt 17,20). «Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno» (Mc 16,17). L’episodio evangelico della tempesta sedata, attraverso il rimprovero di Gesù ai suoi sulla pochezza della loro fede è un richiamo all’esigenza della fede e della fiducia in Gesù nella vita cristiana come caratteristica che la distingue e che ne costituisce la specificità nel mondo in mezzo agli uomini.
L’immagine della domenica

Laudato si’
Laudato si’,
mi’ Signore,
per sor’aqua,
la quale è multo utile
et humile
et pretiosa
et casta.
(Dal Cantico delle Creature)
Meditazione
Il racconto della ‘tempesta sedata’ nella versione di Marco 4,35-41 (la narrazione è presente anche in Mt 8,18.23-27 e Lc 8,22-25) è al centro della liturgia della Parola di questa domenica.
Ed è un racconto ricco di risonanze simboliche che rimandano chiaramente all’immaginario culturale e religioso biblico e che fanno da sottofondo a una narrazione segnata da significativi contrasti, interrogativi aperti, reazioni opposte. Da una parte Marco evidenzia la signoria di Gesù che trasmette una sovrumana tranquillità interiore, espressione di quella capacità di valutare la portata degli eventi, senza lasciarsi travolgere da essi in quanto si conosce il senso di ciò che sta accadendo. Dall’altra, di fronte a questa forza e serenità di Gesù che, singolarmente assume l’espressione simbolica del sonno (interpretata dai discepoli come una sorta di disinteresse: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?»: v. 38), c’è lo smarrimento dei Dodici su cui incombe l’esperienza della morte e che significativamente passa dalla paura al timore. Anche la natura sembra entrare in questo gioco di contrasti, quasi ad esprimere esteriormente ciò che i discepoli stanno vivendo nel loro cuore: Marco ci descrive lo spettacolo di una natura che scatena tutta la sua forza bruta, diventando incontrollabile e minacciosa, e lo spettacolo di una natura che rivela armonia e pace. Ed è un passaggio segnato da una parola e da un gesto che Gesù compie come risposta all’angosciata preghiera dei discepoli e che suscita un interrogativo finale: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mari gli obbediscono?» (v. 41). La dinamica di questo racconto ci suggerisce allora alcune sottolineature.
Anzitutto notiamo che un elemento simbolico e reale allo stesso tempo, emerge come sottofondo biblico di tutto il racconto. Ed è quello del mare. Secondo il linguaggio che caratterizza molti testi del Primo Testamento, l’immagine del mare, caratterizzata dalla superficie instabile delle acque e dai fenomeni minacciosi e imprevedibili della tempesta, rappresenta una potenza misteriosa e oscura, una forza non domabile dall’uomo. È l’esperienza dei naviganti descritta nel Salmo 106, i cui versetti 23-31 compongono il salmo responsoriale: travolti dalla tempesta su di un mare minaccioso, coloro «che commerciavano su grandi acque… si sentivano venir meno nel pericolo, ondeggiavano e barcollavano… tutta la loro abilità era svanita». Di fronte al pericolo minaccioso e alla morte che incombe, l’uomo non ha potere, perde la sua abilità. E appunto la reazione istintiva, connotata dalla paura della morte, che caratterizza anche i discepoli di fronte a quella «grande tempesta di vento» e a quelle «onde che si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena» (v. 37).
Secondo la Scrittura, solo Dio ha la forza di dominare questo spazio misterioso e pieno di incognite, perché solo Dio conosce i limiti entro cui questo simbolico luogo di morte può esercitare il suo potere. Così il Signore dice a Giobbe: «Chi ha chiuso fra due porte il mare?… gli ho fissato un limite… dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre e qui si infrangerà l’orgoglio delle tue onde”» (Gb 38,8-11). Il gesto di Dio che pone le acque dentro un spazio ben delimitato è il gesto della creazione (cfr. Gen 1,9-10). Ma Dio ha anche potere di piegare il mare e la sua forza bruta mettendolo a servizio del suo disegno di salvezza: il mare può diventare un cammino di liberazione, una strada sicura per il popolo di Dio (il passaggio attraverso il mar Rosso narrato in Es 14). La straordinaria ricchezza di queste immagini bibliche è come condensata nel gesto e nella parole di Gesù; proprio in quel Gesù, che Marco ci presenta anche molto umano, stanco, affaticato e per questo addormentato, si rivela la potenza di Dio. Gesù assume così i tratti del Kyrios, il Signore della creazione e dell’esodo.
Vediamo che Gesù, svegliato e quasi rimproverato dai discepoli terrorizzati (v. 38), «si destò». Questo movimento segna il passaggio dal sonno all’atteggiamento di colui che veglia ed è ben presente a se stesso e agli eventi che lo circondano; ma indica anche il passaggio da una situazione oscura e pericolosa segnata dalla morte incombente, alla vita (abbiamo qui una allusione alla dinamica pasquale). Ma significativa è anche la parola che Gesù pronuncia sul mare sconvolto dalla tempesta: «minacciò il vento e disse al mare: “Taci, calmati!”» (v. 39). Gesù ha l’ultima parola sul creato, sulla storia, su tutte le forze che la compongono e che la minacciano, perché tutto il creato e ogni evento dipendono da quella parola, in quanto solo essa ha la forza di creare e di rivelare il logos di tutto. Ecco perché a quella Parola «anche il vento e il mari gli obbediscono».
Se tutta la scena con il suo straordinario dinamismo ha la forza di rivelare l’identità di Gesù, essa permette anche di sottolineare l’atteggiamento del discepolo di fronte a questo volto che si rivela. Diventa allora fondamentale l’interrogativo con cui si chiude l’episodio: «Chi è dunque costui?» (v. 41). A un certo punto Gesù domanderà ai discepoli: «Ma voi, chi dite che io sia?» (Mc 8,29; la domanda che è posta da Marco al centro del cammino del discepolo). L’interrogativo pieno di stupore e di timore con cui si conclude il racconto della ‘tempesta sedata’ è come un avvio a questa consapevolezza che il discepolo deve maturare a riguardo della identità di Gesù. Ed è una consapevolezza che mette in gioco la fede. Ecco allora una altro interrogativo che Gesù stesso pone e a cui il discepolo deve dare una risposta proprio a partire da ciò che ha vissuto: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40). Nei discepoli c’è fede, perché prendono con loro Gesù «così com’era, sulla barca» (v. 39). C’è fede perché nel pericolo si accostano a Gesù e lo supplicano: «Maestro…». Ma manca in loro ancora fede, c’è un cammino ancora da compiere, devono ancora comprendere molto di Gesù. E soprattutto il salto di qualità da compiere, proprio a partire dalla esperienza vissuta, è quello che permette di passare dalla paura ad una abbandono totale nelle mani di Gesù, quel Gesù che li ha «scelti perché stessero con lui» (Mc 3,14), quel Gesù che, pur addormentato e apparentemente assente, conosce il cammino da seguire. La fede dei discepoli deve compiere un salto; deve, simbolicamente, passare all’altra riva. E proprio l’atteggiamento che suscita la domanda finale, segna l’inizio di questo passaggio. Alla fine il discepolo non ha più paura, ma ha timore, è il timore di fronte alla grandezza e alla potenza di un Dio che può veramente calmare il mare agitato delle vicende umane, un Dio che si prende cura della fragilità e della paure dell’uomo per educarlo alla fede in Lui. Forse il discepolo ha sempre bisogno di sentirsi rivolgere questa domanda da Gesù: Non avete ancora fede? Solo così il discepolo può camminare dietro a Gesù e comprender che la sua fede in lui deve incessantemente compiere altri passi, passare attraverso mari in tempesta, sperimentare pace e calma ed essere sempre accompagnata dall’interrogativo: Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?
Preghiere e racconti
L’inquietudine della notte della fede
Ripartire da Dio vuol dire sapere che noi non lo vediamo, ma lo crediamo e lo cerchiamo così come la notte cerca l’aurora. Vuol dunque dire vivere per sé e contagiare altri dell’inquietudine santa di una ricerca senza sosta del volto nascosto del Padre. Come Paolo fece coi Galati e coi Romani, così anche noi dobbiamo denunciare ai nostri contemporanei la miopia del contentarsi di tutto ciò che è meno di Dio, di tutto quanto può divenire idolo. Dio è più grande del nostro cuore, Dio sta oltre la notte.
Egli è nel silenzio che ci turba davanti alla morte e alla fine di ogni grandezza umana; Egli è nel bisogno di giustizia e di amore che ci portiamo dentro; Egli è il Mistero santo che viene incontro alla nostalgia del Totalmente Altro, nostalgia di perfetta e consumata giustizia, di riconciliazione e di pace.
Come il credente Manzoni, anche noi dobbiamo lasciarci interrogare da ogni dolore: dallo scandalo della violenza che sembra vittoriosa, dalle atrocità dell’odio e delle guerre, dalla fatica di credere nell’Amore quando tutto sembra contraddirlo. Dio è un fuoco divorante, che si fa piccolo per lasciarsi afferrare e toccare da noi. Portando Gesù in mezzo a voi, non ho potuto non pensare a questa umiliazione, a questa “contrazione” di Dio, come la chiamavano i Padri della Chiesa, a questa debolezza. Essa si fa risposta alle nostre domande non nella misura della grandezza e della potenza di questo mondo, ma nella piccolezza, nell’umiltà, nella compagnia umile e pellegrinante del nostro soffrire.
(Carlo Maria MARTINI, Incontro al Signore risorto, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2009, 66).
Cristo comandò al mare e si fece una grande bonaccia
Anche il sonno di Cristo è un segno esteriore di una realtà nascosta. Sono come dei naviganti quelli che fanno la traversata di questa vita su di un’imbarcazione. Anche quella barca era figura della chiesa. E ogni persona è tempio di Dio, naviga nel proprio cuore e non fa naufragio, se prova buoni sentimenti. Se hai udito un’offesa, è come il vento; sei adirato? Ecco la tempesta. Se soffia il vento e giunge la tempesta, corre pericolo la nave, corre pericolo il tuo cuore ed è agitato. All’udire l’offesa, desideri vendicarti; ecco, ti sei vendicato e, godendo del male altrui, hai fatto naufragio. E perché? Perché Cristo in te dorme. Che cosa significa: «In te Cristo dorme»? Che ti sei dimenticato di Cristo. Risveglia dunque Cristo, ricordati di Cristo, sia desto in te Cristo, considera lui. Che cosa volevi? Volevi vendicarti. Ti eri dimenticato che egli, essendo crocifisso, disse: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,24). Egli che dormiva nel tuo cuore non volle vendicarsi. Sveglialo e ricordalo. Il ricordo di lui è la sua parola, il ricordo di lui è il suo comando. Se in te è desto Cristo, tu dirai tra te e te: «Che razza di uomo sono io che mi voglio vendicare? Chi sono io, che mi permetto di minacciare un altro? Forse morrò prima di vendicarmi. E quando ansante, infiammato di collera e assetato di vendetta, uscirò da questo corpo, non mi accoglierà Colui che non volle vendicarsi, non mi accoglierà colui che disse: «Date e vi sarà dato, perdonate e vi sarà perdonato» (Lc 6,37-38). Frenerò allora la mia collera e tornerò alla pace del mio cuore». Cristo comandò al mare e si fece una grande bonaccia.
In tutte le altre vostre tentazioni attenetevi a ciò che ho detto riguardo all’ira. Quando sorge una tentazione, è come il vento; tu sei agitato, c’è la tempesta. Sveglia Cristo affinché parli con te. […] Imita i venti e il mare: ubbidisci al Creatore!
(AGOSTINO, Discorso 63,1-3, NBA XXX/1, pp. 284-286).
Come si fa ad avere fede?
«Un giorno, durante un acquazzone improvviso, ci riparammo nell’ingresso di una grotta. “Come si fa ad avere fede? gli chiesi là dentro”. “Non si fa, viene”. Lei ce l’ha già ma il suo orgoglio le impedisce di ammetterlo, si pone troppe domande, dov’è semplice complica. In realtà ha soltanto una paura tremenda. Si lasci andare e ciò che ha da venire verrà».
(Susana Tamaro, Va dove ti porta il cuore, Rizzoli, p. 148).
Il dubbio che porta al tramonto
Si narra che un alpinista, fortemente motivato a conquistare un’altissima vetta, iniziò la sua impresa dopo anni di preparazione. Deciso a non spartire la gloria con alcuno, iniziò l’impresa senza compagni.
Iniziò l’ascesa ma si fece tardi, sempre più tardi, senza che egli si decidesse ad accamparsi, insistendo nell’ascesa. Ben presto fu buio.
La notte giunse bruscamente sulle alture della montagna, sicché non si poteva vedere assolutamente nulla. Tutto era tenebra, il buio regnava sovrano, la luna e le stelle erano coperte dalle nubi.
Salendo per un costone roccioso, a pochi metri dalla cima, scivolò e precipitò nel vuoto, cadendo a velocità vertiginosa. Nella caduta, l’alpinista poteva appena vedere delle macchie scure e sperimentare la sensazione di essere risucchiato dalla forza di gravità. Continuava a cadere… e in quegli attimi angosciosi, gli passarono per la mente gli episodi più importanti della sua vita.
Rifletteva, ormai vicino alla morte. D’improvviso avvertì il violento strappo della lunga fune che aveva assicurato alla cintura.
In quel momento di terrore, sospeso nel vuoto, non gli rimase che gridare:
”Dio mio, aiutami!”
Improvvisamente una voce grave e profonda dal cielo gli domandò:
”Cosa vuoi che io faccia?”
“Mio Dio, salvami!”
“Credi realmente che io possa salvarti?”
“Sì, mio Signore. Lo credo”
Allora, recidi la corda che ti sostiene!”
Ci fu un momento di silenzio;
poi l’uomo si avvinse ancora più fortemente alla corda.
Il resoconto della squadra di soccorso, afferma che l’alpinista fu trovato, ormai morto per congelamento, fortemente avvinghiato alla corda… A soli due metri dal suolo…
La vita è un atto di fede
Ho appreso che la ricerca di Dio è una Notte Buia. E che anche la Fede è una Notte Buia. Di certo, non può dirsi una sorpresa. Per l’uomo, ogni giorno è una Notte Buia. Nessuno sa che cosa accadrà nell’istante successivo, eppure tutti vanno avanti. Perché ‘confidano’. Perché hanno Fede. […] Ogni momento della vita è un atto di fede.
(Paulo COELO, Brida, Bompiani, Milano, 2008, 31).
Racconto
In un paese c’ era un incrocio con tre strade: verso il mare, verso la città, verso nessuna parte.
Giovanna domanda, ma dove porta la strada «verso nessuna parte»..? Tutti i saggi del paese dicono che è pericoloso, che nessuno ha fatto mai questa strada, che non si torna più….Nonostante, Giovanna un giorno si decide a percorrere quella strada pericolosa…valli, montagne…alla fine trova un cane….il cane porta Giovanna ad una casa dove abita una fata misteriosa che dice: da tanto tempo aspettavo una visita…..guarda la mia casa e prendi l’oro che vuoi…..Cosi fece Giovanna….quando tornò al paese tutti aspettavano….vedendo l’oro che portava Giovanna tutti si affrettarono a percorrere la strada che ‘porta da nessuna parte’….Non trovarono nulla. Arrabbiati tornano da Giovanna: “sei una imbrogliona….bugiarda…”. Non, ma soltanto che per avere l’oro si deve percorrere la strada che porta verso nessuna parte.
Preghiera
Aiutami a fare silenzio, Signore,
voglio ascoltare la tua voce.
Prendi la mia mano,
guidami nel deserto,
per incontrarci soli, Tu e io.
Ho bisogno di contemplare il tuo volto,
ho bisogno del calore della tua voce,
di camminare insieme…
di tacere, perché possa parlare tu.
Mi metto nelle tue mani,
voglio guardare la mia vita,
scoprire ciò che deve cambiare,
rendere più saldo ciò che va bene,
sorprendermi per le novità che mi chiedi.
Aiutami a lasciar da parte la carriera,
le preoccupazioni che riempiono la testa,
blocca i miei dubbi e le mie insicurezze,
aiutami ad archiviare le mie risposte prefabbricate.
Voglio condividere con te la mia vita
e verificarla accanto a te.
Vedere dove “preme forte e sicura la scarpa”
per operare il cambio.
Portami nel deserto, Signore,
liberami da ciò che mi lega,
scuoti le mie certezze
e metti alla prova il mio amore.
Per incominciare nuovamente,
umile, semplice,
con la forza dello Spirito,
a vivere fedele a Te.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno B, Milano, Vita e Pensiero, 2008.
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia, Milano, Vita e Pensiero, 2011.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.
PER L’APPROFONDIMENTO:
XII DOM TEMP ORD ANNO B