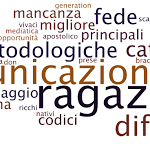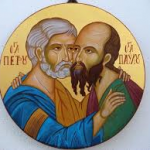
Prima lettura: Atti 12,1-11
|
In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli Azzimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati, in fretta!». E le catene gli caddero dalle mani. L’angelo gli disse: «Mettiti la cintura e légati i sandali». E così fece. L’angelo disse: «Metti il mantello e seguimi!». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell’angelo: credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città; la porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l’angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva». |
2 L’ultima comparsa di Pietro negli Atti l’abbiamo in 15,7-11, dove si dimostra persona equilibrata e responsabile che cerca di mediare fra due opposte posizioni, a proposito delle condizioni da imporre ai pagani convertiti. Egli è la figura dominante del racconto proprio fino a questo cap. 12, per cedere dopo il ruolo di protagonista a Paolo. L’episodio in esso contenuto, dell’arresto di Pietro e della sua liberazione, si estende fino al v. 19 (la pericope liturgica finisce con il v. 11), e risulta particolarmente colorito per la sua ambientazione, tra la notte e il giorno, nella città di Gerusalemme:
«Pietro uscì e prese a seguirlo […]10Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città; la porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada […]12 Dopo aver riflettuto, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni detto anche Marco, dove si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera.
13Appena ebbe bussato alla porta esterna, una fanciulla di nome Rode si avvicinò per sentire chi era. 14Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse ad annunziare che fuori c’era Pietro».
Ma le cose più importanti sono, naturalmente, altre: la liberazione prodigiosa che indica come è il Signore a garantire il cammino inarrestabile del Vangelo nel mondo e, poi, la vicinanza della comunità attorno al suo apostolo: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva» (v. 11); «Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui» (v. 5).
«Egli allora, fatto segno con la mano di tacere, narrò come il Signore lo aveva tratto fuori del carcere, e aggiunse: “Riferite questo a Giacomo e ai fratelli”» (v. 17). In questo caso Giacomo, considerato come il capo dei giudeocristiani di Gerusalemme e che guiderà questa chiesa dopo la partenza di Pietro, era parente di Gesù, ed è distinto da Giacomo apostolo, fratello di Giovanni, già messo a morte da Erode (v. 2). L’episodio degli stessi Atti letto nella vigilia (At 3,1 -10) presenta un altro momento importante della vicenda di Pietro che dice: «Non possiedo ne argento ne oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù, il Nazareno, cammina!» (v. 6).
Seconda lettura: 2 Timoteo 4,6-8.17-18
|
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. |
2 La lettura dedicata a Paolo riguarda una retrospettiva sulla sua vita passata, prossima alla fine, che gli consente di farne un bilancio davanti a Dio. Nel v. 6 l’immagine della libagione, che nei sacrifici comportava l’uso di vino, acqua e olio (Es 29,40; Nm 28,7), secondo il testo greco non riguarda «il sangue», parola supplita impropriamente nella versione italiana, perché la metafora si applica anche alla morte naturale e non implica per sé una morte cruenta nel martirio.
Veramente la vita di Paolo è stata una battaglia e una corsa per il Vangelo. Ciononostante, egli non si considera in una posizione speciale di fronte a Dio, ma accomunato con gli altri credenti «che hanno atteso con amore la sua manifestazione» (v. 8b). Giustamente la missione di Paolo viene caratterizzata dal fatto che è stata indirizzata in maniera intenzionale a «tutte le genti» (v. 17). Lo stesso concetto è messo a fuoco nell’appassionato brano autobiografico proposto nella vigilia (Gal 1,11-20) dove si parla dei «pagani», ma si usa in greco anche ethnē (v. 16). Anche qui si ribadisce il dono della rivelazione ricevuta direttamente da Dio (vv. 15-16), analogamente a quanto sottolineato nel macarismo rivolto a Pietro in Mt 16,17. E proprio nello stesso contesto si trova l’eco del conflitto di Paolo con Pietro, i due apostoli associati nell’odierna festività. «[…] visto che a me era stato affidato il vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi — poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per i pagani… Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto perché evidentemente aveva torto» (Gal 2,7-11).
Vangelo:Matteo 16,13-19
|
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono. Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». |
Esegesi
Questo brano evangelico qualificato come il vangelo del «primato», è stato visto nel corso della tradizione da diverse angolazioni, imperniate ora sull’accentuazione e ora sulla contestazione del primato di Pietro che perdura nel ministero petrino del Papa. Noi lo vogliamo ora ricordare per la sua portata ecclesiologica ed ecclesiale, cioè in senso dottrinale e in senso spirituale.
a) Il contesto
Nello schema di Mc, seguito da Mt, ci troviamo alla conclusione del ministero pubblico di Gesù in Galilea. D’ora in poi diventa dominante il tema della sua prossima morte a Gerusalemme, sottolineato dai tre annunzi della passione che scandiscono la seconda parte del vangelo; il primo di essi segue immediatamente nei vv. 21-23. La scena si colloca a Cesarea di Filippo che si trova a 50 km a nord del lago di Genezaret, al confine con il territorio pagano. Ora Gesù, non è seguito più dalla folla, ma si trova solo con i suoi discepoli, con i quali tenta un bilancio della predicazione svolta finora, chiedendo quello che su di lui pensa la gente.
Quindi, alla domanda su cosa ne pensano loro, solo Pietro prende la parola.
b) Confronto con i Sinottici
Nella risposta di Pietro, Mt è il più completo («Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»), mentre Mc 8,29b («Tu sei il Cristo» e Lc 9,20b «Il Cristo di Dio») sono più semplici. Ma dopo questa confessione di fede, solo Mt contiene la lunga risposta di Gesù dei vv. 17-19, che, dal punto di vista formale, presentano tre strofe di tre righe ciascuna, di cui le ultime due sono costruite con un parallelismo di tipo antinomico.
e) Il macarismo (v. 17)
«Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli ». Non si hanno altri esempi di macarismi diretti in seconda persona, se non in Dt 33,29a: «Te beato, Israele! Chi è come te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo della tua difesa e la spada del tuo trionfo». Anche qui, come nel v. 17 si mette in evidenza il dono di Dio e non un merito umano. Pietro deve ad una rivelazione del Padre la capacità di cogliere nella fede la vera identità di Gesù. La carne e il sangue, l’uomo lasciato a se stesso, non può giungere alla fede.
d) L’immagine della pietra/roccia (v. 18)
«E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa». Colui che poco prima è stato identificato come Simone, e ora chiamato Pietro, un nome che consente il passaggio all’immagine della «pietra» che serve a qualificare la funzione che lui è chiamato a svolgere nell’edificio della Chiesa.
Come in italiano, anche in greco il passaggio dal maschile Pietro (gr. petros) al femminile pietra (gr. petra) non permette di notare la ripetizione della stessa parola aramaica kepha’ (pietra, roccia) che si deve presupporre in entrambi i casi, cosa che rende più evidente un gioco di parola che deve essere stato intenzionale. Il simbolo della roccia come solido fondamento per la costruzione della casa è richiamato alla fine del discorso della montagna: «Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia» (Mt 7,24s).
e) L’immagine delle chiavi (v. 19)
«A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Se l’immagine delle chiavi è coerente con quella precedente dell’edificio, nel quale ci deve essere pure un’entrata, non è altrettanto ovvio il passaggio dalle chiavi all’idea di legare e sciogliere, giacche esse rimandano piuttosto alle azioni di entrare ed uscire. Sembra perciò più logico vedere qui sovrapposte due immagini parallele di tipo diverso: le chiavi servono per fare entrare (cf. Is 22,22b: «se egli apre, nessuno chiuderà: se egli chiude, nessuno potrà aprire»), mentre l’azione del legare o sciogliere riguarda un giudizio di tipo dottrinale o disciplinare che sarà ratificato nei cieli.
Vale ora la pena rileggere alla luce del nostro brano altri passi che parlano di Pietro o del ministero degli Apostoli nel cui quadro anche quello che gli è più specifico trova una sua coerente collocazione.
j) Gli altri evangelisti su Pietro
Giovanni riporta una variante della vocazione di Pietro e della sua professione di fede: «Egli (Andrea) incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: ‘Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)’ e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: ‘Tu sei Simone, figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (gr. kêphas) (che vuol dire Pietro)» (Gv 1,41s); si notino le differenze tra Mc 1,16-18, Mt 4,16-20 e Lc 5,11.
«E (Gesù) continuò: “Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre mio”. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: “Forse anche voi volete andarvene?”. Gli rispose Simon Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”» (Gv 6,65-69).
Luca ci riporta questa particolare confidenza fatta da Gesù a Pietro nell’ultima cena: «“Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come grano: ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli”. E Pietro gli disse: “Signore, con te sono pronto ad andare in prigione e alla morte”.
Gli rispose: “Pietro, io ti dico: non canterà oggi il gallo prima che tu per tre volte avrai negato di conoscermi”». (Lc 22,31-34).
g) Gli altri Apostoli (in Mt)
«Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti, esclamando: “Tu sei veramente il Figlio di Dio!”» (Mt 14,33): è questa una confessione di fede uguale a quella che si incontrerà in Mt 16,16. La missione fondamentale degli Apostoli riguarda la disciplina all’interno della comunità (Mt 18,18) e, soprattutto, la predicazione: «In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo» (18,18); «E Gesù, avvicinatesi, disse loro: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”» (28,18-20). Con queste parole finali del Risorto la missione degli Apostoli e quella di Pietro ricevono la loro suprema legittimazione e il loro perenne fondamento. Ed è proprio in una apparizione del Risorto che si colloca il rinnovato conferimento del primato a Pietro, letto nella messa della vigilia, che pure allude alla fine alla sua fedeltà fino al martirio (Gv 21,15-19; v. 19).
Meditazione
Al cuore della celebrazione odierna vi è la memoria di Pietro e Paolo. Il pescatore di Galilea reso pescatore di uomini e il fariseo zelante della Legge, il persecutore dei cristiani, conquistato da Gesù Cristo e reso apostolo delle genti; Pietro, il primo del gruppo dei Dodici e Paolo, che di quel gruppo non ha fatto parte e non ha conosciuto Gesù storicamente, ma è stato reso apostolo per volontà del Signore; Pietro, l’apostolo dei circoncisi, e Paolo, l’apostolo degli incirconcisi. Vie differenti, vite diverse, itinerari distanti, personalità entrate in conflitto tra di loro (cfr. Gal 2,11 ss.), eppure, in Cristo, entrambi affratellati a tal punto che i loro cammini esistenziali hanno trovato in Roma il luogo del martirio. Un unico cammino di obbedienza al Cristo Signore conduce entrambi, nelle differenze che li caratterizzano, a dare la vita per il Signore.
Se il vangelo è centrato sulla figura di Pietro e sul suo mandato ecclesiale, la prima e la seconda lettura riguardano momenti dell’esperienza della sofferenza apostolica di Pietro (At 12: l’incarcerazione di Pietro) e di Paolo (2Tm 4: prossimità alla morte di Paolo).
La prima lettura presenta un frangente particolarmente critico della giovane comunità cristiana di Gerusalemme. Giacomo è stato decapitato; Pietro incarcerato: chi sosterrà la comunità? Di fronte alle persecuzioni che si abbattono sui suoi capi, la comunità prega. Una particella greca con valenza avversativa (At 12,5: « ma una preghiera… » ) dice che la preghiera è la forma con cui la comunità cristiana vive la sua lotta contro i potenti del mondo che scatenano persecuzioni e violenze. Con la preghiera la comunità rimane vicina a Pietro in carcere e intercede per lui, «combatte con e per lui» (come afferma l’insegnamento paolino sulla preghiera: cfr. Rm 15,30; Col 4,12), manifesta la sua obiezione nei confronti della prepotenza dei potenti, persevera nella fede e non si piega agli eventi avversi.
Nella seconda lettura Paolo, al termine della sua esistenza, in prossimità ormai del traguardo, guarda la sua vita come a ritroso, a partire dal momento finale che sa vicino: e la considerazione che più colpisce è che egli constata di aver conservato la fede (2Tm 4,7). Gesù, in un momento critico del proprio cammino esistenziale, aveva pregato per Pietro, perché la sua fede non venisse meno (Lc 22,32). Paolo, al termine della sua vita, con umile fierezza e senso di gratitudine, riconosce di aver conservato la fede. Al termine di una vita spesa per l’evangelizzazione, la missione, la predicazione della parola, il servizio del vangelo, la fondazione e l’organizzazione di comunità cristiane, Paolo ricorda il suo essere ancora un credente. A dire che la fede non può mai essere data per scontata, anche per gli uomini di chiesa. Forse la grande fatica apostolica è proprio questa: conservare la fede.
Pietro viene proclamato beato da Gesù perché la confessione di fede in lui quale Messia e Figlio di Dio è frutto di rivelazione del Padre (Mt 16,17), così come Paolo affermerà che è per rivelazione di Dio che egli ha conosciuto l’evangelo e il Figlio Gesù Cristo (Gal 1,12.16). Sia Pietro che Paolo rientrano fra quei piccoli a cui la conoscenza delle cose di Dio, ed essenzialmente la conoscenza di Gesù, in cui si sintetizza il tutto di Dio, viene consegnata per rivelazione, per dono divino (Mt 11,25-27). È la conoscenza pneumatica di Gesù, la relazione con lui, l’amore per lui, sono il cardine attorno a cui ruota il ministero di Pietro e di Paolo.
Alla confessione di Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16), risponde la parola di Gesù: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa» (Mt 16,18). Pietro sa bene (come anche Paolo: 1Cor 3,11) che non vi è altra pietra di fondamento dell’edificio della chiesa al di fuori del Cristo risorto (1Pt 2,4 ss.). Ma attraverso le immagini della roccia, delle chiavi e del potere di sciogliere e legare, Pietro è stabilito come il necessario punto di autorità e di comunione nella chiesa. Non la sua persona (il sangue e la carne) da stabilità alla chiesa, ma la sua fede che rinvia a Colui che è il Signore della chiesa.
Preghiere e racconti
Conferma i tuoi fratelli
Il nostro Salvatore e Signore disse a Pietro: «Simone, Simone, ecco che Satana ha ottenuto di vagliarvi come grano e io ho pregato per te affinché non venga meno la tua fede; ma tu, una volta ritornato a me, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,31-32). È come se dicesse: «Io ti sostengo quando vacilli e così anche tu sii un appoggio per quelli dei tuoi fratelli che sono turbati e accorda loro un po’ della protezione di cui godi. Non spingere quelli che stanno per scivolare, ma nel pericolo rialzali. Io consento che tu inciampi, ma non ti lascio cadere affinché tu mi aiuti a tenere in piedi quelli che vacillano. Così Pietro, questa grande colonna, ha sostenuto tutti quelli che vacillavano e ha impedito loro di crollare; li ha rialzati, li ha resi più saldi e, incaricato di pascolare il gregge di Dio, accettava di essere insultato a causa del gregge e, sotto i colpi, gioiva. Uscendo dal sinedrio malvagio gioiva con il suo compagno perché aveva meritato di essere maltrattato per il nome del Signore (cfr. At 5,41). Gettato in prigione, era contento e tutto felice. Quando, sotto Nerone, fu condannato a morire sulla croce per il Crocifisso, pregava i carnefici di non inchiodarlo nello stesso modo del Signore, ma nel senso contrario, per timore, sembra, che il subire la croce nello stesso modo producesse un’uguale venerazione da parte degli ignoranti. Per questo supplicò che lo si inchiodasse con le mani in basso e i piedi in alto. Aveva imparato, infatti, a scegliere l’ultimo posto, non soltanto nell’onore, ma anche nella vergogna. E se avesse potuto morire dieci volte, cinquanta volte, lo avrebbe accettato volentieri perché ardeva del desiderio di Dio. Anche il divino Paolo esclamava la stessa cosa; talora diceva: «Ogni giorno rischio la morte, come è vero che voi siete il mio vanto in Cristo Gesù» (1Cor 15,31), e tal’altra: «Sono crocifisso con Cristo; non sono più io che vivo è Cristo che vive in me» (Gal 2,20).
(TEODORETO DI CIRO, Sulla divina carità 12-13, SC 257, pp. 290-292).
Il fascino di Paolo
Vorremmo in questo breve spazio far risaltare una figura di altissimo rilievo nel Nuovo Testamento, quella di Paolo, l’apostolo per eccellenza al quale sono attribuite dal Canone 13 lettere. San Girolamo, il grande traduttore e interprete della Bibbia, non aveva esitato a scrivere che Paolo «non si preoccupava più di tanto delle parole, una volta che aveva messo al sicuro il significato».
E, secoli dopo, un altro grande studioso delle Scritture, Erasmo da Rotterdam, morto nel 1536, ribadiva che, «se si suda a spiegare le idee di poeti e oratori, con questo scrittore (Paolo) si suda ancor più a capire cosa voglia e a che cosa miri». Il suo effettivamente è un linguaggio strano, travolto dall’irrompere del suo pensiero e della sua passione: egli impedisce che l’incandescenza del messaggio da comunicare si raggeli negli stampi freddi dello stile e delle regole, insomma di un bel testo.
Ma proprio questa ribellione diventa la ragione del fascino che l’apostolo ha sempre esercitato coi suoi scritti, a partire dal vescovo e grande oratore francese Bossuet che in un panegirico del 1659 esaltava «colui che non lusinga le orecchie ma colpisce diritto al cuore», mentre un altro francese, il romanziere Victor Hugo nel suo William Shakespeare (1864) inseriva Paolo tra i genii, «santo per la Chiesa, grande per l’umanità, colui al quale il futuro è apparso: nulla è superbo come questo volto stupito dalla vittoria della luce».
Conquistato dall’apostolo e dai suoi scritti era stato anche Pier Paolo Pasolini che nel 1968 aveva pensato di dedicargli un film del quale è rimasto solo un abbozzo di sceneggiatura, pubblicato postumo nel 1977 col titolo San Paolo (ed. Einaudi). Il notissimo scrittore e regista pensava di trasporre la vicenda e il messaggio dell’apostolo ai nostri giorni, sostituendo le antiche capitali del potere e della cultura visitate da Paolo con New York, Londra, Parigi, Roma e la Germania. Scriveva, infatti, Pasolini:
«Paolo è qui, oggi, tra noi. Egli demolisce rivoluzionariamente, con la semplice forza del suo messaggio religioso, un tipo di società fondata sulla violenza di classe, l’imperialismo, lo schiavismo».
Certo, quella parola disadorna, «senza sublimità di discorso o di sapienza», come Paolo stesso confessava ai Corinzi (I Cor 2,1), ha incrinato tante strutture e tanti luoghi comuni del potere e della cultura imperiale romana. Ma la forza, la passione, l’entusiasmo del suo “messaggio religioso” erano nell’amore per Gesù Cristo. Un amore che gli fa dettare le pagine più intense e splendide. Per questo è del tutto insufficiente e fuorviante la definizione di «Lenin del cristianesimo» che gli riserverà una persona pur acuta e sincera come Antonio Gramsci. Per capire Paolo è necessario prendere in mano e leggere quelle sue lettere che – come diceva il nostro grande poeta Mario Luzi – s’insediano «nell’inquieta aspettativa degli uomini per dare un senso alla speranza».
(G. Ravasi).
Mi ami tu?
Ecco che il Signore, dopo la sua resurrezione, appare di nuovo ai suoi discepoli. Interroga l’apostolo Pietro e spinge a confessare per tre volte il proprio amore colui che aveva rinnegato tre volte per timore. Cristo è risorto secondo la carne, Pietro secondo lo spirito. Mentre Cristo moriva soffrendo, Pietro moriva rinnegando. Il Signore Cristo resuscita dai morti e nel suo amore resuscita Pietro. Ha interrogato l’amore di colui che lo confessava e gli ha affidato le sue pecore. […] Il Signore Cristo volendo mostrarci in che modo gli uomini debbano provare che lo amano, lo rivela chiaramente: va amato nelle pecore che ci sono affidate. Mi ami tu? Ti amo. Pasci le mie pecore. E questo una volta, due volte, tre volte. Pietro non dice altro se non che lo ama. Il Signore non gli domanda altro se non se lo ama.
A Pietro che gli risponde non affida altro se non le sue pecore. Amiamoci a vicenda e ameremo Cristo. Cristo, infatti, eternamente Dio, è nato uomo nel tempo. E apparso agli uomini come uomo e figlio dell’uomo. Essendo Dio nell’uomo, opera molti miracoli. Ha molto sofferto, in quanto uomo, da parte degli uomini, ma è risorto dopo la morte perché era Dio nell’uomo. Ha passato sulla terra quaranta giorni come un uomo con gli uomini. Poi, sotto i loro occhi, è asceso al cielo come Dio nell’uomo e si è assise alla destra del Padre. Tutto questo lo crediamo, non lo vediamo. Ci è stato ordinato di amare Cristo Signore che noi non vediamo e tutti noi proclamiamo: «Io amo Cristo». Ma se non ami il fratello che vedi, come puoi amare Dio che non vedi? (I Gv 4,20). Amando le pecore, mostra di amare il pastore, perché le pecore sono membra del Pastore.
(AGOSTINO, Discorso Morin Guelferbytanus 16, PLS 2,579-580).
Preghiera a Gesù Buon Pastore
O Gesù buon Pastore,
nei santi apostoli Pietro e Paolo
hai dato alla tua Chiesa
due modelli di Pastori
secondo il tuo cuore.
Fa’ che, sul loro esempio
e confortati
dalla loro testimonianza,
impariamo ad amare
e servire i fratelli
con gioia e gratuità.
O santi apostoli Pietro e Paolo
intercede per noi,
affinché possiamo vivere
in comunione nelle diversità dei doni e dei ministeri.
Amen!
(dagli scritti di don Alberiore)
Preghiera al canto del gallo
O eterno creatore di ogni cosa,
tu che governi la notte e il giorno
e stabilisci il momento del tempo
di alleviare le angosce.
Già si sente l’annunciatore del giorno,
della profonda notte vigile,
luce notturna per i viandanti,
che separa la notte dalla notte.
Risvegliato da lui Lucifero,
libera il cielo dalle tenebre,
per lui ogni schiera di coloro che errano,
abbandona le strade del male.
Per lui il marinaio si rinvigorisce
e si placano i flutti del mare,
per lui anche la pietra della chiesa
al suo canto lava il peccato.
Alziamoci perciò subito,
il gallo sveglia chi ancora giace,
e richiama gli assonnati,
il gallo rimprovera quelli che si rifiutano.
Quando canta il gallo ritorna la speranza,
la salute viene restituita agli infermi,
viene riposta l’arma del bandito,
a coloro che cadono ritorna la fede.
O Gesù, salvaguarda chi vacilla,
corrige, e correggici col tuo sguardo,
se ci guardi annulli le colpe:
il peccato si dissolve nel pianto.
Tu luce illumina i sensi
dissipa il torpore dell’animo,
la nostra voce invochi te per primo,
e rivolgiamo a Te le nostre preghiere.
(Ambrogio di Milano)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004;2007-.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– Comunità domenicana di Santa Maria delle Grazie, La grazia della predicazione. Tempo di Quaresima e Tempo di Pasqua, in «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 95 (2014) 2, pp.67.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Tempo ordinario anno A, Milano, vita e Pensiero, 2010.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
– F. ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità. Anno A, Padova, Messaggero, 2001.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
PER L’APPROFONDIMENTO: