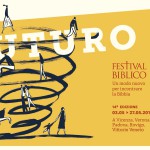Prima lettura:Atti 10,25-27.34-35.44-48
|
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati: anche io sono un uomo!». Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
|
v Il brano che leggiamo risulta da tre piccoli ritagli di quel grande affresco che è il cap. 10 degli Atti. Consigliamo di rileggere tutto il cap. 10 nella sua interezza. Siamo ad un momento decisivo del cammino missionario della Chiesa primitiva: la conversione di Cornelio assume dimensione emblematica dell’apertura della predicazione al mondo pagano.
— «Si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio» (v. 25). Di fronte ai prodigi e ad un essere superiore che si ritiene celeste, il mondo pagano reagisce con atteggiamento di adorazione. Così capita anche a Paolo e Barnaba, a seguito di un miracolo, a Listra (At 14,11-15).
— «Alzati…» (v. 26). La predicazione cristiana è sempre attenta ad evitare l’equivoco che si può creare sulla persona degli apostoli, chiarendo che non sono esseri celesti e superiori, ma uomini come gli altri. Coerente con tale chiarimento, Pietro conversa con il centurione con familiarità, allargando l’incontro con le molte persone che sono in quella casa (v. 27).
— «Dio non fa preferenze di persone» (vv. 34-35). È l’inizio del discorso di Pietro: non è soltanto citazione dell’AT (vedi Dt 10,17; Sp 6,7; Sir 35,5), ma ammirata constatazione che trova riscontro nei fatti che Pietro sta vivendo: il privilegio di ricevere la parola di Dio non appartiene più esclusivamente al popolo ebraico. È l’inizio del cammino universale della predicazione cristiana, dell’annuncio della salvezza.
— «Accoglie chi lo teme e pratica la giustizia» (v. 35). Allargata a tutti i popoli, la misericordia di Dio non esige che due disposizioni negli uomini ai quali si rivolge: a) timore e rispetto intimo di Dio riconosciuto come unico e onorato nella propria coscienza; b) pratica della giustizia, ossia di una profonda onestà nei doveri naturali.
— «Lo Spirito Santo discese sopra tutti…» (vv. 44-48). Il racconto che segue è indicato come la «pentecoste dei pagani». Lo stesso Pietro sottolinea che «questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo» (v. 47). Questi pagani, senza seguire le usanze giudaiche, e senza alcuna particolare preparazione, ricevono lo Spirito Santo: ciò dimostra — come rileva l’apostolo Pietro — che sono già pronti per ricevere il battesimo (v. 47). L’effetto carismatico, prodotto nei pagani dalla discesa dello Spirito Santo, è simile a quello ricevuto dagli apostoli nella prima pentecoste: consiste nel fatto di esprimersi in lingue nuove e nel lodare Dio in modo estatico (v. 46). In entrambi gli aspetti è da vedere l’unificazione della famiglia umana nel dono delle lingue e della preghiera, questa volta anche nel mondo pagano.
Seconda lettura: 1Giovanni 4,7-10
|
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.
|
v In uno sviluppo parenetico (cioè di carattere prevalentemente esortativo) pressoché parallelo a quello della II Lett. di domenica scorsa, la Prima Epistola di Giovanni insiste sulla necessità, per i cristiani, di avere una fede autentica ed un vero amore (4,7;5,4), con la
probabile intenzione di stigmatizzare l’insorgere di alcune eresie nella chiesa primitiva. Senza vero amore non c’è vera fede, e viceversa. Il brano di oggi si colloca esattamente all’inizio di tale sviluppo.
Tre le affermazioni fondamentali contenute nella nostra lettura:
— Prima: Dio non è conoscibile se non attraverso la via dell’amore (vv. 7-8). Perché? Dio è amore, in senso operativo, cioè ogni sua attività è mossa da amore. Ne derivano due conseguenze che si possono esprimere in termini positivi e negativi: solo chi ama è nato da Dio (v. 7), solo chi ama i fratelli «conosce», cioè mostra di avere un’esperienza vera e pro-fonda di Dio. Di fatto, l’assenza di amore rende impossibile ogni comunicazione e comunione con Dio (v. 8). Per S. Agostino la conoscenza dello stesso mistero trinitario non avviene se non attraverso un movimento di amore.
— Seconda: non c’è prova più evidente che Dio è mosso da amore, che il fatto della venuta del Figlio Unigenito nel mondo, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui (v. 9). «Unigenito»: questo titolo attribuito al Figlio ha due valenze: a) è sinonimo di amato, diletto, oggetto di amore unico, e in tal caso sottolinea la grandezza del dono di Dio, mandandolo nel mondo; b) sottolinea l’unicità del Figlio di Dio come rivelatore del Padre; egli è l’unico che veramente possa rivelarci il volto del Padre: «Nessuno conosce il Padre se non il Figlio…» (Mt 11,27).
— Terza: caratteristica dell’amore divino è che previene l’amore dell’uomo; non aspetta di essere amato per amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, (v. 10) anzi noi abbiamo tradito il suo amore col peccato. Ma egli ha preso per prima l’iniziativa e ha mandato il suo Figlio in funzione di espiare, cioè offrire il sacrificio, per i nostri peccati.
Vangelo: Giovanni 15,9-17
|
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
|
Esegesi
Il brano evangelico odierno costituisce l’immediato seguito del vangelo di domenica scorsa (vv. 1-8), ed in certo senso ne è l’illustrazione in termini parenetici. Il brano è costituito grosso modo da due sezioni che fanno capo a due parole-chiave: la parola «amore» e la parola «amici».
Chiariamo il senso di queste due parole fondamentali su cui il nostro brano è costruito: «amore» e «amico»:
— amore (in gr. agapō) a differenza di altri verbi che implicano reciprocità e scambio, se si applica a Dio, indica un movimento di amore assolutamente gratuito e illimitato (vedi II Lettura). La fonte è divina e eterna: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi (v. 9), comunicandosi agli uomini nel tempo. Abbiamo così una serie di anelli che costituiscono tutti essenzialmente il senso dell’agape cristiano: Padre-Figlio-discepoli e discepoli tra loro. La comparazione: rimanete nel mio amore, come io rimango nell’amore del Padre (cf. v. 10) non indica solo un rapporto esemplare o di imitazione. Il come indica la natura e il fondamento stesso dell’amore cristiano, che sgorga ed è alimentato dall’amore trinitario. Perciò l’espressione «nel mio amore», pur potendosi intendere nel senso dell’amore dei discepoli per Gesù, è però più coerente intenderlo come amore di Gesù per i discepoli. Concepito così, tale amore va fino al sacrificio di sé, come lo è stato per quello di Gesù (v. 13);
— amicizia, amico (in gr. philos). Nei rapporti umani, l’amicizia si stabilisce tra due persone che sono sullo stesso piano. Questo è vero per l’amicizia di Gesù per i discepoli, se si tiene però conto che è lui ad elevarci dal livello di schiavi (doulos) a quello di amici. La differenza, come spiega il Signore, va capita nella prospettiva della comunicazione: tra servo e padrone non c’è comunicazione, perché abitualmente il padrone non fa sapere, e quindi non comunica al servo quello che fa e perché lo fa (v. 15). Gesù invece comunica e rivela ai discepoli quello che ha «udito» dal Padre, cioè li rende partecipi della sua relazione intima e filiale col Padre (v. 15).
Inoltre, sul piano dell’amicizia umana, ognuno è e si sente autore delle scelte che fa, e non stabilisce le finalità che l’altro deve raggiungere. Nell’amicizia con Gesù non è così: non i discepoli hanno scelto lui, ma lui ha scelto loro — elevandoli al suo livello — con iniziativa gratuita e sovrana (v. 16), e li ha scelti con un preciso scopo: assegnare loro una missione (portare frutto) stabile e duratura (v. 16).
Meditazione
«Amiamoci gli uni gli altri». È l’imperativo che l’apostolo Giovanni non si stanca di rivolgere alla sua comunità. Egli sa bene quanto l’amore sia centrale nella vita dei discepoli. Lo ha appreso direttamente da Gesù. Ma più che da una lezione teorica o da un’esortazione morale, Giovanni ne ha fatto l’esperienza concreta. Ne ha potuto gustare la dolcezza e la tenerezza, ne ha visto la radicalità e l’ampiezza che giungeva sino all’amore per i nemici, anzi sino al dono della stessa vita. Di questo amore Giovanni è stato un testimone privilegiato, un custode attento e un predicatore sollecito. Nella sua prima lettera vuole svelarne la natura e indicarne la fonte: «Amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio; chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio» (1Gv 4,7). L’apostolo parla qui di un amore diverso da quello che normalmente noi intendiamo con questo termine. L’amore per noi è quel complesso di sentimenti che nasce spontaneo dal cuore, fatto di attrazione fisica, simpatia, desiderio, passione, compiacimento e soddisfazione di sé. Nel linguaggio del Nuovo Testamento per indicare tale amore si usa il termine greco «eros». L’apostolo usa, invece, la parola «agape» per connotare l’amore che nasce da Dio e che deve presiedere i rapporti tra i discepoli.
Per comprendere l’amore di Dio (l’agape) non bisogna perciò partire da noi stessi, dalle nostre speculazioni teoriche, dai nostri sentimenti o dalla nostra psicologia ma, appunto, da Dio. Le Sante Scritture sono il documento privilegiato per comprendere tale amore; esse infatti non sono altro che la narrazione della vicenda storica dell’amore di Dio per gli uomini. Pagina dopo pagina, nelle Sante Scritture scorgiamo un Dio che sembra non darsi pace finché non trova riposo nel cuore dell’uomo. Potremmo parafrasare per il Signore la nota frase che sant’Agostino applicava all’uomo: «Inquietum est cor nostrum…». Un sacerdote poeta, Davide Maria Turoldo, ha parlato del «cuore inquieto di Dio»: Egli è venuto sulla terra per cercare e salvare ciò che era perduto, per dare la vita a ciò che non aveva più vita. È un Dio che si fa mendicante, mendicante di amore. In verità, mentre Egli stende la mano per chiedere amore lo dà agli uomini. Egli è la luce che penetra nelle tenebre, per dare vita, per spiritualizzare, per elevare e salvare. Questo è l’amore cristiano: Dio che scende, gratuitamente, nel più basso per raggiungere l’amato.
Sì, Dio è inquieto finché non trova l’uomo. E lo è a tal punto «da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3, 16). L’amore di Dio, potremmo dire, «è in discesa», si abbassa fino a giungere nel più profondo della vita degli uomini, e con una dedizione totale, «sino a dare la vita per i propri amici, come Gesù stesso dice. Si legge ancora nella prima lettera di Giovanni: «In questo sta l’amore (cristiano): non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati» (1Gv 4, 10). È Dio che ama per primo, e ama perfino gli esseri immeritevoli del suo amore. È, in effetti, un amore totalmente gratuito; anzi immotivato. Dio, infatti, non ama i giusti ma i peccatori, i quali non sono degni di essere amati. Paolo dice che Dio ha scelto le cose che non contano perché contassero; ha scelto le cose che sono abominevoli di fronte agli uomini, per farne oggetto della sua grazia (1Cor 1, 28). Questo è il Dio dei Vangeli: un Dio che è mosso da un amore che non si fa indietro neppure davanti alla mancanza di vita, alla negazione dell’amore. Dio si fa piccolo pur di raggiungere il più disgraziato degli uomini e arricchirlo della sua amicizia. La storia stessa di Gesù è racchiusa in tale amore. Dio, infatti, non è l’Essere in sé, alla maniera del pensiero aristotelico, ma è l’Essere per noi, è apertura infinita, è amore appassionato per noi.
Se l’intera Scrittura è la storia dell’amore di Dio sulla terra, i Vangeli ne mostrano il culmine. Perciò, se vogliamo balbettare qualcosa dell’amore di Dio, se vogliamo dargli un volto e un nome, possiamo dire che l’amore è Gesù. L’amore è tutto ciò che Gesù ha detto, vissuto, fatto, amato, patito… L’amore è cercare i malati, è avere per amici noti peccatori e peccatrici, samaritani e samaritane, gente lontana, nemica e rifiutata. Infatti «nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici». L’amore è dare la propria vita per tutti, è restare soli per non tradire il Vangelo, è avere come primo compagno in paradiso un condannato a morte, il ladro pentito… Questo è l’amore di Dio. Davvero altra cosa dall’eros, impastato di egoismi, di grettezze, degli sbalzi della nostra psicologia, dei nostri umori… Per questo per la Bibbia e per Gesù l’amore, l’agape, non è un sentimento in balia delle circostanze o dei sentimenti, ma un «comandamento», qualcosa a cui rispondere e che si deve costruire: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi». Forse è proprio quel «come» la novità dell’amore cristiano. Siamo chiamati ad amare nella stessa misura di Gesù.
Il vuoto d’amore tra gli uomini sembra farsi più ampio e profondo, proprio mentre i legami di affetto e di amicizia si rivelano più fragili. L’egocentrismo dei singoli e dei gruppi si ispessisce e grava pesante su tutti. Tutti viviamo più soli e al tempo stesso sempre più preoccupati di difendere il nostro personale benessere. I legami di affetto tra gli uomini basati sull’attrazione «naturale» sono labili, basta poco per rovesciarli e distruggerli. È diventato raro legarsi per la vita e difficile sentire i rapporti definitivi e fedeli. L’eros, che ha nella soddisfazione personale più che nella felicità altrui la sua ragione d’essere, non è così forte da resistere alle tempeste e ai problemi della vita. Tante, tantissime sono le vittime che cadono su questo fragile e sdrucciolevole terreno. Solo l’agape è come la roccia salda che ci risparmia dalla distruzione, perché prima dell’io c’è l’altro. Gesù ce ne ha dato l’esempio anzitutto con la sua stessa vita. Può dunque dire ai discepoli: «Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore» (Gv 15, 9).
Il rapporto esistente tra il Padre e il Figlio è posto come modello e fonte dell’amore cristiano. Certo, non può nascere da noi un tale amore; possiamo però riceverlo da Dio; se accolto, ha una forza dirompente: fa crollare i muri, cominciando da quelli che costruiamo per difendere noi stessi, e apre il cuore e la vita verso una fraternità ampia, universale, che non conosce nemici. Genera insomma una nuova comunità di uomini e donne, ove l’amore di Dio si incrocia, quasi sino all’identificazione, con l’amore vicendevole. L’uno infatti è causa dell’altro. Un noto teologo russo amava dire: «Non permettere che la tua anima dimentichi questo motto degli antichi maestri dello spirito: dopo Dio considera ogni uomo come Dio!». Questo tipo di amore è il segno distintivo di chi è generato da Dio. Ma non è proprietà acquisita una volta per tutte, né appartiene di diritto a questo o a quel gruppo. L’amore di Dio non conosce limiti e confini di nessun genere, supera il tempo e lo spazio; infrange ogni barriera dì razza, di cultura, di nazione, persino di fede, come si legge negli Atti degli Apostoli quando lo Spirito riempì anche la casa del pagano Cornelio. L’agape è eterna; tutto passa, persino la fede e la speranza, l’amore resta per sempre, neppure la morte lo infrange, anzi è più forte di essa. A ragione Gesù può concludere: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15, 11).
L’immagine della domenica
«Il nostro vero problema
è che siamo immersi
in un oceano d’amore e non ce ne rendiamo conto»
(G. Vannucci)
Preghiere e racconti
Abitare nella casa dell’amore
Questa è una singolare metafora dell’amore. L’amore non è soltanto un sentimento passeggero. È uno spazio in cui si può rimanere. Gesù, tuttavia, indica anche la condizione per rimanere nell’amore: «Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore» (Gv 15,10). Non possiamo godere da soli dell’amore di Dio. Dobbiamo continuare a farlo scorrere verso gli altri. Altrimenti ristagna. E allora lo spazio d’amore, in cui si può abitare tanto bene, crolla.
L’amore di Gesù non prende, come fa spesso il nostro, ma dà. È puro dono. A un amore del genere, che lascia liberi e si dona, che muore per noi e scorre senza confini per noi, aneliamo nel profondo del nostro cuore.
Di fronte al Cristo crocifisso percepiamo che siamo incapaci di vero amore. Il nostro amore si mescola spesso al desiderio di avere l’altro tutto per noi, di riuscire a possederlo. Vogliamo tenerlo stretto, in modo che non ci lasci mai più. E non ci accorgiamo di come gli togliamo la possibilità di evolversi, di diventare interamente se stesso. Spesso vogliamo essere noi a plasmare la persona amata e comprimerla nella forma che ci sembra amabile. Il gesto della croce esprime il contrario: ci lascia liberi, ci invita a farci abbracciare, ma ci lascia anche andare, affinché possiamo percorrere in libertà il nostro cammino.
(Anselm Grün, Apri il tuo cuore all’amore, Brescia, Queriniana, 2005, 19-20).
La differenza cristiana: amarsi come ama il Signore
Una poesia dolcissima e profonda, ritmata sul lessico degli amanti: amare, amore, gioia, pienezza, frutti… È il canto della nostra fede. Come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Di amore parliamo come di un nostro compito. Ma noi non possiamo far sgorgare amore se non ci viene donato. Siamo letti di fiume che Dio trasforma in sorgenti.
Rimanete nel mio amore. Nell’amore si entra e si dimora. Rimanete, non andatevene, non fuggite dall’amore. Spesso all’amore resistiamo, ci difendiamo. Abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni, ci aspettiamo tradimenti. Ma Gesù ti dice: “arrenditi all’amore”. Se non lo fai, vivrai sempre affamato. Gesù: il guaritore del tuo disamore. Il mondo sembra spesso la casa dell’odio, eppure l’amore c’è, reale come un luogo. È la casa in cui già siamo, come un bimbo nel grembo della madre: non la può vedere, ma ha mille segni della sua presenza: «Il nostro vero problema è che siamo immersi in un oceano d’amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). L’amore è, esiste, circola, ed è cosa da Dio: amore unilaterale, a prescindere, asimmetrico, incondizionato. Questo vi ho detto perché la vostra gioia sia piena. L’amore è da prendere sul serio, il Vangelo è da ascoltare con attenzione, ne va della nostra felicità, che sta in cima ai pensieri di Dio. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Non semplicemente: amate. Ma fatelo in un rapporto di comunione, un faccia a faccia, una reciprocità. E aggiunge la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Amare come Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non giudica nessuno; che mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca degli ultimi. Chiunque ami così, qualsiasi sia il suo credo, è entrato nel flusso dell’amore di Cristo, dimora in lui che si è fatto canale dell’amore del Padre. Come lui ognuno può farsi vena non ostruita, canale non intasato, perché l’amore scenda e circoli nel corpo del mondo. Se ti chiudi, in te e attorno a te qualcosa muore, come quando si chiude una vena nel corpo.
Voi siete miei amici. Non più servi. Amico: parola dolce, musica per il cuore dell’uomo. Un Dio che da signore e re si fa amico, e teneramente appoggia la sua guancia a quella dell’amato. Nell’amicizia non c’è un superiore e un inferiore, ma l’incontro di due libertà che si liberano a vicenda. Perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Quali frutti dà un tralcio innestato su una pianta d’amore? Pace, guarigione, un fervore di vita, liberazione, tenerezza, giustizia: questi nostri frutti continueranno a germogliare sulla terra anche quando noi l’avremo lasciata
(Ermes Ronchi)
La gioia degli amati che amano.
1. Il contesto del brano evangelico è il «libro degli addii» (Gv13-17), a tavola Gesù rivela se stesso e le cose che gli stanno a cuore ai «suoi», un vero lascito testamentario non solo ai presenti a quella cena ma agli amici di ogni luogo e di ogni tempo resi contemporanei al suo racconto tramite la «lectio», la lettura-ascolto. Contemporanei a un Tu che ci svela al contempo il suo nome e il suo compito, il nostro nome e il nostro compito e il nome di chi è all’origine del tutto.
2. La narrazione inizia con un Gesù che si presenta in questi termini: io mi chiamo «amato dal Padre» (Gv 15,9), il quale a sua volta si chiama amore: «Dio è amore» (1Gv 4,18). Gesù comunica ciò che sa, introduce i suoi a segreti uditi dal Padre stesso (Gv 15,15), il segreto dell’ «incipit»: in principio vi è un Tu che ama, un Amante dal cui grembo è stato generato l’Amato, nome proprio di Gesù, inviato ad amare come amato, compito proprio di Gesù (Gv 15,9). Vi è dunque l’Amore all’origine di Gesù e alla intelligenza di sé come amato, un Amore a lui imperativo categorico: la fedeltà alla propria verità di amato inviato a travasare l’amore che lo ha generato, il solo in grado di generare figli e non schiavi, amici e non nemici. Gesù, a questa consapevolezza di sé di essere il sacramento storico, visibile e tangibile, di Dio amante dell’uomo, è «Si»: «Rimango nel suo amore» e il suo comando rimane in me (Gv 15,10). La mente è aperta a conoscenze inedite precluse all’indagine razionale e al calcolo scientifico, un sapere frutto di discorsi a tavola di un certo Gesù: in principio vi è un Amante, detto Padre, che in forza dell’Amore, detto Spirito, genera l’Amato, detto Figlio, l’inviato a inondare di amore sia il mondo: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito» (Gv 3,16), che i suoi non a caso definiti discepoli amati: «Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi» (Gv 15,9). Come? Con un amore elettivo: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 15,16); oblativo: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13); esigente: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi» (Gv 15,13),: «Questo vi comando: che riamiate gli uni gli altri» (Gv 15,17). Un amore infine amico: «Vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15), e «Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando» Gv15,14).
3. Chi è il discepolo? Un incontrato e un invitato a tavola da un amico di nome Gesù che ha deciso di raccontargli «cose nascoste fin dalla fondazione del mondo» (Mt 13,35). Dio è amore e fonte sorgiva di ogni amore, Gesù è l’amato inviato a raccontare in parole e gesti l’amore di Dio per ogni creatura, il discepolo è l’amato da Dio in Gesù mandato ad amare come amato da Dio in Gesù. Ove al «Rimanete nel mio amore» (Gv 15,9) si risponde si lì è dato al discepolo, e in lui a ogni uomo, di conoscere finalmente il proprio ineffabile nome, il proprio ineffabile compito e il proprio ineffabile approdo: amati per amare per sempre facendo dell’amore il perno da cui tutto muove e a cui tutto rimanda. Visione urgente a livello personale, comunitario, ecclesiale e sociale nella lucida consapevolezza che «al di fuori dell’amore non c’è salvezza». E non c’è gioia: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11). La gioia degli amati che amano.
(Giancarlo Bruni)
Rimanete nel mio amore
«Rimanete nel mio amore» (Gv 15,10). In che modo ci rimarremo? Ascolta quanto segue: «Se osservate i miei comandamenti», dice il Signore, «rimarrete nel mio amore» (ibi). È l’amore che ci fa osservare i comandamenti, oppure è l’osservare i comandamenti che fa nascere l’amore? Ma chi può mettere in dubbio che l’amore precede l’osservare i comandamenti? Chi non ama non ha motivo di osservare i comandamenti. Dicendo: «Se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore», il Signore non vuole indicare l’origine dell’amore, ma la prova. Come se dicesse: Non crediate di poter rimanere nel mio amore se non osservate i miei comandamenti; potrete rimanervi solo se li osserverete. Questa sarà la prova che rimanete nel mio amore, se osserverete i miei comandamenti. Nessuno quindi si illuda di amare il Signore, se non osserva i suoi comandamenti, perché lo amiamo in quanto osserviamo i suoi comandamenti, e quanto meno li osserviamo tanto meno lo amiamo. Anche se dalle parole: «Rimanete nel mio amore» non appare chiaro di quale amore egli stia parlando, se di quello con cui amiamo lui o di quello con cui egli ama noi, possiamo però dedurlo dalla frase precedente. Egli aveva detto: «Anch’io ho amato voi», e subito dopo ha aggiunto: «Rimanete nel mio amore». Si tratta dunque dell’amore che egli nutre per noi. E allora che cosa significa: «Rimanete nel mio amore», se non: rimanete nella mia grazia? E che cosa significa: «Se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore», se non che voi potete avere la certezza di essere nel mio amore, cioè nell’amore che io vi porto, se osserverete i miei comandamenti? Non siamo dunque noi che prima osserviamo i comandamenti di modo che egli venga ad amarci, ma il contrario: se egli non ci amasse, noi non potremmo osservare i suoi comandamenti. Questa è la grazia che è stata rivelata agli umili, mentre è rimasta nascosta ai superbi.
(AGOSTINO DI IPPONA, Commento al vangelo di Giovanni 82,3, NBA XXIV, p. 1248).
Credo
Credo in un Dio che non si nasconde dentro ad un mistero
che non mi seduce con un miracolo
e che non mi opprime con la sua autorità.
Credo in un Dio che non mi chiede di rinunciare alla mia libertà,
che mi pone di fronte alla scelta del bene e del male,
che non accetta compromessi,
ma che benedice la follia di chi lo segue.
Credo in un Dio che non fa della sua potenza persuasione,
che non rimette a posto le cose dall’alto,
che non esercita la giustizia degli uomini.
Credo in un Dio che si lascia tradire,
che al mio no risponde con un bacio silenzioso,
credo in un Dio sconfitto, crocifisso e poi Risorto.
Credo in un Dio che non ho inventato io,
che non soddisfa i miei bisogni,
che non dice e fa quello che voglio io,
un Dio scomodo che non si può né vendere, né comprare.
Credo in un Dio vero,
che si fa uomo, amico, fratello della mia umanità,
che si fa piccolo, debole indifeso
perché non debba salire troppo in alto per poterlo incontrare.
Credo in un Dio che gioca a nascondino
perché possa scoprirlo nel cuore di ogni uomo,
credo in un Dio che mi si fa vicino,
che mi viene incontro e mi dice : “ti amo”.
Si, io credo in Dio, in un Dio che si può soltanto amare.
(Ester Battista).
Da’ gratuitamente
«Il tuo amore, in quanto viene da Dio, è permanente. Puoi reclamare il carattere permanente del tuo amore come un dono di Dio. E puoi dare questo amore permanente agli altri. Quando gli altri cessano di amarti, non devi cessare di amarli. A livello umano, i cambiamenti possono essere necessari, ma a livello del divino tu puoi rimanere fedele al tuo amore.
Un giorno sarai libero di dare un amore gratuito, un amore che non chiede niente in cambio. Un giorno sarai anche libero di ricevere un amore gratuito. Spesso l’amore ti viene offerto, ma tu non lo riconosci. Lo metti da parte perché rimani fissato nell’idea di riceverlo dalla medesima persona alla quale l’hai dato.
Il grande paradosso dell’amore è che proprio quando hai rivendicato il fatto che sei il diletto figlio di Dio, hai posto dei confini al tuo amore, e quindi hai contenuto i tuoi bisogni, è allora che cominci a crescere nella libertà di dare gratuitamente».
(H.J.M. NOUWEN, La voce dell’amore, Queriniana, Brescia. 2005, 27-28).
L’amore
Noi delle strade siamo certissimi di poter amare Dio sin quando avrà voglia di essere amato da noi. Non pensiamo che l’amore sia una cosa che brilla, ma una cosa che consuma; pensiamo che fare tutte le piccole cose per Dio ce lo fa amare altrettanto che il compiere grandi azioni. D’altra parte pensiamo di essere molto male informati sulla misura dei nostri atti. Non sappiamo che due cose: la prima, che tutto quello che facciamo non può essere che piccolo; la seconda, che tutto ciò che fa Dio è grande. Questo ci rende tranquilli di fronte all’azione. Sappiamo che ogni nostro lavoro consiste nel non gesticolare sotto la grazia, nel non scegliere le cose da fare, e che Dio agirà per nostro mezzo. Non c’è niente di difficile per Dio, e chi teme la difficoltà si crede capace di agire. Poiché troviamo nell’amore un’occupazione sufficiente, non abbiamo cercato il tempo per classificare gli atti in preghiere e in azioni. Troviamo che la preghiera è un’azione e l’azione una preghiera; ci sembra che l’azione veramente amorosa è tutta piena di luce. Ci sembra che di fronte ad essa l’anima è come una notte tutta protesa verso la luce che sta per venire. E quando la luce si fa – il volere di Dio chiaramente compreso – ecco l’anima viverla con dolcezza piena, con pacatezza piena, guardando Dio animarsi e agire in essa. Ci sembra che l’azione sia anche una preghiera d’implorazione. Non ci sembra che l’azione c’inchiodi nel nostro terreno di lavoro, di apostolato o di vita. Al contrario, ci sembra che l’azione perfettamente compiuta là dove ci viene reclamata innesta noi in tutta la Chiesa, ci diffonde in tutto il suo corpo, ci fa disponibili in essa. I nostri passi camminano in una strada, ma il nostro cuore batte nel mondo intero. E’ per questo che i nostri piccoli atti, nei quali non sappiamo distinguere fra azione e preghiera, uniscono così perfettamente l’amore di Dio e l’amore dei nostri fratelli. Il fatto di abbandonarci alla volontà di Dio ci consegna nello stesso istante alla Chiesa che da questa volontà medesima è resa costantemente salvatrice e madre di grazia. Ciascun atto docile ci fa ricevere pienamente Dio e dare pienamente Dio in una grande libertà di spirito. Allora la vita è una festa. Ogni piccola azione è un avvenimento immenso nel quale ci viene dato il paradiso, nel quale possiamo dare il paradiso. Non importa che cosa dobbiamo fare: tenere in mano una scopa o una penna stilografica. Parlare o tacere, rammendare o fare una conferenza, curare un malato o battere a macchina. Tutto ciò non è che la scorza della realtà splendida, l’incontro dell’anima con Dio rinnovata ad ogni minuto, che ad ogni minuto si accresce in grazia, sempre più bella per il suo Dio. Suonano? Presto, andiamo ad aprire: è Dio che viene ad amarci. Un’informazione? …eccola: è Dio che viene ad amarci. E’ l’ora di metterci a tavola? Andiamoci: è Dio che viene ad amarci. Lasciamolo fare.
(Madeleine Delbrêl).
Parlami d’Amore
Amore supera l’amore, mio caro. L’amore è volo d’uccello nel cielo infinito. Ma il volo dell’uccello è più che il volteggiare in aria di un esserino di carne, più che le sue ali innamorate, corteggiate dal vento, è più che l’indicibile gioia quando muoiono i battiti delle ali e il corpo in pace plana nella luce. L’amore è canto di violino che canta il canto del mondo. Ma il canto del violino è più che il legno e l’archetto, inerti e solitari, più che le note in abito da sera che danzano sulla partitura, e più che le dita dell’artista che corrono sulle corde. L’amore è luce, per le strade umane. Ma la luce che si dà è più che carezza mattutina che apre gli occhi notturni, più che raggi di fuoco che riscaldano i corpi, e più che mille pennelli d seta che colorano i volti. L’amore è fiume d’argento che scorre verso il mare. Ma il fiume vivo, che indugia o che si affretta, è più che il suo letto accogliente, scrigno che non trattiene, più che l’acqua che si arrossa allo sguardo del tramonto, e più che l’uomo sulla riva che getta l’esca e ne estrae i frutti. L’amore è veliero che sulle acque fende le onde. Ma la corsa del veliero è più che la prora sedotta che penetra il mare, che si offre o i dibatte, più che le vele frementi sotto il tocco della brezza o gli schiaffi del vento, è più che le mani del marinaio afferrate al timone, mentre instancabile insegue la sua selvaggina. …l’Amore supera l’amore. L’Amore è soffio infinito, che viene da un altrove e vola verso l’altrove. L’amore è mente d’uomo che conosce e riconosce il soffio, è libertà d’uomo che tutto si volge verso di Lui. L’amore è consenso dell’uomo al soffio che invita, è cuore dell’uomo che si apre per accoglierlo e donarLo, è corpo dell’uomo che si raccoglie, disponibile, perché da Lui abitato, da Lui invaso prenda il volo verso gli altri, verso… l’altro, e perché infine ciò che era lontano si ricongiunga e si accordi ciò che era separato diventi uno e che dall’uno sgorghi una nuova vita.
(Michel Quoist).
La mia vocazione
Nell’eccesso della mia gioia delirante ho esclamato: O Gesù mio Amore… la mia vocazione l’ho trovata finalmente! La mia vocazione è l’Amore.
( Santa Teresa di Gesù Bambino).
Una luce splende alla mia anima
Che ti amo Signore, non ho alcun dubbio; ne sono certo.
Con la tua parola hai toccato il mio cuore, e io ho cominciato ad amarti.
Ma che cosa amo amandoti?
Non una bellezza corporea né una grazia transitoria;
non lo splendore di una luce così cara a questi miei occhi;
non dolci melodie di svariate cantilene;
non un profumo di fiori, di unguenti e di aromi;
non manna né miele, non membra invitanti ad amplessi carnali.
Amando il mio Dio, non amo queste cose.
E tuttavia nell’amare lui amo una certa luce,
una voce, un profumo, un cibo ed un amplesso
che sono la luce, la voce, il profumo,
l’amplesso dell’uomo interiore che è in me, dove splende alla mia anima una luce
che nessun fluire di secoli può portar via,
dove si espande un profumo che nessuna ventata può disperdere,
dove si gusta un sapore che nessuna voracità può sminuire,
dove si intreccia un rapporto che nessuna sazietà può spezzare.
Tutto questo io amo quando amo il mio Dio.
(S. Agostino)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
—
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Anno B, Milano, Vita e Pensiero, 2008.
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia, Milano, Vita e Pensiero, 2011.
– H.J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
—
– Immagine della domenica, a cura di García-Orsini-Pennesi.
PER L’APPROFONDIMENTO: