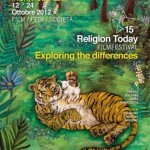Prima lettura: Sapienza 2,12.17-20
|
«Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo e si oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà».
|
Presentazione generale:
a) Il contesto – I capp. 1-5 del libro della Sapienza presentano la figura del «sapiente» e dello «stolto» (chiamati anche «giusto» e «empio»): chi sono, cosa fanno, come concepiscono la vita; quali valori privilegiano, a quali cose e persone danno il primato. Nella tradizione biblica «giusto» (o «sapiente») è l’uomo che sa riferire tutto a Dio e sa leggere la storia, gli avvenimenti, la stessa vita di ogni giorno alla luce della dimensione religiosa e nell’atteggiamento di chi sa accogliere ogni cosa come dono del suo Signore. «Empio» o «stolto» è l’uomo che pone al centro del suo vivere se stesso, le cose, il successo. È l’uomo incapace di cogliere la presenza di Dio nel suo mondo e nella sua vita. L’empio, comunque, non è l’ateo, nel senso che noi oggi diamo a questo termine. La Bibbia non conosce la figura moderna dell’ateo, ma solo l’uomo che di fronte al male, al dolore o a qualsiasi altro elemento che provoca differenza e disagio, si interroga sulla certezza della presenza di Dio «qui» e «adesso», proprio come fanno gli «empi» di questa lettura (cf. Sal 13,1: «Lo stolto pensa: ‘Non c’è Dio’»).
b) Il tema – È il contrasto tra la concezione del vivere propria degli empi e quella dei giusti. In questo contrasto vengono evidenziate le reazioni degli empi nei confronti di quanti vivono alla luce della Parola di Dio e dei valori che ad essa si ispirano. Questo testo è stato applicato alla Passione di Gesù e alla sua vita apparentemente abbandonata da Dio sulla croce. Gli evangelisti pongono sulle labbra di coloro che assistono alla sua crocifissione le ultime parole di questo brano («Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuole bene», cf. Mt 27,43). In Gesù, giusto per eccellenza, si rivela non l’abbandono di Dio, ma il suo amore e la sua vicinanza all’uomo. Dalle sue sofferenze e dalla sua croce, infatti, ha origine la salvezza degli uomini. Per la chiesa primitiva il nostro brano (come pure il Sal 21,9 che contiene le medesime espressioni) sono stati considerati profezie riguardanti Gesù, il Giusto consegnato nelle mani degli empi e morto per la nostra salvezza.
Annotazioni
— v. 17: «Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo… ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta»; queste parole vanno collocate nel contesto generale del libro della Sapienza, che contiene una forte critica nei confronti degli Israeliti che avevano rinnegato la loro formazione religiosa ed erano passati alla cultura ellenistica. Dall’ellenismo (introdotto in Oriente da Alessandro Magno, nel 333 a.C.) avevano accettato anche le mode e le abitudini (palestre, teatri, spettacoli, terme ecc.) e anche l’invito a non farsi più circoncidere. Quest’ultimo elemento era da sempre considerato caratteristico della formazione e della religiosità ebraiche.
— v. 19: «Mettiamolo alla prova… per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione»: questi verbi che si riferiscono alla «tentazione» — e che la Bibbia ama attribuire a Dio — sono qui attribuiti agli empi, i quali si propongono non di rafforzare la fede e la fiducia dei giusti (secondo il significato che la Bibbia dà alla tentazione), ma di farli deviare dalla via del bene e di scoraggiarli dal compiere ogni cosa secondo Dio e nella fedeltà alla sua Parola.
Seconda lettura: Giacomo 3,16-4,3
|
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni.
|
Presentazione generale:
La Lettera di Giacomo comprende una serie di esortazioni senza un ordine logico, che si ispirano all’idea fondamentale di un’esistenza cristiana da vivere nella fedeltà al vangelo, nella carità e nella solidarietà (a questo si rifanno le severe espressioni che la Lettera usa contro i ricchi, incapaci di solidarietà e chiusi alle necessità del prossimo bisognoso). Una vita così vissuta esprime anche la ricchezza interiore dell’uomo che, opponendosi ai vizi, alle passioni cattive e alle suggestioni del potere e del denaro, manifesta padronanza di sé e fedeltà al progetto di Dio sull’uomo e sulla creazione. Il nostro brano comprende due temi: a) la qualità della vera sapienza, quella che conduce a vivere secondo il progetto di Dio (Gc 3,13-18); b) la riflessione sulle cause delle ostilità nel cuore dell’uomo e nel mondo e i loro rimedi (Gc 4,1-12).
Annotazioni
— v. 16: «C’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni»: queste espressioni fanno parte del cosiddetto «catalogo dei vizi» che spesso la predicazione degli apostoli richiamava per mettere in guardia chi non accoglieva l’invito del vangelo a convertirsi dalle opere cattive e a vivere con attenzione e impegno (cf. 2Cor 12,20).
— v. 17: «La sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera»: questa descrizione della «vera» sapienza si ispira alla concezione che di essa hanno i Sinottici e Paolo (cf. Gal 5,22-23). In particolare è da sottolineare l’affinità di questi termini con il resto delle Beatitudini (Mt 5,1 ss), un testo che nell’evangelista Matteo diventa il programma di vita del cristiano. Vivere secondo questo programma è anche per Giacomo un segno della vera sapienza cristiana che vede, giudica, illumina tutto alla luce del vangelo e della persona di Gesù. Anche l’espressione «buoni frutti» richiama il Vangelo (cf. Mt 7.16-20): «Dai loro frutti li riconoscerete») 4,1: «Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? »: alla ricerca dei rimedi da contrapporre ai mali dell’uomo (guerre, liti, contese), Giacomo propone atteggiamenti e comportamenti che, sanando l’interno dell’uomo («il cuore») hanno poi la capacità di influire positivamente anche sul mondo esteriore. Per questo sono importanti il dominio delle passioni, la forza della preghiera e l’attenzione a vivere secondo le virtù che caratterizzano e distinguono il cristiano (vv. 2-3).
Vangelo: Marco 9,30-37
|
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».
|
Esegesi
Presentazione generale:
a) Il contesto – È quello che caratterizza la seconda parte del vangelo di Marco. Secondo lo schema di questo evangelista, la prima parte contiene il racconto dei miracoli di Gesù (cc. 1-8) per orientare il lettore alla comprensione della sua identità di Messia e Figlio di Dio (come farà Pietro in 8,27-29, che è «il centro» del vangelo di Marco). La seconda parte (cc. 9-16) è tutta impostata sulle esigenze radicali che Gesù chiede ai discepoli e ai cristiani di ogni tempo che lo vogliono seguire. Con il nostro brano ha inizio la descrizione di queste esigenze. Esse vengono collocate in questa seconda sezione perché solo chi ha riconosciuto
la vera identità di Gesù (in tutto obbediente al Padre fino ad accettare la croce) sa anche accettare il suo destino di morte e di risurrezione.
b) Il tema – È la presentazione della missione di Gesù alla luce del progetto di salvezza di Dio (che passa attraverso la croce e la morte) e la richiesta al discepolo di ogni tempo di partecipare a questo progetto nella totale obbedienza che ha caratterizzato Gesù.
Annotazioni
— v. 30: «Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse»: questa frase è da collocare nel contesto del cosiddetto «segreto messianico»: Gesù cioè vuole essere riconosciuto come Messia e Figlio di Dio non nell’esteriorità dei miracoli (che aveva finora compiuti in Galilea), ma nella obbedienza a Dio che lo consegna alla croce e alla morte.
— v. 31: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini»: «Figlio dell’uomo» è uno dei titoli messianici di Gesù, che si ispira a Dan 7,14 (testo ritenuto messianico nell’interpretazione biblica) e al profeta Ezechiele (che inizia sempre i suoi oracoli con l’espressione «Figlio dell’uomo», tuttavia senza significato messianico, ma con il significato comune di «uomo»).
Il verbo «consegnare» è molto ricco teologicamente. Esso indica il progetto che Dio ha pensato per gli uomini: per la loro salvezza Dio «consegna» Gesù nelle loro mani. Gesù, infatti, non è stato tradito («tradire» è un secondo significato dello stesso verbo paradìdomi, che traduciamo con «consegnare») solo da Giuda o dagli Anziani, ma è stato «consegnato» a morte da Dio stesso. Gesù non è stato ucciso (nel senso teologico) dai contemporanei (anche se storicamente essi hanno preso parte al consumarsi di questa morte), ma dalle «mani» di ogni uomo (= dai suoi peccati) alle quali Dio ha «consegnato» Gesù.
— v. 34: «Avevano discusso tra loro chi fosse più grande»: i discepoli si aspettavano da un momento all’altro che Gesù inaugurasse il Regno messianico (che essi vedevano erroneamente anticipato dai miracoli da Lui compiuti), nel quale pensavano di essere favoriti con un posto di particolare prestigio.
— v. 35: «Sedutosi… preso un bambino… chi accoglie uno solo di questi bambini»: il verbo «sedersi» indicava l’attività di insegnamento del maestro o del rabbino. Il verbo da anche l’idea della profondità e della gravità degli insegnamenti che Gesù sta per dare ai discepoli («essere l’ultimo… essere il servo di tutti»).
«Bambini» e «piccoli» nel vangelo (oltre al loro proprio significato letterale) indicano anche i membri più deboli della comunità cristiana, le persone più dimenticate e per le quali nessuno ha uno sguardo o un’attenzione particolare. Di esse deve farsi carico il discepolo di Gesù, come Lui si è fatto carico dell’umanità debole e fragile sotto il dominio del peccato.
Meditazione
C’è un’immagine, nel racconto di Marco, che ritorna spesso e che ritma un po’ tutta la narrazione: è l’immagine della via, immagine allo stesso tempo reale e simbolica. È la strada che conduce a Gerusalemme e che Gesù percorre con i suoi discepoli, ma è anche il simbolo dell’itinerario che ogni discepolo deve compiere nella misura in cui sceglie di seguire Gesù. Lungo la via il discepolo impara a posare la pianta dei suoi piedi nell’orma che Gesù lascia; lungo la via il discepolo impara a conoscere il volto di Gesù, il segreto del suo cammino, la meta a cui tende tutta la sua vita; lungo la via il discepolo scopre anche la sua debolezza, la sua incapacità a seguire il Signore Gesù, la sua durezza di cuore, la sua cecità; lungo la via, infine, il discepolo comprende che solo riconoscendo la sua povertà può avere la grazia della sequela, il dono di scoprire che è sempre Gesù a camminare avanti, mentre egli può solo e sempre stare dietro.
Nella pericope del racconto di Marco proposta in questa domenica, lungo la via ascoltiamo ora una parola di Gesù che il discepolo ha già udito (cfr. Mc 8,31), ma che al suo orecchio appare sempre dura, addirittura estranea: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà» (9,31). Consegnare, uccidere, risorgere: tre verbi che offrono la sequenza di una storia drammatica e paradossale, inaudita, la vicenda ‘pasquale’ di Gesù. Una vicenda già contenuta in filigrana nella storia dei profeti, di coloro che Dio invia per comunicare la sua parola di giudizio e di salvezza sulla storia degli uomini. La storia del profeta, del giusto, è sempre una storia drammatica, contraddittoria e violenta, e in questi termini la rilegge il libro della Sapienza (cfr. la prima lettura). «Tendiamo insidie al giusto… mettiamolo alla prova con violenze… condanniamolo ad una morte infamante» (Sap 2,12.17-20): è questa la risposta degli empi a una parola di Dio, comunicata dal profeta, una parola che suona come accusa a una logica di ingiustizia e di violenza (quella logica condannata in Gc 3,16-4,3). Il profeta diventa segno di contraddizione, odiosa pietra di scandalo («per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni»: 2,12) per un sistema sociale e religioso basato sulla ipocrisia, ma nascosto dietro una apparente legalità. Ecco perché la sua parola deve essere neutralizzata dimostrandone l’inefficacia ridicola e malefica, o più semplicemente deve essere eliminato.
Ma tra i tre verbi che caratterizzano la vicenda del ‘profeta’ Gesù, uno in particolare offre una luce per raggiungere il cuore di avvenimenti di per sé incomprensibili. Si tratta del verbo consegnare («viene consegnato nelle mani…»: paradidotai eis cheiras), un verbo che domina tutta la via crucis del Figlio dell’uomo: Giuda, il discepolo che lo tradisce, lo consegna ai soldati; i soldati ai capi del popolo; i capi del popolo a Pilato e questi ai crocefissori. Ma il paradosso è che il Padre stesso consegna il Figlio alla morte e in questa morte è Dio stesso a consegnarsi all’uomo, a donarsi, a offrire per l’uomo la sua stessa vita.
Consegnare, uccidere, risorgere: tre verbi oscuri per il discepolo che insegue i suoi pensieri, che cerca un volto di Gesù molto diverso da quello che lui ora gli sta presentando. Il discepolo non comprende questa logica che gli pare assurda. Ma pur non comprendendo, ha paura di domandare: «…non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo» (Mc 9,32). È veramente paradossale questa reazione. Chi non capisce, chiede. E perché il discepolo non osa chiedere? Forse perché ha paura della risposta: o meglio, ha paura di un confronto con la parola di Gesù. Il discepolo preferisce nascondersi dietro le proprie molte parole, le quali offrono cammini più facili, indicano desideri più gratificanti, immediati: «Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande» (9,34).
Lungo la strada allora Gesù fa fare una sosta al discepolo, ponendo anzitutto una domanda, che però resta senza risposta: «Di che cosa stavate discutendo lungo la strada?» (9,33). Sembra quasi che di fronte a Gesù il discepolo non sappia usare la parola. Ed è veramente così: il discepolo non sa usare la parola, resta muto, perché non ha ascoltato la Parola, quella parola che è il cammino di Gesù, quella parola dura che è la croce. Solo Gesù può dare una risposta alle molte parole e ai silenzi del discepolo. E la sua risposta è sconcertante e vera allo stesso tempo. Essa ha come due momenti, due angolature attraverso cui si può rileggere la vicenda di Gesù, ma che diventano anche altrettante scelte concrete per il discepolo. «Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti» (9,35). Gesù prende sul serio il desiderio del discepolo, essere il primo, cioè realizzarsi pienamente, poter emergere nella vita. Ma la risposta che Gesù offre è sconcertante: inverte quella strada che il discepolo credeva di poter percorrere per essere il più grande. Per Gesù essere il più grande non è porsi sull’altro, prevalere sull’altro, cercare tutto ciò che è primo; essere grandi è stare ai piedi dell’altro, essere per l’altro dono, consegnarsi all’altro perché esso possa vivere. In una parola, il discepolo deve capire che c’è una sola via che realizza pienamente il desiderio più vero di vita che abita in lui: è proprio quella via da cui il discepolo ha distolto lo sguardo, la via di Gesù, «il quale da ricco che era si fece povero… che non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso…» (cfr. 2Cor 8,9; Fil 2,6.7); la via dell’umiltà, la via del servizio, la via del dono.
Ma c’è un passo ulteriore, un salto di qualità che Gesù fa compiere al discepolo. «E preso un bambino lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: “Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie… colui che mi ha mandato”» (9,36-37). Questo gesto di Gesù, pieno di compassione e di tenerezza, libera il discepolo da un’ultima tentazione. Essere all’ultimo posto, essere il servo di tutti, significa essere liberati dalla tentazione del potere. Ma il discepolo può ancora essere attratto dalla pretesa di essere sempre lui quello che deve fare o deve dare agli altri. Scoprire che al centro non c’è tanto il suo servizio all’altro, ma l’altro come persona, anzi il piccolo, l’ultimo come un dono da accogliere, significa essere veramente liberi e poveri. Chi veramente dona, chi si fa ultimo, chi si fa nostro servo è il Signore Gesù: è lui il piccolo che sta in mezzo a noi come servo, è lui che ci dona tutto rivelandoci il volto misericordioso del Padre. Di fronte al piccolo, qualunque esso sia, non possiamo fare altro che aprire le nostre mani per ricevere il dono della compassione del Padre, nel volto di Gesù.
Preghiere e racconti
In mitezza e umiltà
«Essi però non comprendevano quelle parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni» (Mc 9,32). Tale ignoranza da parte dei discepoli non nasce tanto dalla limitatezza della loro mente, quanto dall’amore che essi nutrivano per il Salvatore. Questi uomini che vive-vano ancora secondo la carne ed erano ignari del mistero della croce, si rifiutavano di credere che colui che essi avevano riconosciuto quale Dio vero sarebbe morto ed essendo abituati a sentirlo parlare in parabole, poiché inorridivano alla sola idea della sua morte, cercavano di attribuire un senso figurato anche a quello che diceva apertamente a proposito della sua cattura e della sua passione. «E giunsero a Cafarnao. Entrati in casa chiese loro: “Di che cosa stavate discutendo lungo la via?”. Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande» (Mc 9,33-34). Sembra che la discussione tra i discepoli a proposito del primo posto fosse nata perché avevano visto che Pietro, Giacomo e Giovanni erano stati condotti in disparte sul monte e che qui era stato affidato loro qualcosa di segreto. Ma già da prima erano convinti, come racconta Matteo (cfr. Mt 16,18-19), che a Pietro erano state date le chiavi del Regno dei cieli, e che la chiesa del Signore doveva essere edificata sulla pietra della fede, dalla quale egli stesso aveva ricevuto il nome. Ne concludevano o che quei tre apostoli dovevano essere superiori agli altri o che Pietro era superiore a tutti. Il Signore, vedendo i pensieri dei discepoli, cerca di correggere il loro desiderio di gloria col freno dell’umiltà e fa loro intendere che non si deve cercare di essere primi; così, dapprima li esorta con il semplice comandamento dell’umiltà e, subito dopo, li ammaestra con l’esempio dell’innocenza del bambino. Dicendo infatti: «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me» (Mc 9,37) […] li esorta, a motivo della loro malizia, a essere anche loro come bambini, cioè a conservare la semplicità senza arroganza, la carità senza invidia e la devozione senza ira. Prendendo poi in braccio il bambino, indica che sono degni del suo abbraccio e del suo amore gli umili e che, quando avranno messo in pratica il suo comandamento: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29), solo allora potranno gloriarsi.
(BEDA IL VENERABILE, Commento al vangelo di Marco, CCL 120.n. 551).
Soprattutto un viaggio di ricerca
“Io sono un navigatore e un viaggiatore, e ogni giorno scopro una nuova regione della mia anima” … Queste semplici ma straordinariamente parole di Kahil Gibran (Sabbia e onda) possono ben attagliarsi al tema di queste pagine, poiché pongono in rilievo un fatto fondamentale: l’uomo scopre nel mondo solo quello che ha già dentro di sé.
Il viaggio deve essere soprattutto uno strumento di approfondimento interiore, un mezzo per andare oltre le secche della quotidianità e far sì che l’anima respiri nuova aria, si alimenti con nuove energie spirituali. Viaggiare è conoscere, ma è anche conferma della conoscenza acquisita e anche un modo per essere nella storia, senza distorsioni, linearmente, forse partendo dalle origini.
(Massimo CENTINI, Il cammino di Santiago, Xenia, Milano, 2009, 10-11).
Collaboratori della gioia di tutti
Chiamato a servire, nell’impegno di ogni giorno, nella specificità dei servizi d’amore cui Dio lo chiama, il cristiano non deve mai perdersi d’animo, né cedere alla tentazione della disperazione e dello scetticismo. Il segreto che gli permette di mantenere intatta la sua capacità di leggere giorno dopo giorno i segni della salvezza di Dio, che è all’opera, sta nell’incontro fedele e perseverante con Cristo, sorgente di vera gioia.
Questa gioia dell’incontro col Signore accompagna la vita del cristiano: anche nella prova e nella persecuzione i discepoli restano “pieni di gioia e di Spirito Santo” (Atti 13,52). La gioia è un frutto dello Spirito, conseguenza del dimorare in Dio nella preghiera e nella celebrazione del suo amore per noi, sperimentato nella fede e nella speranza: “Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1Tessalonicesi 5,16-18). La gioia si coniuga così alla carità, vissuta nel portare con Cristo il peso della sofferenza propria e altrui.
Servire è farsi collaboratori della gioia di tutti: “Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della vostra gioia” (2Corinzi 1,24).
(Bruno FORTE, Lettera ai cercatori di Dio, EDB, Bologna, 2009, 71).
Rinascere dalle ceneri del tuo dolore
Non biasimare altri per la tua sorte, perché tu e soltanto tu hai preso la decisione di vivere la vita che volevi. La vita non ti appartiene, e se, per qualche ragione, ti sfida, non dimenticare che il dolore e la sofferenza sono la base della crescita spirituale. Il vero successo, per gli uomini, inizia dagli errori e dalle esperienze del passato. Le circostanze in cui ti trovi possono essere a tuo favore o contro, ma è il tuo atteggiamento verso ciò che ti capita quello che ti darà la forza di essere chiunque tu voglia essere, se comprendi la lezione. Impara a trasformare una situazione difficile in un’arma a tuo favore. Non sentirti sopraffatto dalla pena per la tua salute o per le situazioni in cui ti getta la vita: queste non sono altro che sfide, ed è il tuo atteggiamento verso queste sfide che fa la differenza. Impara a rinascere ancora una volta dalle ceneri del tuo dolore, a essere superiore al più grande degli ostacoli in cui tu possa mai imbatterti per gli scherzi del destino. Dentro di te c’è un essere capace di ogni cosa. Guardati allo specchio. Riconosci il tuo coraggio e i tuoi sogni, e non asserragliarti dietro alle tue debolezze per giustificare le tue sfortune. Se impari a conoscerti, se alla fine hai imparato chi tu sei veramente, diventerai libero e forte, e non sarai mai più un burattino nelle mani di altri. Tu sei il tuo destino, e nessuno può cambiarlo, se tu non lo consenti. Lascia che il tuo spirito si risvegli, cammina, lotta, prendi delle decisioni, e raggiungerai le mete che ti sei prefissato in vita tua. Sei parte della forza della vita stessa. Perché quando nella tua esistenza c’è una ragione per andare avanti, le difficoltà che la vita ti pone possono essere oggetto di conquista personale, non importa quali esse siano. Ricordati queste parole: “Lo scopo della fede è l’amore, lo scopo dell’amore è il servizio”.
(Sergio BAMBARÉN, La musica del silenzio, Sperling & Kupfer, 2006, 114-116).
Preghiera per il servizio
Signore,
mettici al servizio dei nostri fratelli
che vivono e muoiono nella povertà
e nella fame di tutto il mondo.
Affidali a noi oggi;
dà loro il pane quotidiano
insieme al nostro amore pieno di comprensione, di pace, di gioia.
Signore,
fa di me uno strumento della tua pace,
affinché io possa portare l’amore dove c’è l’odio,
lo spirito del perdono dove c’è l’ingiustizia,
l’armonia dove c’è la discordia,
la verità dove c’è l’errore,
la fede dove c’è il dubbio,
la speranza dove c’è la disperazione,
la luce dove ci sono ombre,
e la gioia dove c’è la tristezza.
Signore,
fa che io cerchi di confortare e di non essere confortata,
di capire, e non di essere capita,
e di amare e non di essere amata,
perché dimenticando se stessi ci si ritrova,
perdonando si viene perdonati
e morendo ci si risveglia alla vita eterna.
(Madre Teresa di Calcutta)
Rendici umili servi di tutti!
Signore Gesù, come Giacomo e Giovanni anche noi spesso «vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiediamo». Non siamo infatti migliori dei due discepoli. Come loro abbiamo però ascoltato il tuo insegnamento e vorremmo ricevere da te la forza per attuarlo; quella forza che ha poi condotto i figli di Zebedeo a testimoniarti con la vita.
Gesù, aiutaci a comprendere l’amore che ti ha spinto a bere il calice della sofferenza al nostro posto, a immergerti nei flutti del dolore e della morte per strappare dalla morte eterna noi, peccatori. Aiutaci a contemplare nel tuo estremo abbassamento l’umiltà di Dio. Liberaci dalla stolta presunzione di asservire gli altri a noi stessi e infondici nel cuore la carità vera, che ci farà lieti di servire ogni fratello con il dono della nostra vita
Mite Servo sofferente, che con il tuo sacrificio di espiazione sei divenuto il vero sommo sacerdote misericordioso, tu ben conosci le infermità del nostro spirito e le pesanti catene dei nostri peccati: tu che per noi hai versato il tuo sangue, purificaci da ogni colpa. Tu che ora siedi alla destra del Padre, rendici umili servi di tutti!
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006- .
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– COMUNITÀ DI S. EGIDIO, La Parola e la storia. Tempo ordinario. Parte prima, Milano, Vita e Pensiero, 2012.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. II: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.
PER APPROFONDIRE:
XXV DOM TEMP ORD ANNO B