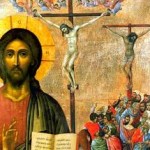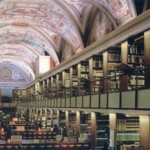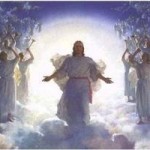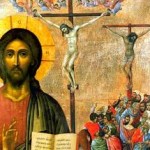
Prima lettura: Zaccaria 12,10-11;13,1
|
Così dice il Signore: «Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al lamento di Adad-Rimmon nella pianura di Meghiddo. In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l’impurità».
|
Chi abbia potuto suggerire a Pietro di rispondere in modo esatto, benché non del tutto consapevolmente, se non lo Spirito? Nel passo parallelo di Mt 16,17 Gesù afferma che Pietro ha parlato perché ispirato: «E Gesù: ‘Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli’».
Lo Spirito fa recuperare all’uomo quelle disposizioni, grazia e consolazione, essenziali per mettersi in comunicazione con Dio. Inoltre, lo Spirito, aprendo gli occhi all’uomo, gli fa incontrare un Dio che si interessa a tal punto di lui da sentirsi trafitto, e lo induce così a trovare consolazione nel pianto della preghiera e dell’implorazione. Ma quando abbiamo visto Dio trafitto se non volgendo il nostro sguardo a Cristo crocifisso, figlio unico e primogenito di Dio morto per noi? Parlando delle Scritture adempiute da Gesù, il vangelo di Giovanni riprende proprio questo concetto: «E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (19,37). Luca inoltre ci descrive le donne che piangevano mentre Gesù si portava al luogo della sua crocifissione: «Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui» (23,27).
Eppure, le cose non possono terminare con la morte: il riferimento ad Adad-Rimmon lo sottintende. Come nella pianura di Meghiddo i Cananei celebravano la morte di Baal (chiamato anche Adad-Rimmon) con il pianto e ne proclamavano la «rinascita», perché ricominciava con la primavera il cielo della natura, così il pianto effettuato a Gerusalemme
preluderà alla risurrezione del Messia, primavera di un’epoca nuova.
Seconda lettura: Galati 3,26-29
|
Fratelli, tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.
|
Ma che cosa è in grado di produrre la fede? Soltanto il riconoscimento di Gesù in quanto Figlio di Dio e Messia? Quale impatto si verifica? San Paolo, nel piccolo brano che leggiamo in questa domenica, ci illustra in sintesi il grande mistero al quale apparteniamo.
La prima affermazione riguarda la fede che ci rende figli di Dio, «poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo» (3,27). Infatti, come esseri umani, abbiamo addosso un vestito disadatto a presentarci al cospetto del Padre buono e misericordioso. Quanto sia importante il vestito nel linguaggio biblico lo si desume dal fatto che esso viene considerato espressione dell’identità della persona. Nella parabola del banchetto nuziale «il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l’abito nuziale, gli disse: ‘Amico, come hai potuto entrare qui senz’abito nuziale’» (Mt 22,11-12). D’altronde, Paolo invita i cristiani a rivestirsi di Cristo, perché ciò vuol dire rinnovamento della vita: «Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri» (Rm 13,14).
Una volta che ci siamo rivestiti di Cristo e apparteniamo a lui, non possono più sussistere quelle barriere che dividono l’umanità, rendendola infelice e nemica di se stessa. Avere tutti il medesimo «vestito», perciò, spinge l’umanità a riscoprirsi una nel nome di colui che l’ha salvata: «E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito» (1Cor 12,13). Il battesimo si fa dunque strumento di questo processo di unità e di pace, perché si parte tutti dallo stesso punto: l’essere figli di un unico Padre. Infatti, «beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9).
Infine, san Paolo collega l’appartenenza a Cristo con l’essere discendenza di Abramo e, quindi, eredi secondo la promessa fatta da Dio a lui. Gli Ebrei erano giustamente fieri di essere discendenza di Abramo: «Noi siamo discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno» (Gv 8,33). In verità, ad Abramo era stato promesso di diventare padre di una moltitudine di popoli: «Eccomi: la mia alleanza è con tè e sarai padre di una moltitudine di popoli. Non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abraham perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te nasceranno dei re» (Gn 17,4-6). A lui, come ci riferisce, ad esempio, Gn 15, fu detto che i suoi discendenti avrebbero avuto in eredità un paese, la terra d’Israele, immagine di quel regno che Dio instaurerà. In conclusione, con parole che lo stesso san Paolo usa in un altro contesto, «se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (Rm 8,17).
Vangelo: Luca 9,18-24
|
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è risorto».
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».
Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà».
|
Esegesi
Durante la sua vita pubblica, Gesù ha sempre cercato di riservarsi dei momenti che non consistessero di solo puro riposo, bensì anche di preghiera o di dialogo con i propri discepoli. Già in questo stesso capitolo Luca ci narra che, al ritorno degli apostoli dalla missione, Gesù li invitò a ritirarsi con lui in disparte. Ma la folla glielo impedì, «costringendo» proprio lui a predicare e a guarire (9,10-11) e, infine, a moltiplicare i pani e i pesci (9,12-17). Questa volta, invece, sembra finalmente che ci sia riuscito, perché il versetto 18 ci informa che egli si trovava solo a pregare e i discepoli gli erano accanto. Ad ogni modo, l’evangelista Luca ci fa notare spesso che Gesù era solito pregare, specialmente nei momenti fondamentali della sua missione: ad esempio, nel giorno del battesimo, egli riceve lo Spirito mentre si trova in preghiera (3,21), oppure alla fine di impegnative fatiche apostoliche (5,16).
Il Maestro è però anche conscio che un numero sempre maggiore di persone si interrogano sulla sua identità. Giovanni il Battista mandò addirittura i suoi discepoli a chiedere: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» (7,20); dopo che la peccatrice fu perdonata in casa di Simone il fariseo, i commensali si domandarono: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» (7,49). Persino Erode il tetrarca «sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: «Giovanni è risuscitato dai morti», altri: «È apparso Elia», e altri ancora: «È risorto uno degli antichi profeti». Ma Erode diceva: «Giovanni l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale sento dire tali cose?». E cercava di vederlo» (9,7-9). Erode davvero vide Gesù, ma in una circostanza nella quale non potette ascoltare nessuna sua parola (23,6-12).
Se altrove molti si erano chiesti chi fosse Gesù, ora è egli stesso che vuole sapere che cosa gli altri pensino di lui. Il «sondaggio» d’opinione viene eseguito interrogando i discepoli, che si dimostrano ben informati, ripetendo quello che era stato detto al tetrarca Erode: «Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è risorto» (9,19). Il parametro è chiaro: per il suo modo di comportarsi e di parlare, Gesù assomiglia tanto a quei profeti che, nell’Antico Testamento, erano stati protagonisti di buona parte della vita religiosa, e non solo, d’Israele. Gesù non può meravigliarsi del fatto che lo si paragoni a un profeta. Nella sinagoga di Nazaret, leggendo Is 61,12, egli dice che è stato consacrato come profeta e spiega il rifiuto dei suoi concittadini verso di lui con esempi tratti dalla vita di Elia ed Eliseo (4,16-27); dopo aver risuscitato il figlio della vedova di Nain, «tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: ‘Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo’» (7,16). In chiave polemica, lo afferma pure il fariseo Simone: «A quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé: ‘Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice’» (7,39).
Ma poi Gesù diventa curioso di sapere che cosa pensano i suoi discepoli, coloro che l’hanno seguito in giro per la Galilea assistendo a cose straordinarie compiute da lui. Pietro rispose per tutti: «Il Cristo di Dio» (9,20). Finora, nella sua vita pubblica, Gesù era stato chiamato «Cristo» soltanto da esseri non appartenenti al mondo umano, come gli angeli, che in 2,11 ne annunziarono ai pastori la nascita, e come i demoni, che lo riconoscono quale Cristo in 4,41. Ma nessun uomo lo aveva mai chiamato e riconosciuto come tale fin quando Pietro non dichiarò questa sua fede. L’espressione, usata nell’Antico Testamento per indicare il re (cf. 1Sam 24,7.11; 26,9.16.23) o una persona scelta da Dio per svolgere una
missione speciale (Is 45.1), esprime una visione di messia ancora parziale e soltanto legato al momento della gloria umanamente intesa, perciò Gesù sente il bisogno di impedire ai discepoli di affermare ciò in pubblico (la gente, ma neanche i discepoli, non era pronta per una rivelazione del genere), aggiungendovi l’annuncio della passione, morte e risurrezione, unitamente con le severe condizioni per la sequela. Annunciare il Cristo non significa annunciare con le sole parole una dottrina, bensì impegnare la propria psychè (vita) al punto da essere disposti a perderla, come la perse Gesù stesso, per ritrovarla poi nella risurrezione.
Meditazione
Si potrebbe cogliere nella domanda che Gesù rivolge ai discepoli la prospettiva teologica a cui ci orienta la liturgia della Parola di questa domenica: «Ma voi, chi dite che io sia?» (Lc 9,20). Chi è Gesù per il discepolo? Nella sequela quotidiana dietro questo maestro così discusso, così misterioso, il discepolo ha avuto il coraggio di fissare lo sguardo sul volto autentico di Gesù? E quali tratti di questo volto è riuscito a cogliere? L’interrogativo che Gesù pone ai discepoli incuriosisce anche la gente e inquieta lo stesso Erode (cfr. 9,7-8); le risposte a questa domanda si rincorrono e i modelli biblici sembrano offrire una qualche spiegazione sulla identità di Gesù: è Giovanni «risorto dai morti» (9,7), «altri dicono Elia; altri, uno degli antichi profeti che è risorto» (9,19). Ora però, è Gesù stesso a porre questa domanda e lo fa coinvolgendo i discepoli in una risposta personale: «Ma voi, chi dite che io sia?» (9,20). Pietro si fa portavoce dei suoi compagni e la sua risposta va ben oltre le varie opinioni raccolte tra la gente: per i discepoli Gesù è «il Cristo di Dio» (v. 20). Il discepolo, nella fede, intuisce il mistero che abita Gesù e proclama in lui l’uomo scelto da Dio per l’attuazione delle sue promesse di salvezza. Ma la via che il Messia sceglie per portare a compimento il progetto di Dio, «per riversare sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione» (Zc 12,10), è una via misteriosa che passa attraverso una umiliazione che lascia sconcertato l’uomo perché contrasta con le sue attese di gloria e di potere. Gesù è il Cristo di Dio perché è il Figlio obbediente, il servo umile che ascolta e realizza la Parola, rivelando la fedeltà di Dio al suo popolo, nonostante il suo rifiuto e la sua incredulità. Gesù è il Messia perché è «il Figlio dell’uomo (che) deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno» (v. 22). Tratteggiando questo volto del Messia così inaudito e scandaloso per l’uomo, Gesù rilegge l’oscura profezia di Zaccaria, portandola a compimento: quel re messianico coperto di ferite è lui stesso, il crocifisso, dal cui fianco aperto usciranno sangue e acqua (cfr. Gv 19,34), segno di quello spirito di grazia e di con-solazione riversato sull’umanità intera (cfr. Zc 12,10). Di fronte a questo volto, il discepolo deve compiere un movimento di conversione, un lungo cammino di purificazione perché siano cancellate quelle pretese dell’uomo che diventano pietra di inciampo e venga accolta la rivelazione del Messia crocifisso.
Per comprendere il cammino di questo messia rifiutato è necessario attendere il momento in cui si attuerà la profezia: «…guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico» (Zc 12,10, testo citato in Gv 19,37). Tuttavia, dal momento in cui il discepolo ha accettato di rispondere alla domanda di Gesù e compromettersi con la sua via, è già iniziato questo cammino di conversione, perché incessantemente deve volgere lo sguardo verso colui che cammina decisamente verso Gerusalemme (cfr. Lc 9,51), lì dove il Figlio dell’uomo deve essere «ucciso e risorgere il terzo giorno» (9,22). Ora il discepolo deve porsi la domanda: chi è il discepolo che segue questo Messia? Ed è Gesù a rispondere a questo interrogativo nascosto nel cuore di tutti coloro che hanno ascoltato, disorientati e sconcertati, l’annuncio della passione del Messia: «se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà» (vv. 23-24). L’identità del discepolo si fonde con quella di Gesù e il cammino di Gesù motiva e da qualità al cammino di sequela del discepolo. Si tratta di andare dietro a Gesù, di seguire Gesù, di perdere la propria vita per causa sua. Ciò che costituisce l’identità del discepolo e rende autentica la sua sequela è anzitutto e soprattutto la scoperta del volto di Gesù, l’aver risposto personalmente e in modo irrepetibile a quella chiamata espressa nell’interrogativo: «Ma voi, chi dite che io sia?». Da questa risposta che coinvolge il discepolo nel cuore stesso della sua vita, quella vita che può essere persa o salvata in relazione a Gesù, dipende la serietà della sequela, e nello stesso tempo la sua fatica, la sua sofferenza. Gesù scandisce in tre momenti il cammino del discepolo, tre tappe che rendono autentica ogni sequela. Il punto di partenza è la libertà che nasce dall’incontro con Gesù ed è solo lui che deve essere seguito («se qualcuno vuol venire dietro a me», v. 23).
Ma per seguire sono necessarie due condizioni: una reale libertà da se stessi e la scelta di affrontare il cammino stesso di Gesù verso Gerusalemme. Rinnegare se stessi in un contesto in cui si parla di realizzazione di sé, può suonare negativo. Gesù non vuole che il discepolo rinunci alla propria umanità, alla bellezza della propria vita. Ma vuole che questa vita sia veramente bella. Infatti proprio quel mondo interiore fatto di pretese di dominio, di violenza, di falsità, quell’amore smodato di sé che ci illude di salvare la propria vita per il solo fatto di tenerla stretta tra le mani, rende la nostra vita brutta, infelice. È questo che deve essere abbandonato per diventare liberi, per vivere da salvati.
E poi è necessario prendere la propria croce. Anzi Luca aggiunge: ogni giorno (v. 23). Qual è la croce da prender su di sé? Sono le sofferenze che si incontrano nella vita (dolore, malattie, fallimenti ecc.)? Ma può Gesù invitarci a prender ciò che contraddice la dignità dell’uomo? La croce da prendere, la sofferenza da portare (ed è la propria, quella che solo ciascuno di noi può assumere liberamente) non è tanto la sofferenza che nasce dalla relazione con i limiti della natura umana (in qualche modo inevitabile, anche se attraverso di essa possiamo scoprire qualcosa di diverso in noi); è la sofferenza che nasce dalla nostra relazione con Cristo. È la sofferenza di chi lotta per essere fedele a Gesù, di chi ogni giorno fatica nella sua sequela, di chi si scontra con la apparente debolezza delle promesse di Dio,
di chi rischia tutto per obbedire alla logica del vangelo. È la fatica di esser cristiani. La croce non ha senso in sé. Solo in Cristo, nel suo amore sino alla fine, essa acquista un senso. E diventa il paradosso del chicco di grano che per portare frutto deve accettare di essere nascosto sotto terra e morire (cfr. Gv 12,24). Ma ciò che conta è il frutto. Si comprende la morte del seme dal frutto che porta. È il paradosso di una vita perduta perché donata e quindi vissuta in pienezza, cioè salvata (cfr. Lc 9,24 e Gv 12,25). Si comprende la croce dal dono della vita che da essa sgorga.
La rinuncia e la croce (la fatica di esser discepoli) sono la qualità e l’autenticità della sequela. Ma la sequela non si riduce alla rinuncia e alla croce. Non solo perché la meta della sequela è la gioia, è l’evangelo, una vita salvata, ma soprattutto perché la sequela è camminare dietro a Gesù, è l’esperienza quotidiana della comunione con lui, comunione che è salvezza e perdono. Si rinuncia e si perde per trovare la vita. Ancora una volta siamo richiamati a guardare in avanti (solo così si può camminare), a tenere fisso il nostro sguardo sul volto di Gesù, perché è lui che ci precede ed è lui solo a conoscere la via.
Preghiere e racconti
«Di Dio oggi nulla posso dirvi»
Dice Angela da Foligno una mistica del secolo XIII al confessore che insisteva perché ella gli spiegasse meglio una sua esperienza mistica, a un certo punto, gli disse: Padre, se tu provassi ciò che ho provato io e poi salissi sul pulpito a predicare, non potresti far altro che dire, rivolto al popolo: “Fratelli, andatevene con la benedizione di Dio perché di Dio oggi nulla posso dirvi”.
Fede e roccia
L’uomo d’oggi, Signore Gesù, è sommerso
dall’appariscenza e dall’effimero,
si lascia incantare da frasi vuote e immagini colorite,
ha perso la capacità di riflettere,
si lascia trascinare da mode e miti
che durano una stagione.
Signore, tu hai scelto Pietro come roccia
non per le sue qualità umane,
ma per la fedeltà alla confessione di fede.
Donaci la fede di Pietro, solida e certa
su cui edificare la tua Chiesa.
Donaci la tua fiducia tale da meritare
in custodia le chiavi del Regno
e confermare nella fede i fratelli vacillanti.
Siamo chiamati a riconoscere il tuo primato
e servirti nell’umiltà.
La fede di Pietro è roccia incrollabile,
modello di chiunque voglia credere nella Verità.
Fa’ che anche noi, come Pietro, possiamo dire:
«Signore, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
Critica di se stessi
Fedeltà a se stessi? Questo minuscolo sé che cosa contiene di così grande per essergli fedele? Appare spesso così piccolo, altezzoso, supponente, meschinamente interessato … stupido. Affidarsi a questa instabile imbarcazione per attraversare il mare della vita non è certo una garanzia. Gesù lo insegnava a suo modo dicendo: “chi vorrà salvare la propria vita, la perderà”, cioè chi si concentrerà unicamente su se stesso si smarrirà, chi imposterà la sua vita solo sul proprio interesse e sul proprio piacere non guadagnerà ciò che è veramente prezioso nella vita: “Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima?”.
Siamo in presenza di un paradosso, c’è qualcosa che si può perdere o che si può guadagnare, e questo qualcosa è la psyché, l’anima spirituale, cioè (dinamicamente considerata) la libertà. Devo fare di tutto per guadagnare la mia anima spirituale, per salvaguardare la mia libertà, perché lo scopo della mia esistenza di uomo consiste esattamente in questo. Ma ecco il paradosso: proprio per guadagnare il centro di me stesso, devo diffidare di me stesso, mi devo superare. La versione della Cei traduce le parole di Gesù in Marco 8,34 in questo modo: “Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso”, mentre sarebbe meglio rendere il verbo greco aparnéomai con “negare” nel senso di “vincere”, “superare”; se qualcuno vuol venire dietro di me, si deve negare, si deve superare. Non si tratta di rinnegare se stessi quasi in odio a se stessi, ma si tratta di superare i propri interessi particolari per realizzarsi veramente nell’adesione a qualcosa di più grande. Solo uscendo dal mio orizzonte inevitabilmente limitato sarò infatti nella condizione di incontrare qualcosa di più grande e di più stabile del mio piccolo e instabile Io, affidandomi al quale il mio Io nella sua profondità (l’anima spirituale) non si perde, ma si guadagna, si fortifica, si compie. […] Il nostro essere-energia va coltivato, speso, investito: solo così si sviluppano tutte le nostre potenzialità e diventiamo veramente ciò che siamo, cioè liberta che vuole la verità, che vuole aderire alla realtà.
(Vito MANCUSO, La vita autentica, Raffaello Cortina Ed., Milano, 2009, 107-109).
L’incontro con la croce
Nel 1917, allorché Edith Stein era assistente di Edmund Husserl, giunse a Friburgo una notizia dolorosa. Adolf Reinach, anche lui assistente di Husserl, era morto sul campo di battaglia delle Fiandre. Il dolore di Edith Stein fu grande; pensò alla moglie di Reinach. Da Gottinga, la pregarono di ordinare il lascito di Reinach. Edith Stein temeva di rivedere la vedova. Il suo animo era sconvolto: Reinach, che insieme con Husserl costituiva il fulcro del circolo di Gottinga, non viveva più. Attraverso la sua bontà, aveva potuto gettare uno sguardo in quel mondo che le sembrava sbarrato. Il ricordo non la aiutava. Che cosa avrebbe potuto dire alla moglie, certamente in preda alla disperazione? Edith Stein non poteva credere a una vita eterna.
L’atteggiamento rassegnato della signora Reinach la colpì come un raggio di luce che proveniva da quel regno nascosto. La vedova non era abbattuta dal dolore. Nonostante il lutto, era piena di una speranza che la consolava e le dava pace. Di fronte a questa esperienza, andarono in frantumi gli argomenti razionali di Edith Stein. Non la conoscenza chiara e distinta, ma il contatto con l’essenza della verità trasformò Edith Stein. La fede risplendette a lei nel mistero della croce. Era necessario ancora un lungo cammino prima che riuscisse a trarre tutte le conseguenze da questa esperienza. Per una pensatrice come Edith Stein, non era facile tagliare tutti i ponti e osare il salto nella nuova vita. Ma il colpo fu così forte che ancora poco prima della sua morte, parlava in questi termini della sua esperienza al gesuita padre Hirschmann: «Fu il mio primo incontro con la croce e con la forza divina che essa comunica a chi la porta. Vidi per la prima volta, tangibile davanti a me, la chiesa, nata dal dolore del Redentore, nella sua vittoria sul pungolo della morte. Fu il momento in cui andò in frantumi la mia incredulità e risplendette la luce di Cristo, Cristo nel mistero della croce»
(W. HERBSTRITH [ed.], Edith Stein, La Mistica della Croce. Scritti spirituali sul senso della vita, Roma 1987, 87).
Che cosa sei tu per me?
Signore,
che cosa sono io per te,
perché tu voglia essere amato da me
al punto che ti inquieti se non lo faccio,
e mi minacci severamente?
Come se non fosse già una grossa sventura il non amarti!
Dimmi, ti prego,
Signore Dio mio misericordioso,
che cosa sei tu per me?
Dì alla mia anima:
«Io sono la tua salvezza».
Dillo, che io lo senta.
Le orecchie del mio cuore, Signore,
sono davanti a te;
aprile e dì alla mia anima:
«Io sono la tua salvezza».
Rincorrerò questa voce
e così ti raggiungerò;
tu non nascondermi il tuo volto.
(AGOSTINO D’IPPONA, Confessioni I, 5).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– M. FERRARI, monaco di Camaldoli, «Oggi di è adempiuta questa scrittura», Milano, Vita e Pensiero, 2013.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Seconda parte: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla Risurrezione, Città del Vaticano, Liberia Editrice Vaticana, 2011.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
PER L’APPROFONDIMENTO:
XII DOM TEMP ORD (C)