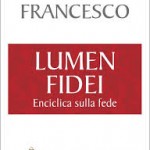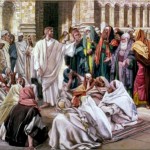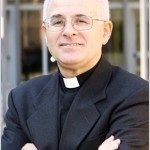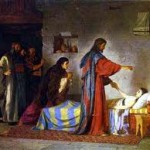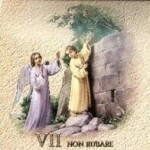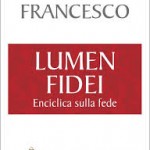
LETTERA ENCICLICA
LUMEN FIDEI
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO
AI VESCOVI
AI PRESBITERI E AI DIACONI
ALLE PERSONE CONSACRATE
E A TUTTI I FEDELI LAICI
SULLA FEDE
1. La luce della fede: con quest’espressione, la tradizione della Chiesa ha indicato il grande dono portato da Gesù, il quale, nel Vangelo di Giovanni, così si presenta: « Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre » (Gv 12,46). Anche san Paolo si esprime in questi termini: « E Dio, che disse: “Rifulga la luce dalle tenebre”, rifulge nei nostri cuori » (2 Cor 4,6). Nel mondo pagano, affamato di luce, si era sviluppato il culto al dio Sole, Sol invictus, invocato nel suo sorgere. Anche se il sole rinasceva ogni giorno, si capiva bene che era incapace di irradiare la sua luce sull’intera esistenza dell’uomo. Il sole, infatti, non illumina tutto il reale, il suo raggio è incapace di arrivare fino all’ombra della morte, là dove l’occhio umano si chiude alla sua luce. « Per la sua fede nel sole — afferma san Giustino Martire — non si è mai visto nessuno pronto a morire ».[1] Consapevoli dell’orizzonte grande che la fede apriva loro, i cristiani chiamarono Cristo il vero sole, « i cui raggi donano la vita ».[2] A Marta, che piange per la morte del fratello Lazzaro, Gesù dice: « Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio? » (Gv 11,40). Chi crede, vede; vede con una luce che illumina tutto il percorso della strada, perché viene a noi da Cristo risorto, stella mattutina che non tramonta.
Una luce illusoria?
2. Eppure, parlando di questa luce della fede, possiamo sentire l’obiezione di tanti nostri contemporanei. Nell’epoca moderna si è pensato che una tale luce potesse bastare per le società antiche, ma non servisse per i nuovi tempi, per l’uomo diventato adulto, fiero della sua ragione, desideroso di esplorare in modo nuovo il futuro. In questo senso, la fede appariva come una luce illusoria, che impediva all’uomo di coltivare l’audacia del sapere. Il giovane Nietzsche invitava la sorella Elisabeth a rischiare, percorrendo « nuove vie…, nell’incertezza del procedere autonomo ». E aggiungeva: « A questo punto si separano le vie dell’umanità: se vuoi raggiungere la pace dell’anima e la felicità, abbi pur fede, ma se vuoi essere un discepolo della verità, allora indaga ».[3] Il credere si opporrebbe al cercare. A partire da qui, Nietzsche svilupperà la sua critica al cristianesimo per aver sminuito la portata dell’esistenza umana, togliendo alla vita novità e avventura. La fede sarebbe allora come un’illusione di luce che impedisce il nostro cammino di uomini liberi verso il domani.
3. In questo processo, la fede ha finito per essere associata al buio. Si è pensato di poterla conservare, di trovare per essa uno spazio perché convivesse con la luce della ragione. Lo spazio per la fede si apriva lì dove la ragione non poteva illuminare, lì dove l’uomo non poteva più avere certezze. La fede è stata intesa allora come un salto nel vuoto che compiamo per mancanza di luce, spinti da un sentimento cieco; o come una luce soggettiva, capace forse di riscaldare il cuore, di portare una consolazione privata, ma che non può proporsi agli altri come luce oggettiva e comune per rischiarare il cammino. Poco a poco, però, si è visto che la luce della ragione autonoma non riesce a illuminare abbastanza il futuro; alla fine, esso resta nella sua oscurità e lascia l’uomo nella paura dell’ignoto. E così l’uomo ha rinunciato alla ricerca di una luce grande, di una verità grande, per accontentarsi delle piccole luci che illuminano il breve istante, ma sono incapaci di aprire la strada. Quando manca la luce, tutto diventa confuso, è impossibile distinguere il bene dal male, la strada che porta alla mèta da quella che ci fa camminare in cerchi ripetitivi, senza direzione.
Una luce da riscoprire
4. È urgente perciò recuperare il carattere di luce proprio della fede, perché quando la sua fiamma si spegne anche tutte le altre luci finiscono per perdere il loro vigore. La luce della fede possiede, infatti, un carattere singolare, essendo capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo. Perché una luce sia così potente, non può procedere da noi stessi, deve venire da una fonte più originaria, deve venire, in definitiva, da Dio. La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita. Trasformati da questo amore riceviamo occhi nuovi, sperimentiamo che in esso c’è una grande promessa di pienezza e si apre a noi lo sguardo del futuro. La fede, che riceviamo da Dio come dono soprannaturale, appare come luce per la strada, luce che orienta il nostro cammino nel tempo. Da una parte, essa procede dal passato, è la luce di una memoria fondante, quella della vita di Gesù, dove si è manifestato il suo amore pienamente affidabile, capace di vincere la morte. Allo stesso tempo, però, poiché Cristo è risorto e ci attira oltre la morte, la fede è luce che viene dal futuro, che schiude davanti a noi orizzonti grandi, e ci porta al di là del nostro “io” isolato verso l’ampiezza della comunione. Comprendiamo allora che la fede non abita nel buio; che essa è una luce per le nostre tenebre. Dante, nella Divina Commedia, dopo aver confessato la sua fede davanti a san Pietro, la descrive come una “favilla, / che si dilata in fiamma poi vivace / e come stella in cielo in me scintilla”.[4] Proprio di questa luce della fede vorrei parlare, perché cresca per illuminare il presente fino a diventare stella che mostra gli orizzonti del nostro cammino, in un tempo in cui l’uomo è particolarmente bisognoso di luce.
5. Il Signore, prima della sua passione, assicurava a Pietro: « Ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno » (Lc 22,32). Poi gli ha chiesto di “confermare i fratelli” in quella stessa fede. Consapevole del compito affidato al Successore di Pietro, Benedetto XVI ha voluto indire quest’Anno della fede, un tempo di grazia che ci sta aiutando a sentire la grande gioia di credere, a ravvivare la percezione dell’ampiezza di orizzonti che la fede dischiude, per confessarla nella sua unità e integrità, fedeli alla memoria del Signore, sostenuti dalla sua presenza e dall’azione dello Spirito Santo. La convinzione di una fede che fa grande e piena la vita, centrata su Cristo e sulla forza della sua grazia, animava la missione dei primi cristiani. Negli Atti dei martiri leggiamo questo dialogo tra il prefetto romano Rustico e il cristiano Gerace: « Dove sono i tuoi genitori? », chiedeva il giudice al martire, e questi rispose: « Nostro vero padre è Cristo, e nostra madre la fede in Lui ».[5] Per quei cristiani la fede, in quanto incontro con il Dio vivente manifestato in Cristo, era una “madre”, perché li faceva venire alla luce, generava in essi la vita divina, una nuova esperienza, una visione luminosa dell’esistenza per cui si era pronti a dare testimonianza pubblica fino alla fine.
6. L’Anno della fede ha avuto inizio nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II. Questa coincidenza ci consente di vedere che il Vaticano II è stato un Concilio sulla fede,[6] in quanto ci ha invitato a rimettere al centro della nostra vita ecclesiale e personale il primato di Dio in Cristo. La Chiesa, infatti, non presuppone mai la fede come un fatto scontato, ma sa che questo dono di Dio deve essere nutrito e rafforzato, perché continui a guidare il suo cammino. Il Concilio Vaticano II ha fatto brillare la fede all’interno dell’esperienza umana, percorrendo così le vie dell’uomo contemporaneo. In questo modo è apparso come la fede arricchisce l’esistenza umana in tutte le sue dimensioni.
7. Queste considerazioni sulla fede — in continuità con tutto quello che il Magistero della Chiesa ha pronunciato circa questa virtù teologale[7] —,intendono aggiungersi a quanto Benedetto XVI ha scritto nelle Lettere encicliche sulla carità e sulla speranza. Egli aveva già quasi completato una prima stesura di Lettera enciclica sulla fede. Gliene sono profondamente grato e, nella fraternità di Cristo, assumo il suo prezioso lavoro, aggiungendo al testo alcuni ulteriori contributi. Il Successore di Pietro, ieri, oggi e domani, è infatti sempre chiamato a “confermare i fratelli” in quell’incommensurabile tesoro della fede che Dio dona come luce sulla strada di ogni uomo.
Nella fede, dono di Dio, virtù soprannaturale da Lui infusa, riconosciamo che un grande Amore ci è stato offerto, che una Parola buona ci è stata rivolta e che, accogliendo questa Parola, che è Gesù Cristo, Parola incarnata, lo Spirito Santo ci trasforma, illumina il cammino del futuro, e fa crescere in noi le ali della speranza per percorrerlo con gioia. Fede, speranza e carità costituiscono, in un mirabile intreccio, il dinamismo dell’esistenza cristiana verso la comunione piena con Dio. Com’è questa via che la fede schiude davanti a noi? Da dove viene la sua luce potente che consente di illuminare il cammino di una vita riuscita e feconda, piena di frutto?
CAPITOLO PRIMO
ABBIAMO CREDUTO ALL’AMORE
(cfr 1 Gv 4,16)
Abramo, nostro padre nella fede
8. La fede ci apre il cammino e accompagna i nostri passi nella storia. È per questo che, se vogliamo capire che cosa è la fede, dobbiamo raccontare il suo percorso, la via degli uomini credenti, testimoniata in primo luogo nell’Antico Testamento. Un posto singolare appartiene ad Abramo, nostro padre nella fede. Nella sua vita accade un fatto sconvolgente: Dio gli rivolge la Parola, si rivela come un Dio che parla e che lo chiama per nome. La fede è legata all’ascolto. Abramo non vede Dio, ma sente la sua voce. In questo modo la fede assume un carattere personale. Dio risulta così non il Dio di un luogo, e neanche il Dio legato a un tempo sacro specifico, ma il Dio di una persona, il Dio appunto di Abramo, Isacco e Giacobbe, capace di entrare in contatto con l’uomo e di stabilire con lui un’alleanza. La fede è la risposta a una Parola che interpella personalmente, a un Tu che ci chiama per nome.
9. Ciò che questa Parola dice ad Abramo consiste in una chiamata e in una promessa. È prima di tutto chiamata ad uscire dalla propria terra, invito ad aprirsi a una vita nuova, inizio di un esodo che lo incammina verso un futuro inatteso. La visione che la fede darà ad Abramo sarà sempre congiunta a questo passo in avanti da compiere: la fede “vede” nella misura in cui cammina, in cui entra nello spazio aperto dalla Parola di Dio. Questa Parola contiene inoltre una promessa: la tua discendenza sarà numerosa, sarai padre di un grande popolo (cfrGen 13,16; 15,5; 22,17). È vero che, in quanto risposta a una Parola che precede, la fede di Abramo sarà sempre un atto di memoria. Tuttavia questa memoria non fissa nel passato ma, essendo memoria di una promessa, diventa capace di aprire al futuro, di illuminare i passi lungo la via. Si vede così come la fede, in quanto memoria del futuro, memoria futuri, sia strettamente legata alla speranza.
10. Quello che viene chiesto ad Abramo è di affidarsi a questa Parola. La fede capisce che la parola, una realtà apparentemente effimera e passeggera, quando è pronunciata dal Dio fedele diventa quanto di più sicuro e di più incrollabile possa esistere, ciò che rende possibile la continui-tà del nostro cammino nel tempo. La fede accoglie questa Parola come roccia sicura sulla quale si può costruire con solide fondamenta. Per questo nella Bibbia la fede è indicata con la parola ebraica ’emûnah, derivata dal verbo ’amàn, che nella sua radice significa “sostenere”. Il termine ’emûnah può significare sia la fedeltà di Dio, sia la fede dell’uomo. L’uomo fedele riceve la sua forza dall’affidarsi nelle mani del Dio fedele. Giocando sui due significati della parola — presenti anche nei termini corrispondenti in greco (pistós) e latino (fidelis) —, san Cirillo di Gerusalemme esalterà la dignità del cristiano, che riceve il nome stesso di Dio: ambedue sono chiamati “fedeli”.[8] Sant’Agostino lo spiegherà così: « L’uomo fedele è colui che crede a Dio che promette; il Dio fedele è colui che concede ciò che ha promesso all’uomo ».[9]
11. Un ultimo aspetto della storia di Abramo è importante per capire la sua fede. La Parola di Dio, anche se porta con sé novità e sorpresa, non risulta per nulla estranea all’esperienza del Patriarca. Nella voce che si rivolge ad Abramo, egli riconosce un appello profondo, inscritto da sempre nel cuore del suo essere. Dio associa la sua promessa a quel “luogo” in cui l’esistenza dell’uomo si mostra da sempre promettente: la paternità, il generarsi di una nuova vita — « Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco » (Gen17,19). Quel Dio che chiede ad Abramo di affidarsi totalmente a Lui si rivela come la fonte da cui proviene ogni vita. In questo modo la fede si collega con la Paternità di Dio, dalla quale scaturisce la creazione: il Dio che chiama Abramo è il Dio creatore, Colui che « chiama all’esistenza le cose che non esistono » (Rm 4,17), Colui che « ci ha scelti prima della creazione del mondo… predestinandoci a essere suoi figli adottivi » (Ef 1,4-5). Per Abramo la fede in Dio illumina le più profonde radici del suo essere, gli permette di riconoscere la sorgente di bontà che è all’origine di tutte le cose, e di confermare che la sua vita non procede dal nulla o dal caso, ma da una chiamata e un amore personali. Il Dio misterioso che lo ha chiamato non è un Dio estraneo, ma Colui che è origine di tutto e che sostiene tutto. La grande prova della fede di Abramo, il sacrificio del figlio Isacco, mostrerà fino a che punto questo amore originario è capace di garantire la vita anche al di là della morte. La Parola che è stata capace di suscitare un figlio nel suo corpo “come morto” e “nel seno morto” di Sara sterile (cfr Rm 4,19), sarà anche capace di garantire la promessa di un futuro al di là di ogni minaccia o pericolo (cfr Eb 11,19; Rm 4, 21).
La fede di Israele
12. La storia del popolo d’Israele, nel libro dell’Esodo, prosegue sulla scia della fede di Abramo. La fede nasce di nuovo da un dono originario: Israele si apre all’azione di Dio che vuole liberarlo dalla sua miseria. La fede è chiamata a un lungo cammino per poter adorare il Signore sul Sinai ed ereditare una terra promessa. L’amore divino possiede i tratti del padre che porta suo figlio lungo il cammino (cfr Dt 1,31). La confessione di fede di Israele si sviluppa come racconto dei benefici di Dio, del suo agire per liberare e guidare il popolo (cfr Dt 26,5-11), racconto che il popolo trasmette di generazione in generazione. La luce di Dio brilla per Israele attraverso la memoria dei fatti operati dal Signore, ricordati e confessati nel culto, trasmessi dai genitori ai figli. Impariamo così che la luce portata dalla fede è legata al racconto concreto della vita, al ricordo grato dei benefici di Dio e al compiersi progressivo delle sue promesse. L’architettura gotica l’ha espresso molto bene: nelle grandi Cattedrali la luce arriva dal cielo attraverso le vetrate dove si raffigura la storia sacra. La luce di Dio ci viene attraverso il racconto della sua rivelazione, e così è capace di illuminare il nostro cammino nel tempo, ricordando i benefici divini, mostrando come si compiono le sue promesse.
13. La storia di Israele ci mostra ancora la tentazione dell’incredulità in cui il popolo più volte è caduto. L’opposto della fede appare qui come idolatria. Mentre Mosè parla con Dio sul Sinai, il popolo non sopporta il mistero del volto divino nascosto, non sopporta il tempo dell’attesa. La fede per sua natura chiede di rinunciare al possesso immediato che la visione sembra offrire, è un invito ad aprirsi verso la fonte della luce, rispettando il mistero proprio di un Volto che intende rivelarsi in modo personale e a tempo opportuno. Martin Buber citava questa definizione dell’idolatria offerta dal rabbino di Kock: vi è idolatria « quando un volto si rivolge riverente a un volto che non è un volto ».[10] Invece della fede in Dio si preferisce adorare l’idolo, il cui volto si può fissare, la cui origine è nota perché fatto da noi. Davanti all’idolo non si rischia la possibilità di una chiamata che faccia uscire dalle proprie sicurezze, perché gli idoli « hanno bocca e non parlano » (Sal 115,5). Capiamo allora che l’idolo è un pretesto per porre se stessi al centro della realtà, nell’adorazione dell’opera delle proprie mani. L’uomo, perso l’orientamento fondamentale che dà unità alla sua esistenza, si disperde nella molteplicità dei suoi desideri; negandosi ad attendere il tempo della promessa, si disintegra nei mille istanti della sua storia. Per questo l’idolatria è sempre politeismo, movimento senza meta da un signore all’altro. L’idolatria non offre un cammino, ma una molteplicità di sentieri, che non conducono a una meta certa e configurano piuttosto un labirinto. Chi non vuole affidarsi a Dio deve ascoltare le voci dei tanti idoli che gli gridano: “Affidati a me!”. La fede in quanto legata alla conversione, è l’opposto dell’idolatria; è separazione dagli idoli per tornare al Dio vivente, mediante un incontro personale. Credere significa affidarsi a un amore misericordioso che sempre accoglie e perdona, che sostiene e orienta l’esistenza, che si mostra potente nella sua capacità di raddrizzare le storture della nostra storia. La fede consiste nella disponibilità a lasciarsi trasformare sempre di nuovo dalla chiamata di Dio. Ecco il paradosso: nel continuo volgersi verso il Signore, l’uomo trova una strada stabile che lo libera dal movimento dispersivo cui lo sottomettono gli idoli.
14. Nella fede di Israele emerge anche la figura di Mosè, il mediatore. Il popolo non può vedere il volto di Dio; è Mosè a parlare con YHWH sulla montagna e a riferire a tutti il volere del Signore. Con questa presenza del mediatore, Israele ha imparato a camminare unito. L’atto di fede del singolo si inserisce in una comunità, nel “noi” comune del popolo che, nella fede, è come un solo uomo, “il mio figlio primogenito”, come Dio chiamerà l’intero Israele (cfr Es 4,22). La mediazione non diventa qui un ostacolo, ma un’apertura: nell’incontro con gli altri lo sguardo si apre verso una verità più grande di noi stessi. J. J. Rousseau si lamentava di non poter vedere Dio personalmente: « Quanti uomini tra Dio e me! »;[11] « È così semplice e naturale che Dio sia andato da Mosè per parlare a Jean-Jacques Rousseau? ».[12] A partire da una concezione individualista e limitata della conoscenza non si può capire il senso della mediazione, questa capacità di partecipare alla visione dell’altro, sapere condiviso che è il sapere proprio dell’amore. La fede è un dono gratuito di Dio che chiede l’umiltà e il coraggio di fidarsi e affidarsi, per vedere il luminoso cammino dell’incontro tra Dio e gli uomini, la storia della salvezza.
La pienezza della fede cristiana
15. « Abramo […] esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia » (Gv 8,56). Secondo queste parole di Gesù, la fede di Abramo era orientata verso di Lui, era, in un certo senso, visione anticipata del suo mistero. Così lo intende sant’Agostino, quando afferma che i Patriarchi si salvarono per la fede, non fede in Cristo già venuto, ma fede in Cristo che stava per venire, fede tesa verso l’evento futuro di Gesù.[13] La fede cristiana è centrata in Cristo, è confessione che Gesù è il Signore e che Dio lo ha risuscitato dai morti (cfr Rm10,9). Tutte le linee dell’Antico Testamento si raccolgono in Cristo, Egli diventa il “sì” definitivo a tutte le promesse, fondamento del nostro “Amen” finale a Dio (cfr 2 Cor 1,20). La storia di Gesù è la manifestazione piena dell’affidabilità di Dio. Se Israele ricordava i grandi atti di amore di Dio, che formavano il centro della sua confessione e aprivano lo sguardo della sua fede, adesso la vita di Gesù appare come il luogo dell’intervento definitivo di Dio, la suprema manifestazione del suo amore per noi. Quella che Dio ci rivolge in Gesù non è una parola in più tra tante altre, ma la sua Parola eterna (cfr Eb 1,1-2). Non c’è nessuna garanzia più grande che Dio possa dare per rassicurarci del suo amore, come ci ricorda san Paolo (cfr Rm 8,31-39). La fede cristiana è dunque fede nell’Amore pieno, nel suo potere efficace, nella sua capacità di trasformare il mondo e di illuminare il tempo. « Abbiamo conosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi » (1 Gv 4,16). La fede coglie nell’amore di Dio manifestato in Gesù il fondamento su cui poggia la realtà e la sua destinazione ultima.
16. La prova massima dell’affidabilità dell’amore di Cristo si trova nella sua morte per l’uomo. Se dare la vita per gli amici è la massima prova di amore (cfr Gv 15,13), Gesù ha offerto la sua per tutti, anche per coloro che erano nemici, per trasformare il cuore. Ecco perché gli evangelisti hanno situato nell’ora della Croce il momento culminante dello sguardo di fede, perché in quell’ora risplende l’altezza e l’ampiezza dell’amore divino. San Giovanni collocherà qui la sua testimonianza solenne quando, insieme alla Madre di Gesù, contemplò Colui che hanno trafitto (cfr Gv 19,37): « Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate » (Gv 19,35). F. M. Dostoevskij, nella sua opera L’Idiota, fa dire al protagonista, il principe Myskin, alla vista del dipinto di Cristo morto nel sepolcro, opera di Hans Holbein il Giovane: « Quel quadro potrebbe anche far perdere la fede a qualcuno ».[14] Il dipinto rappresenta infatti, in modo molto crudo, gli effetti distruttivi della morte sul corpo di Cristo. E tuttavia, è proprio nella contemplazione della morte di Gesù che la fede si rafforza e riceve una luce sfolgorante, quando essa si rivela come fede nel suo amore incrollabile per noi, che è capace di entrare nella morte per salvarci. In questo amore, che non si è sottratto alla morte per manifestare quanto mi ama, è possibile credere; la sua totalità vince ogni sospetto e ci permette di affidarci pienamente a Cristo.
17. Ora, la morte di Cristo svela l’affidabilità totale dell’amore di Dio alla luce della sua Risurrezione. In quanto risorto, Cristo è testimone affidabile, degno di fede (cfr Ap 1,5; Eb 2,17), appoggio solido per la nostra fede. « Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede », afferma san Paolo (1 Cor 15,17). Se l’amore del Padre non avesse fatto risorgere Gesù dai morti, se non avesse potuto ridare vita al suo corpo, allora non sarebbe un amore pienamente affidabile, capace di illuminare anche le tenebre della morte. Quando san Paolo parla della sua nuova vita in Cristo, si riferisce alla « fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me » (Gal 2,20). Questa “fede del Figlio di Dio” è certamente la fede dell’Apostolo delle genti in Gesù, ma suppone anche l’affidabilità di Gesù, che si fonda, sì, nel suo amore fino alla morte, ma anche nel suo essere Figlio di Dio. Proprio perché Gesù è il Figlio, perché è radicato in modo assoluto nel Padre, ha potuto vincere la morte e far risplendere in pienezza la vita. La nostra cultura ha perso la percezione di questa presenza concreta di Dio, della sua azione nel mondo. Pensiamo che Dio si trovi solo al di là, in un altro livello di realtà, separato dai nostri rapporti concreti. Ma se fosse così, se Dio fosse incapace di agire nel mondo, il suo amore non sarebbe veramente potente, veramente reale, e non sarebbe quindi neanche vero amore, capace di compiere quella felicità che promette. Credere o non credere in Lui sarebbe allora del tutto indifferente. I cristiani, invece, confessano l’amore concreto e potente di Dio, che opera veramente nella storia e ne determina il destino finale, amore che si è fatto incontrabile, che si è rivelato in pienezza nella Passione, Morte e Risurrezione di Cristo.
18. La pienezza cui Gesù porta la fede ha un altro aspetto decisivo. Nella fede, Cristo non è soltanto Colui in cui crediamo, la manifestazione massima dell’amore di Dio, ma anche Colui al quale ci uniamo per poter credere. La fede, non solo guarda a Gesù, ma guarda dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazione al suo modo di vedere. In tanti ambiti della vita ci affidiamo ad altre persone che conoscono le cose meglio di noi. Abbiamo fiducia nell’architetto che costruisce la nostra casa, nel farmacista che ci offre il medicamento per la guarigione, nell’avvocato che ci difende in tribunale. Abbiamo anche bisogno di qualcuno che sia affidabile ed esperto nelle cose di Dio. Gesù, suo Figlio, si presenta come Colui che ci spiega Dio (cfr Gv 1,18).La vita di Cristo — il suo modo di conoscere il Padre, di vivere totalmente nella relazione con Lui — apre uno spazio nuovo all’esperienza umana e noi vi possiamo entrare. San Giovanni ha espresso l’importanza del rapporto personale con Gesù per la nostra fede attraverso vari usi del verbo credere. Insieme al “credere che” è vero ciò che Gesù ci dice (cfr Gv 14,10; 20,31), Giovanni usa anche le locuzioni “credere a” Gesù e “credere in” Gesù. “Crediamo a” Gesù, quando accettiamo la sua Parola, la sua testimonianza, perché egli è veritiero (cfr Gv 6,30). “Crediamo in” Gesù, quando lo accogliamo personalmente nella nostra vita e ci affidiamo a Lui, aderendo a Lui nell’amore e seguendolo lungo la strada (cfr Gv 2,11; 6,47; 12,44).
Per permetterci di conoscerlo, accoglierlo e seguirlo, il Figlio di Dio ha assunto la nostra carne, e così la sua visione del Padre è avvenuta anche in modo umano, attraverso un cammino e un percorso nel tempo. La fede cristiana è fede nell’Incarnazione del Verbo e nella sua Risurrezione nella carne; è fede in un Dio che si è fatto così vicino da entrare nella nostra storia. La fede nel Figlio di Dio fatto uomo in Gesù di Nazaret non ci separa dalla realtà, ma ci permette di cogliere il suo significato più profondo, di scoprire quanto Dio ama questo mondo e lo orienta incessantemente verso di Sé; e questo porta il cristiano a impegnarsi, a vivere in modo ancora più intenso il cammino sulla terra.
La salvezza mediante la fede
19. A partire da questa partecipazione al modo di vedere di Gesù, l’Apostolo Paolo, nei suoi scritti, ci ha lasciato una descrizione dell’esistenza credente. Colui che crede, nell’accettare il dono della fede, è trasformato in una creatura nuova, riceve un nuovo essere, un essere filiale, diventa figlio nel Figlio. “Abbà, Padre” è la parola più caratteristica dell’esperienza di Gesù, che diventa centro dell’esperienza cristiana (cfr Rm 8,15). La vita nella fede, in quanto esistenza filiale, è riconoscere il dono originario e radicale che sta alla base dell’esistenza dell’uomo, e può riassumersi nella frase di san Paolo ai Corinzi: « Che cosa possiedi che tu non l’abbia ricevuto? » (1 Cor 4,7). Proprio qui si colloca il cuore della polemica di san Paolo con i farisei, la discussione sulla salvezza mediante la fede o mediante le opere della legge. Ciò che san Paolo rifiuta è l’atteggiamento di chi vuole giustificare se stesso davanti a Dio tramite il proprio operare. Costui, anche quando obbedisce ai comandamenti, anche quando compie opere buone, mette al centro se stesso, e non riconosce che l’origine della bontà è Dio. Chi opera così, chi vuole essere fonte della propria giustizia, la vede presto esaurirsi e scopre di non potersi neppure mantenere nella fedeltà alla legge. Si rinchiude, isolandosi dal Signore e dagli altri, e per questo la sua vita si rende vana, le sue opere sterili, come albero lontano dall’acqua. Sant’Agostino così si esprime nel suo linguaggio conciso ed efficace: « Ab eo qui fecit te noli deficere nec ad te », « Da colui che ha fatto te, non allontanarti neppure per andare verso di te ».[15] Quando l’uomo pensa che allontanandosi da Dio troverà se stesso, la sua esistenza fallisce (cfr Lc 15,11-24). L’inizio della salvezza è l’apertura a qualcosa che precede, a un dono originario che afferma la vita e custodisce nell’esistenza. Solo nell’aprirci a quest’origine e nel riconoscerla è possibile essere trasformati, lasciando che la salvezza operi in noi e renda la vita feconda, piena di frutti buoni. La salvezza attraverso la fede consiste nel riconoscere il primato del dono di Dio, come riassume san Paolo: « Per grazia infatti siete stati salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio » (Ef 2,8).
20. La nuova logica della fede è centrata su Cristo. La fede in Cristo ci salva perché è in Lui che la vita si apre radicalmente a un Amore che ci precede e ci trasforma dall’interno, che agisce in noi e con noi. Ciò appare con chiarezza nell’esegesi che l’Apostolo delle genti fa di un testo del Deuteronomio, esegesi che si inserisce nella dinamica più profonda dell’Antico Testamento. Mosè dice al popolo che il comando di Dio non è troppo alto né troppo lontano dall’uomo. Non si deve dire: « Chi salirà in cielo per prendercelo? » o « Chi attraverserà per noi il mare per prendercelo? » (cfr Dt 30,11-14). Questa vicinanza della Parola di Dio viene interpretata da san Paolo come riferita alla presenza di Cristo nel cristiano: « Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo? — per farne cioè discendere Cristo —; oppure: Chi scenderà nell’abisso? — per fare cioè risalire Cristo dai morti » (Rm 10,6-7). Cristo è disceso sulla terra ed è risuscitato dai morti; con la sua Incarnazione e Risurrezione, il Figlio di Dio ha abbracciato l’intero cammino dell’uomo e dimora nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. La fede sa che Dio si è fatto molto vicino a noi, che Cristo ci è stato dato come grande dono che ci trasforma interiormente, che abita in noi, e così ci dona la luce che illumina l’origine e la fine della vita, l’intero arco del cammino umano.
21. Possiamo così capire la novità alla quale la fede ci porta. Il credente è trasformato dall’Amore, a cui si è aperto nella fede, e nel suo aprirsi a questo Amore che gli è offerto, la sua esistenza si dilata oltre sé. San Paolo può affermare: « Non vivo più io, ma Cristo vive in me » (Gal 2,20), ed esortare: « Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori » (Ef 3,17). Nella fede, l’”io” del credente si espande per essere abitato da un Altro, per vivere in un Altro, e così la sua vita si allarga nell’Amore. Qui si situa l’azione propria dello Spirito Santo. Il cristiano può avere gli occhi di Gesù, i suoi sentimenti, la sua disposizione filiale, perché viene reso partecipe del suo Amore, che è lo Spirito. È in questo Amore che si riceve in qualche modo la visione propria di Gesù. Fuori da questa conformazione nell’Amore, fuori della presenza dello Spirito che lo infonde nei nostri cuori (cfr Rm 5,5), è impossibile confessare Gesù come Signore (cfr 1 Cor 12,3).
La forma ecclesiale della fede
22. In questo modo l’esistenza credente diventa esistenza ecclesiale. Quando san Paolo parla ai cristiani di Roma di quell’unico corpo che tutti i credenti sono in Cristo, li esorta a non vantarsi; ognuno deve valutarsi invece « secondo la misura di fede che Dio gli ha dato » (Rm 12,3). Il credente impara a vedere se stesso a partire dalla fede che professa: la figura di Cristo è lo specchio in cui scopre la propria immagine realizzata. E come Cristo abbraccia in sé tutti i credenti, che formano il suo corpo, il cristiano comprende se stesso in questo corpo, in relazione originaria a Cristo e ai fratelli nella fede. L’immagine del corpo non vuole ridurre il credente a semplice parte di un tutto anonimo, a mero elemento di un grande ingranaggio, ma sottolinea piuttosto l’unione vitale di Cristo con i credenti e di tutti i credenti tra loro (cfr Rm 12,4-5). I cristiani sono “uno” (cfr Gal 3,28), senza perdere la loro individualità, e nel servizio agli altri ognuno guadagna fino in fondo il proprio essere. Si capisce allora perché fuori da questo corpo, da questa unità della Chiesa in Cristo, da questa Chiesa che — secondo le parole di Romano Guardini — « è la portatrice storica dello sguardo plenario di Cristo sul mondo »,[16] la fede perde la sua “misura”, non trova più il suo equilibrio, lo spazio necessario per sorreggersi. La fede ha una forma necessariamente ecclesiale, si confessa dall’interno del corpo di Cristo, come comunione concreta dei credenti. È da questo luogo ecclesiale che essa apre il singolo cristiano verso tutti gli uomini. La parola di Cristo, una volta ascoltata e per il suo stesso dinamismo, si trasforma nel cristiano in risposta, e diventa essa stessa parola pronunciata, confessione di fede. San Paolo afferma: « Con il cuore infatti si crede […], e con la bocca si fa la professione di fede… » (Rm 10,10). La fede non è un fatto privato, una concezione individualistica, un’opinione soggettiva, ma nasce da un ascolto ed è destinata a pronunciarsi e a diventare annuncio. Infatti, « come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? » (Rm 10,14). La fede si fa allora operante nel cristiano a partire dal dono ricevuto, dall’Amore che attira verso Cristo (cfr Gal 5,6) e rende partecipi del cammino della Chiesa, pellegrina nella storia verso il compimento. Per chi è stato trasformato in questo modo, si apre un nuovo modo di vedere, la fede diventa luce per i suoi occhi.
CAPITOLO SECONDO
SE NON CREDERETE,
NON COMPRENDERETE
(cfr Is 7,9)
Fede e verità
23. Se non crederete, non comprenderete (cfr Is 7,9). La versione greca della Bibbia ebraica, la traduzione dei Settanta realizzata in Alessandria d’Egitto, traduceva così le parole del profeta Isaia al re Acaz. In questo modo la questione della conoscenza della verità veniva messa al centro della fede. Nel testo ebraico, tuttavia, leggiamo diversamente. In esso il profeta dice al re: “Se non crederete, non resterete saldi”. C’è qui un gioco di parole con due forme del verbo ’amàn: “crederete” (ta’aminu), e “resterete saldi” (te’amenu). Impaurito dalla potenza dei suoi nemici, il re cerca la sicurezza che gli può dare un’alleanza con il grande impero di Assiria. Il profeta, allora, lo invita ad affidarsi soltanto alla vera roccia che non vacilla, il Dio di Israele. Poiché Dio è affidabile, è ragionevole avere fede in Lui, costruire la propria sicurezza sulla sua Parola. È questo il Dio che Isaia più avanti chiamerà, per due volte, “il Dio-Amen” (cfr Is 65,16), fondamento incrollabile di fedeltà all’alleanza. Si potrebbe pensare che la versione greca della Bibbia, nel tradurre “essere saldo” con “comprendere”, abbia operato un cambiamento profondo del testo, passando dalla nozione biblica di affidamento a Dio a quella greca della comprensione. Tuttavia, questa traduzione, che accettava certamente il dialogo con la cultura ellenistica, non è estranea alla dinamica profonda del testo ebraico. La saldezza che Isaia promette al re passa, infatti, per la comprensione dell’agire di Dio e dell’unità che Egli dà alla vita dell’uomo e alla storia del popolo. Il profeta esorta a comprendere le vie del Signore, trovando nella fedeltà di Dio il piano di saggezza che governa i secoli. Sant’Agostino ha espresso la sintesi del “comprendere” e dell’”essere saldo” nelle sue Confessioni, quando parla della verità, cui ci si può affidare per poter restare in piedi: « Sarò saldo e mi consoliderò in te, […] nella tua verità ».[17] Dal contesto sappiamo che sant’Agostino vuole mostrare il modo in cui questa verità affidabile di Dio è, come emerge nella Bibbia, la sua presenza fedele lungo la storia, la sua capacità di tenere insieme i tempi, raccogliendo la dispersione dei giorni dell’uomo.[18]
24. Il testo di Isaia, letto in questa luce, porta a una conclusione: l’uomo ha bisogno di conoscenza, ha bisogno di verità, perché senza di essa non si sostiene, non va avanti. La fede, senza verità, non salva, non rende sicuri i nostri passi. Resta una bella fiaba, la proiezione dei nostri desideri di felicità, qualcosa che ci accontenta solo nella misura in cui vogliamo illuderci. Oppure si riduce a un bel sentimento, che consola e riscalda, ma resta soggetto al mutarsi del nostro animo, alla variabilità dei tempi, incapace di sorreggere un cammino costante nella vita. Se la fede fosse così, il re Acaz avrebbe ragione a non giocare la sua vita e la sicurezza del suo regno su di un’emozione. Ma proprio per il suo nesso intrinseco con la verità, la fede è capace di offrire una luce nuova, superiore ai calcoli del re, perché essa vede più lontano, perché comprende l’agire di Dio, che è fedele alla sua alleanza e alle sue promesse.
25. Richiamare la connessione della fede con la verità è oggi più che mai necessario, proprio per la crisi di verità in cui viviamo. Nella cultura contemporanea si tende spesso ad accettare come verità solo quella della tecnologia: è vero ciò che l’uomo riesce a costruire e misurare con la sua scienza, vero perché funziona, e così rende più comoda e agevole la vita. Questa sembra oggi l’unica verità certa, l’unica condivisibile con altri, l’unica su cui si può discutere e impegnarsi insieme. Dall’altra parte vi sarebbero poi le verità del singolo, che consistono nell’essere autentici davanti a quello che ognuno sente nel suo interno, valide solo per l’individuo e che non possono essere proposte agli altri con la pretesa di servire il bene comune. La verità grande, la verità che spiega l’insieme della vita personale e sociale, è guardata con sospetto. Non è stata forse questa — ci si domanda — la verità pretesa dai grandi totalitarismi del secolo scorso, una verità che imponeva la propria concezione globale per schiacciare la storia concreta del singolo? Rimane allora solo un relativismo in cui la domanda sulla verità di tutto, che è in fondo anche la domanda su Dio, non interessa più. È logico, in questa prospettiva, che si voglia togliere la connessione della religione con la verità, perché questo nesso sarebbe alla radice del fanatismo, che vuole sopraffare chi non condivide la propria credenza. Possiamo parlare, a questo riguardo, di un grande oblio nel nostro mondo contemporaneo. La domanda sulla verità è, infatti, una questione di memoria, di memoria profonda, perché si rivolge a qualcosa che ci precede e, in questo modo, può riuscire a unirci oltre il nostro “io” piccolo e limitato. È una domanda sull’origine di tutto, alla cui luce si può vedere la meta e così anche il senso della strada comune.
Conoscenza della verità e amore
26. In questa situazione, può la fede cristiana offrire un servizio al bene comune circa il modo giusto di intendere la verità? Per rispondere è necessario riflettere sul tipo di conoscenza proprio della fede. Può aiutarci un’espressione di san Paolo, quando afferma: « Con il cuore si crede » (Rm 10,10). Il cuore, nella Bibbia, è il centro dell’uomo, dove s’intrecciano tutte le sue dimensioni: il corpo e lo spirito; l’interiorità della persona e la sua apertura al mondo e agli altri; l’intelletto, il volere, l’affettività. Ebbene, se il cuore è capace di tenere insieme queste dimensioni, è perché esso è il luogo dove ci apriamo alla verità e all’amore e lasciamo che ci tocchino e ci trasformino nel profondo. La fede trasforma la persona intera, appunto in quanto essa si apre all’amore. È in questo intreccio della fede con l’amore che si comprende la forma di conoscenza propria della fede, la sua forza di convinzione, la sua capacità di illuminare i nostri passi. La fede conosce in quanto è legata all’amore, in quanto l’amore stesso porta una luce. La comprensione della fede è quella che nasce quando riceviamo il grande amore di Dio che ci trasforma interiormente e ci dona occhi nuovi per vedere la realtà.
27. È noto il modo in cui il filosofo Ludwig Wittgenstein ha spiegato la connessione tra la fede e la certezza. Credere sarebbe simile, secondo lui, all’esperienza dell’innamoramento, concepita come qualcosa di soggettivo, improponibile come verità valida per tutti.[19] All’uomo moderno sembra, infatti, che la questione dell’amore non abbia a che fare con il vero. L’amore risulta oggi un’esperienza legata al mondo dei sentimenti incostanti e non più alla verità.
Davvero questa è una descrizione adeguata dell’amore? In realtà, l’amore non si può ridurre a un sentimento che va e viene. Esso tocca, sì, la nostra affettività, ma per aprirla alla persona amata e iniziare così un cammino, che è un uscire dalla chiusura nel proprio io e andare verso l’altra persona, per edificare un rapporto duraturo; l’amore mira all’unione con la persona amata. Si rivela allora in che senso l’amore ha bisogno di verità. Solo in quanto è fondato sulla verità l’amore può perdurare nel tempo, superare l’istante effimero e rimanere saldo per sostenere un cammino comune. Se l’amore non ha rapporto con la verità, è soggetto al mutare dei sentimenti e non supera la prova del tempo. L’amore vero invece unifica tutti gli elementi della nostra persona e diventa una luce nuova verso una vita grande e piena. Senza verità l’amore non può offrire un vincolo solido, non riesce a portare l’”io” al di là del suo isolamento, né a liberarlo dall’istante fugace per edificare la vita e portare frutto.
Se l’amore ha bisogno della verità, anche la verità ha bisogno dell’amore. Amore e verità non si possono separare. Senza amore, la verità diventa fredda, impersonale, oppressiva per la vita concreta della persona. La verità che cerchiamo, quella che offre significato ai nostri passi, ci illumina quando siamo toccati dall’amore. Chi ama capisce che l’amore è esperienza di verità, che esso stesso apre i nostri occhi per vedere tutta la realtà in modo nuovo, in unione con la persona amata. In questo senso, san Gregorio Magno ha scritto che « amor ipse notitia est », l’amore stesso è una conoscenza, porta con sé una logica nuova.[20] Si tratta di un modo relazionale di guardare il mondo, che diventa conoscenza condivisa, visione nella visione dell’altro e visione comune su tutte le cose. Guglielmo di Saint Thierry, nel Medioevo, segue questa tradizione quando commenta un versetto del Cantico dei Cantici in cui l’amato dice all’amata: I tuoi occhi sono occhi di colomba (cfr Ct 1,15).[21] Questi due occhi, spiega Guglielmo, sono la ragione credente e l’amore, che diventano un solo occhio per giungere a contemplare Dio, quando l’intelletto si fa « intelletto di un amore illuminato ».[22]
28. Questa scoperta dell’amore come fonte di conoscenza, che appartiene all’esperienza originaria di ogni uomo, trova espressione autorevole nella concezione biblica della fede. Gustando l’amore con cui Dio lo ha scelto e lo ha generato come popolo, Israele arriva a comprendere l’unità del disegno divino, dall’origine al compimento. La conoscenza della fede, per il fatto di nascere dall’amore di Dio che stabilisce l’Alleanza, è conoscenza che illumina un cammino nella storia. È per questo, inoltre, che, nella Bibbia, verità e fedeltà vanno insieme: il Dio vero è il Dio fedele, Colui che mantiene le sue promesse e permette, nel tempo, di comprendere il suo disegno. Attraverso l’esperienza dei profeti, nel dolore dell’esilio e nella speranza di un ritorno definitivo alla città santa, Israele ha intuito che questa verità di Dio si estendeva oltre la propria storia, per abbracciare la storia intera del mondo, a cominciare dalla creazione. La conoscenza della fede illumina non solo il percorso particolare di un popolo, ma il corso intero del mondo creato, dalla sua origine alla sua consumazione.
La fede come ascolto e visione
29. Proprio perché la conoscenza della fede è legata all’alleanza di un Dio fedele, che intreccia un rapporto di amore con l’uomo e gli rivolge la Parola, essa è presentata dalla Bibbia come un ascolto, è associata al senso dell’udito. San Paolo userà una formula diventata classica: fides ex auditu, « la fede viene dall’ascolto » (Rm10,17). La conoscenza associata alla parola è sempre conoscenza personale, che riconosce la voce, si apre ad essa in libertà e la segue in obbedienza. Perciò san Paolo ha parlato dell’”obbedienza della fede” (cfr Rm 1,5; 16,26).[23] La fede è, inoltre, conoscenza legata al trascorrere del tempo, di cui la parola ha bisogno per pronunciarsi: è conoscenza che s’impara solo in un cammino di sequela. L’ascolto aiuta a raffigurare bene il nesso tra conoscenza e amore.
Per quanto concerne la conoscenza della verità, l’ascolto è stato a volte contrapposto alla visione, che sarebbe propria della cultura greca. La luce, se da una parte offre la contemplazione del tutto, cui l’uomo ha sempre aspirato, dall’altra non sembra lasciar spazio alla libertà, perché discende dal cielo e arriva direttamente all’occhio, senza chiedere che l’occhio risponda. Essa, inoltre, sembrerebbe invitare a una contemplazione statica, separata dal tempo concreto in cui l’uomo gode e soffre. Secondo questa concezione, l’approccio biblico alla conoscenza si opporrebbe a quello greco, che, nella ricerca di una comprensione completa del reale, ha collegato la conoscenza alla visione.
È invece chiaro che questa pretesa opposizione non corrisponde al dato biblico. L’Antico Testamento ha combinato ambedue i tipi di conoscenza, perché all’ascolto della Parola di Dio si unisce il desiderio di vedere il suo volto. In questo modo si è potuto sviluppare un dialogo con la cultura ellenistica, dialogo che appartiene al cuore della Scrittura. L’udito attesta la chiamata personale e l’obbedienza, e anche il fatto che la verità si rivela nel tempo; la vista offre la visione piena dell’intero percorso e permette di situarsi nel grande progetto di Dio; senza tale visione disporremmo solo di frammenti isolati di un tutto sconosciuto.
30. La connessione tra il vedere e l’ascoltare, come organi di conoscenza della fede, appare con la massima chiarezza nel Vangelo di Giovanni. Per il quarto Vangelo, credere è ascoltare e, allo stesso tempo, vedere. L’ascolto della fede avviene secondo la forma di conoscenza propria dell’amore: è un ascolto personale, che distingue la voce e riconosce quella del Buon Pastore (cfr Gv 10,3-5); un ascolto che richiede la sequela, come accade con i primi discepoli che, « sentendolo parlare così, seguirono Gesù » (Gv 1,37). D’altra parte, la fede è collegata anche alla visione. A volte, la visione dei segni di Gesù precede la fede, come con i giudei che, dopo la risurrezione di Lazzaro, « alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui » (Gv 11,45). Altre volte, è la fede che porta a una visione più profonda: « Se crederai, vedrai la gloria di Dio » (Gv 11,40). Alla fine, credere e vedere s’intrecciano: « Chi crede in me […] crede in colui che mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha mandato » (Gv 12,44-45). Grazie a quest’unione con l’ascolto, il vedere diventa sequela di Cristo, e la fede appare come un cammino dello sguardo, in cui gli occhi si abituano a vedere in profondità. E così, il mattino di Pasqua, si passa da Giovanni che, ancora nel buio, davanti al sepolcro vuoto, “vide e credette” (Gv 20,8); a Maria Maddalena che, ormai, vede Gesù (cfr Gv 20,14) e vuole trattenerlo, ma è invitata a contemplarlo nel suo cammino verso il Padre; fino alla piena confessione della stessa Maddalena davanti ai discepoli: « Ho visto il Signore! » (Gv 20,18).
Come si arriva a questa sintesi tra l’udire e il vedere? Diventa possibile a partire dalla persona concreta di Gesù, che si vede e si ascolta. Egli è la Parola fatta carne, di cui abbiamo contemplato la gloria (cfr Gv 1,14). La luce della fede è quella di un Volto in cui si vede il Padre. Infatti, la verità che la fede coglie è, nel quarto Vangelo, la manifestazione del Padre nel Figlio, nella sua carne e nelle sue opere terrene, verità che si può definire come la “vita luminosa” di Gesù.[24] Ciò significa che la conoscenza della fede non ci invita a guardare una verità puramente interiore. La verità che la fede ci dischiude è una verità centrata sull’incontro con Cristo, sulla contemplazione della sua vita, sulla percezione della sua presenza. In questo senso, san Tommaso d’Aquino parla dell’oculata fides degli Apostoli — fede che vede! — davanti alla visione corporea del Risorto.[25] Hanno visto Gesù risorto con i loro occhi e hanno creduto, hanno, cioè, potuto penetrare nella profondità di quello che vedevano per confessare il Figlio di Dio, seduto alla destra del Padre.
31. Soltanto così, attraverso l’Incarnazione, attraverso la condivisione della nostra umanità, poteva giungere a pienezza la conoscenza propria dell’amore. La luce dell’amore, infatti, nasce quando siamo toccati nel cuore, ricevendo così in noi la presenza interiore dell’amato, che ci permette di riconoscere il suo mistero. Capiamo allora perché, insieme all’ascoltare e al vedere, la fede è, per san Giovanni, un toccare, come afferma nella sua prima Lettera: « Quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto […] e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita… » (1 Gv 1,1). Con la sua Incarnazione, con la sua venuta tra noi, Gesù ci ha toccato e, attraverso i Sacramenti, anche oggi ci tocca; in questo modo, trasformando il nostro cuore, ci ha permesso e ci permette di riconoscerlo e di confessarlo come Figlio di Dio. Con la fede, noi possiamo toccarlo, e ricevere la potenza della sua grazia. Sant’Agostino, commentando il passo dell’emorroissa che tocca Gesù per essere guarita (cfr Lc 8,45-46), afferma: « Toccare con il cuore, questo è credere ».[26] La folla si stringe attorno a Lui, ma non lo raggiunge con il tocco personale della fede, che riconosce il suo mistero, il suo essere Figlio che manifesta il Padre. Solo quando siamo configurati a Gesù, riceviamo occhi adeguati per vederlo.
Il dialogo tra fede e ragione
32. La fede cristiana, in quanto annuncia la verità dell’amore totale di Dio e apre alla potenza di questo amore, arriva al centro più profondo dell’esperienza di ogni uomo, che viene alla luce grazie all’amore ed è chiamato ad amare per rimanere nella luce. Mossi dal desiderio di illuminare tutta la realtà a partire dall’amore di Dio manifestato in Gesù, cercando di amare con quello stesso amore, i primi cristiani trovarono nel mondo greco, nella sua fame di verità, un partner idoneo per il dialogo. L’incontro del messaggio evangelico con il pensiero filosofico del mondo antico costituì un passaggio decisivo affinché il Vangelo arrivasse a tutti i popoli, e favorì una feconda interazione tra fede e ragione, che si è andata sviluppando nel corso dei secoli, fino ai nostri giorni. Il beato Giovanni Paolo II, nella sua Lettera enciclica Fides et ratio, ha mostrato come fede e ragione si rafforzino a vicenda.[27] Quando troviamo la luce piena dell’amore di Gesù, scopriamo che in ogni nostro amore era presente un barlume di quella luce e capiamo qual era il suo traguardo ultimo. E, nello stesso tempo, il fatto che il nostro amore porti con sé una luce, ci aiuta a vedere il cammino dell’amore verso la pienezza di donazione totale del Figlio di Dio per noi. In questo movimento circolare, la luce della fede illumina tutti i nostri rapporti umani, che possono essere vissuti in unione con l’amore e la tenerezza di Cristo.
33. Nella vita di sant’Agostino, troviamo un esempio significativo di questo cammino in cui la ricerca della ragione, con il suo desiderio di verità e di chiarezza, è stata integrata nell’orizzonte della fede, da cui ha ricevuto nuova comprensione. Da una parte, egli accoglie la filosofia greca della luce con la sua insistenza sulla visione. Il suo incontro con il neoplatonismo gli ha fatto conoscere il paradigma della luce, che discende dall’alto per illuminare le cose, ed è così un simbolo di Dio. In questo modo sant’Agostino ha capito la trascendenza divina e ha scoperto che tutte le cose hanno in sé una trasparenza, che potevano cioè riflettere la bontà di Dio, il Bene. Si è così liberato dal manicheismo in cui prima viveva e che lo inclinava a pensare che il male e il bene lottassero continuamente tra loro, confondendosi e mescolandosi, senza contorni chiari. Capire che Dio è luce gli ha dato un orientamento nuovo nell’esistenza, la capacità di riconoscere il male di cui era colpevole e di volgersi verso il bene.
D’altra parte, però, nell’esperienza concreta di sant’Agostino, che egli stesso racconta nelle sue Confessioni, il momento decisivo nel suo cammino di fede non è stato quello di una visione di Dio, oltre questo mondo, ma piuttosto quello dell’ascolto, quando nel giardino sentì una voce che gli diceva: “Prendi e leggi”; egli prese il volume con le Lettere di san Paolo soffermandosi sul capitolo tredicesimo di quella ai Romani.[28] Appariva così il Dio personale della Bibbia, capace di parlare all’uomo, di scendere a vivere con lui e di accompagnare il suo cammino nella storia, manifestandosi nel tempo dell’ascolto e della risposta.
E tuttavia, questo incontro con il Dio della Parola non ha portato sant’Agostino a rifiutare la luce e la visione. Egli ha integrato ambedue le prospettive, guidato sempre dalla rivelazione dell’amore di Dio in Gesù. E così ha elaborato una filosofia della luce che accoglie in sé la reciprocità propria della parola e apre uno spazio alla libertà dello sguardo verso la luce. Come alla parola corrisponde una risposta libera, così la luce trova come risposta un’immagine che la riflette. Sant’Agostino può riferirsi allora, associando ascolto e visione, alla « parola che risplende all’interno dell’uomo ».[29] In questo modo la luce diventa, per così dire, la luce di una parola, perché è la luce di un Volto personale, una luce che, illuminandoci, ci chiama e vuole riflettersi nel nostro volto per risplendere dal di dentro di noi. D’altronde, il desiderio della visione del tutto, e non solo dei frammenti della storia, rimane presente e si compirà alla fine, quando l’uomo, come dice il Santo di Ippona, vedrà e amerà.[30] E questo, non perché sarà capace di possedere tutta la luce, che sempre sarà inesauribile, ma perché entrerà, tutto intero, nella luce.
34. La luce dell’amore, propria della fede, può illuminare gli interrogativi del nostro tempo sulla verità. La verità oggi è ridotta spesso ad autenticità soggettiva del singolo, valida solo per la vita individuale. Una verità comune ci fa paura, perché la identifichiamo con l’imposizione intransigente dei totalitarismi. Se però la verità è la verità dell’amore, se è la verità che si schiude nell’incontro personale con l’Altro e con gli altri, allora resta liberata dalla chiusura nel singolo e può fare parte del bene comune. Essendo la verità di un amore, non è verità che s’imponga con la violenza, non è verità che schiaccia il singolo. Nascendo dall’amore può arrivare al cuore, al centro personale di ogni uomo. Risulta chiaro così che la fede non è intransigente, ma cresce nella convivenza che rispetta l’altro. Il credente non è arrogante; al contrario, la verità lo fa umile, sapendo che, più che possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci possiede. Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza della fede ci mette in cammino, e rende possibile la testimonianza e il dialogo con tutti.
D’altra parte, la luce della fede, in quanto unita alla verità dell’amore, non è aliena al mondo materiale, perché l’amore si vive sempre in corpo e anima; la luce della fede è luce incarnata, che procede dalla vita luminosa di Gesù. Essa illumina anche la materia, confida nel suo ordine, conosce che in essa si apre un cammino di armonia e di comprensione sempre più ampio. Lo sguardo della scienza riceve così un beneficio dalla fede: questa invita lo scienziato a rimanere aperto alla realtà, in tutta la sua ricchezza inesauribile. La fede risveglia il senso critico, in quanto impedisce alla ricerca di essere soddisfatta nelle sue formule e la aiuta a capire che la natura è sempre più grande. Invitando alla meraviglia davanti al mistero del creato, la fede allarga gli orizzonti della ragione per illuminare meglio il mondo che si schiude agli studi della scienza.
La fede e la ricerca di Dio
35. La luce della fede in Gesù illumina anche il cammino di tutti coloro che cercano Dio, e offre il contributo proprio del cristianesimo nel dialogo con i seguaci delle diverse religioni. La Lettera agli Ebrei ci parla della testimonianza dei giusti che, prima dell’Alleanza con Abramo, già cercavano Dio con fede. Di Enoc si dice che « fu dichiarato persona gradita a Dio » (Eb 11,5), cosa impossibile senza la fede, perché chi « si avvicina a Dio, deve credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano » (Eb 11,6). Possiamo così capire che il cammino dell’uomo religioso passa per la confessione di un Dio che si prende cura di lui e che non è impossibile trovare. Quale altra ricompensa potrebbe offrire Dio a coloro che lo cercano, se non lasciarsi incontrare? Prima ancora, troviamo la figura di Abele, di cui pure si loda la fede a causa della quale Dio ha gradito i suoi doni, l’offerta dei primogeniti dei suoi greggi (cfr Eb 11,4). L’uomo religioso cerca di riconoscere i segni di Dio nelle esperienze quotidiane della sua vita, nel ciclo delle stagioni, nella fecondità della terra e in tutto il movimento del cosmo. Dio è luminoso, e può essere trovato anche da coloro che lo cercano con cuore sincero.
Immagine di questa ricerca sono i Magi, guidati dalla stella fino a Betlemme (cfr Mt 2,1-12). Per loro la luce di Dio si è mostrata come cammino, come stella che guida lungo una strada di scoperte. La stella parla così della pazienza di Dio con i nostri occhi, che devono abituarsi al suo splendore. L’uomo religioso è in cammino e deve essere pronto a lasciarsi guidare, a uscire da sé per trovare il Dio che sorprende sempre. Questo rispetto di Dio per gli occhi dell’uomo ci mostra che, quando l’uomo si avvicina a Lui, la luce umana non si dissolve nell’immensità luminosa di Dio, come se fosse una stella inghiottita dall’alba, ma diventa più brillante quanto è più prossima al fuoco originario, come lo specchio che riflette lo splendore. La confessione cristiana di Gesù, unico salvatore, afferma che tutta la luce di Dio si è concentrata in Lui, nella sua “vita luminosa”, in cui si svela l’origine e la consumazione della storia.[31] Non c’è nessuna esperienza umana, nessun itinerario dell’uomo verso Dio, che non possa essere accolto, illuminato e purificato da questa luce. Quanto più il cristiano s’immerge nel cerchio aperto dalla luce di Cristo, tanto più è capace di capire e di accompagnare la strada di ogni uomo verso Dio.
Poiché la fede si configura come via, essa riguarda anche la vita degli uomini che, pur non credendo, desiderano credere e non cessano di cercare. Nella misura in cui si aprono all’amore con cuore sincero e si mettono in cammino con quella luce che riescono a cogliere, già vivono, senza saperlo, nella strada verso la fede. Essi cercano di agire come se Dio esistesse, a volte perché riconoscono la sua importanza per trovare orientamenti saldi nella vita comune, oppure perché sperimentano il desiderio di luce in mezzo al buio, ma anche perché, nel percepire quanto è grande e bella la vita, intuiscono che la presenza di Dio la renderebbe ancora più grande. Racconta sant’Ireneo di Lione che Abramo, prima di ascoltare la voce di Dio, già lo cercava « nell’ardente desiderio del suo cuore », e « percorreva tutto il mondo, domandandosi dove fosse Dio », finché « Dio ebbe pietà di colui che, solo, lo cercava nel silenzio ».[32] Chi si mette in cammino per praticare il bene si avvicina già a Dio, è già sorretto dal suo aiuto, perché è proprio della dinamica della luce divina illuminare i nostri occhi quando camminiamo verso la pienezza dell’amore.
Fede e teologia
36. Poiché la fede è una luce, ci invita a inoltrarci in essa, a esplorare sempre di più l’orizzonte che illumina, per conoscere meglio ciò che amiamo. Da questo desiderio nasce la teologia cristiana. È chiaro allora che la teologia è impossibile senza la fede e che essa appartiene al movimento stesso della fede, che cerca l’intelligenza più profonda dell’autorivelazione di Dio, culminata nel Mistero di Cristo. La prima conseguenza è che nella teologia non si dà solo uno sforzo della ragione per scrutare e conoscere, come nelle scienze sperimentali. Dio non si può ridurre ad oggetto. Egli è Soggetto che si fa conoscere e si manifesta nel rapporto da persona a persona. La fede retta orienta la ragione ad aprirsi alla luce che viene da Dio, affinché essa, guidata dall’amore per la verità, possa conoscere Dio in modo più profondo. I grandi dottori e teologi medievali hanno indicato che la teologia, come scienza della fede, è una partecipazione alla conoscenza che Dio ha di se stesso. La teologia, allora, non è soltanto parola su Dio, ma prima di tutto accoglienza e ricerca di un’intelligenza più profonda di quella parola che Dio ci rivolge, parola che Dio pronuncia su se stesso, perché è un dialogo eterno di comunione, e ammette l’uomo all’interno di questo dialogo.[33] Fa parte allora della teologia l’umiltà che si lascia “toccare” da Dio, riconosce i suoi limiti di fronte al Mistero e si spinge ad esplorare, con la disciplina propria della ragione, le insondabili ricchezze di questo Mistero.
La teologia poi condivide la forma ecclesiale della fede; la sua luce è la luce del soggetto credente che è la Chiesa. Ciò implica, da una parte, che la teologia sia al servizio della fede dei cristiani, si metta umilmente a custodire e ad approfondire il credere di tutti, soprattutto dei più semplici. Inoltre, la teologia, poiché vive della fede, non consideri il Magistero del Papa e dei Vescovi in comunione con lui come qualcosa di estrinseco, un limite alla sua libertà, ma, al contrario, come uno dei suoi momenti interni, costitutivi, in quanto il Magistero assicura il contatto con la fonte originaria, e offre dunque la certezza di attingere alla Parola di Cristo nella sua integrità.
CAPITOLO TERZO
VI TRASMETTO
QUELLO CHE HO RICEVUTO
(cfr 1 Cor 15,3)
La Chiesa, madre della nostra fede
37. Chi si è aperto all’amore di Dio, ha ascoltato la sua voce e ha ricevuto la sua luce, non può tenere questo dono per sé. Poiché la fede è ascolto e visione, essa si trasmette anche come parola e come luce. Parlando ai Corinzi, l’Apostolo Paolo ha usato proprio queste due immagini. Da un lato, egli dice: « Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo » (2 Cor 4,13). La parola ricevuta si fa risposta, confessione e, in questo modo, risuona per gli altri, invitandoli a credere. Dall’altro, san Paolo si riferisce anche alla luce: « Riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine » (2 Cor 3,18). È una luce che si rispecchia di volto in volto, come Mosè portava in sé il riflesso della gloria di Dio dopo aver parlato con Lui: « [Dio] rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo » (2 Cor 4,6). La luce di Gesù brilla, come in uno specchio, sul volto dei cristiani e così si diffonde, così arriva fino a noi, perché anche noi possiamo partecipare a questa visione e riflettere ad altri la sua luce, come nella liturgia di Pasqua la luce del cero accende tante altre candele. La fede si trasmette, per così dire, nella forma del contatto, da persona a persona, come una fiamma si accende da un’altra fiamma. I cristiani, nella loro povertà, piantano un seme così fecondo che diventa un grande albero ed è capace di riempire il mondo di frutti.
38. La trasmissione della fede, che brilla per tutti gli uomini di tutti i luoghi, passa anche attraverso l’asse del tempo, di generazione in generazione. Poiché la fede nasce da un incontro che accade nella storia e illumina il nostro cammino nel tempo, essa si deve trasmettere lungo i secoli. È attraverso una catena ininterrotta di testimonianze che arriva a noi il volto di Gesù. Come è possibile questo? Come essere sicuri di attingere al “vero Gesù”, attraverso i secoli? Se l’uomo fosse un individuo isolato, se volessimo partire soltanto dall’”io” individuale, che vuole trovare in sé la sicurezza della sua conoscenza, questa certezza sarebbe impossibile. Non posso vedere da me stesso quello che è accaduto in un’epoca così distante da me. Non è questo, tuttavia, l’unico modo in cui l’uomo conosce. La persona vive sempre in relazione. Viene da altri, appartiene ad altri, la sua vita si fa più grande nell’incontro con altri. E anche la propria conoscenza, la stessa coscienza di sé, è di tipo relazionale, ed è legata ad altri che ci hanno preceduto: in primo luogo i nostri genitori, che ci hanno dato la vita e il nome. Il linguaggio stesso, le parole con cui interpretiamo la nostra vita e la nostra realtà, ci arriva attraverso altri, preservato nella memoria viva di altri. La conoscenza di noi stessi è possibile solo quando partecipiamo a una memoria più grande. Avviene così anche nella fede, che porta a pienezza il modo umano di comprendere. Il passato della fede, quell’atto di amore di Gesù che ha generato nel mondo una nuova vita, ci arriva nella memoria di altri, dei testimoni, conservato vivo in quel soggetto unico di memoria che è la Chiesa. La Chiesa è una Madre che ci insegna a parlare il linguaggio della fede. San Giovanni ha insistito su quest’aspetto nel suo Vangelo, unendo assieme fede e memoria, e associando ambedue all’azione dello Spirito Santo che, come dice Gesù, « vi ricorderà tutto » (Gv 14,26). L’Amore che è lo Spirito, e che dimora nella Chiesa, mantiene uniti tra di loro tutti i tempi e ci rende contemporanei di Gesù, diventando così la guida del nostro camminare nella fede.
39. È impossibile credere da soli. La fede non è solo un’opzione individuale che avviene nell’interiorità del credente, non è rapporto isolato tra l’”io” del fedele e il “Tu” divino, tra il soggetto autonomo e Dio. Essa si apre, per sua natura, al “noi”, avviene sempre all’interno della comunione della Chiesa. La forma dialogata del Credo, usata nella liturgia battesimale, ce lo ricorda. Il credere si esprime come risposta a un invito, ad una parola che deve essere ascoltata e non procede da me, e per questo si inserisce all’interno di un dialogo, non può essere una mera confessione che nasce dal singolo. È possibile rispondere in prima persona, “credo”, solo perché si appartiene a una comunione grande, solo perché si dice anche “crediamo”. Questa apertura al “noi” ecclesiale avviene secondo l’apertura propria dell’amore di Dio, che non è solo rapporto tra Padre e Figlio, tra “io” e “tu”, ma nello Spirito è anche un “noi”, una comunione di persone. Ecco perché chi crede non è mai solo, e perché la fede tende a diffondersi, ad invitare altri alla sua gioia. Chi riceve la fede scopre che gli spazi del suo “io” si allargano, e si generano in lui nuove relazioni che arricchiscono la vita. Tertulliano l’ha espresso con efficacia parlando del catecumeno, che “dopo il lavacro della nuova nascita” è accolto nella casa della Madre per stendere le mani e pregare, insieme ai fratelli, il Padre nostro, come accolto in una nuova famiglia.[34]
I Sacramenti e la trasmissione della fede
40. La Chiesa, come ogni famiglia, trasmette ai suoi figli il contenuto della sua memoria. Come farlo, in modo che niente si perda e che, al contrario, tutto si approfondisca sempre più nell’eredità della fede? È attraverso la Tradizione Apostolica conservata nella Chiesa con l’assistenza dello Spirito Santo, che noi abbiamo un contatto vivo con la memoria fondante. E quanto è stato trasmesso dagli Apostoli — come afferma il Concilio Vaticano II — « racchiude tutto quello che serve per vivere la vita santa e per accrescere la fede del Popolo di Dio, e così nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto la Chiesa perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede ».[35]
La fede, infatti, ha bisogno di un ambito in cui si possa testimoniare e comunicare, e che questo sia corrispondente e proporzionato a ciò che si comunica. Per trasmettere un contenuto meramente dottrinale, un’idea, forse basterebbe un libro, o la ripetizione di un messaggio orale. Ma ciò che si comunica nella Chiesa, ciò che si trasmette nella sua Tradizione vivente, è la luce nuova che nasce dall’incontro con il Dio vivo, una luce che tocca la persona nel suo centro, nel cuore, coinvolgendo la sua mente, il suo volere e la sua affettività, aprendola a relazioni vive nella comunione con Dio e con gli altri. Per trasmettere tale pienezza esiste un mezzo speciale, che mette in gioco tutta la persona, corpo e spirito, interiorità e relazioni. Questo mezzo sono i Sacramenti, celebrati nella liturgia della Chiesa. In essi si comunica una memoria incarnata, legata ai luoghi e ai tempi della vita, associata a tutti i sensi; in essi la persona è coinvolta, in quanto membro di un soggetto vivo, in un tessuto di relazioni comunitarie. Per questo, se è vero che i Sacramenti sono i Sacramenti della fede,[36] si deve anche dire che la fede ha una struttura sacramentale. Il risveglio della fede passa per il risveglio di un nuovo senso sacramentale della vita dell’uomo e dell’esistenza cristiana, mostrando come il visibile e il materiale si aprono verso il mistero dell’eterno.
41. La trasmissione della fede avviene in primo luogo attraverso il Battesimo. Potrebbe sembrare che il Battesimo sia solo un modo per simbolizzare la confessione di fede, un atto pedagogico per chi ha bisogno di immagini e gesti, ma da cui, in fondo, si potrebbe prescindere. Una parola di san Paolo, a proposito del Battesimo, ci ricorda che non è così. Egli afferma che « per mezzo del battesimo siamo […] sepolti insieme a Cristo nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova » (Rm 6,4). Nel Battesimo diventiamo nuova creatura e figli adottivi di Dio. L’Apostolo afferma poi che il cristiano è stato affidato a una “forma di insegnamento” (typos didachés), cui obbedisce di cuore (cfr Rm 6,17). Nel Battesimo l’uomo riceve anche una dottrina da professare e una forma concreta di vita che richiede il coinvolgimento di tutta la sua persona e lo incammina verso il bene. Viene trasferito in un ambito nuovo, affidato a un nuovo ambiente, a un nuovo modo di agire comune, nella Chiesa. Il Battesimo ci ricorda così che la fede non è opera dell’individuo isolato, non è un atto che l’uomo possa compiere contando solo sulle proprie forze, ma deve essere ricevuta, entrando nella comunione ecclesiale che trasmette il dono di Dio: nessuno battezza se stesso, così come nessuno nasce da solo all’esistenza. Siamo stati battezzati.
42. Quali sono gli elementi battesimali che ci introducono in questa nuova “forma di insegnamento”? Sul catecumeno s’invoca in primo luogo il nome della Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. Si offre così fin dall’inizio una sintesi del cammino della fede. Il Dio che ha chiamato Abramo e ha voluto chiamarsi suo Dio; il Dio che ha rivelato il suo nome a Mosè; il Dio che nel consegnarci suo Figlio ci ha rivelato pienamente il mistero del suo Nome, dona al battezzato una nuova identità filiale. Appare in questo modo il senso dell’azione che si compie nel Battesimo, l’immersione nell’acqua: l’acqua è, allo stesso tempo, simbolo di morte, che ci invita a passare per la conversione dell’”io”, in vista della sua apertura a un “Io” più grande; ma è anche simbolo di vita, del grembo in cui rinasciamo seguendo Cristo nella sua nuova esistenza. In questo modo, attraverso l’immersione nell’acqua, il Battesimo ci parla della struttura incarnata della fede. L’azione di Cristo ci tocca nella nostra realtà personale, trasformandoci radicalmente, rendendoci figli adottivi di Dio, partecipi della natura divina; modifica così tutti i nostri rapporti, la nostra situazione concreta nel mondo e nel cosmo, aprendoli alla sua stessa vita di comunione. Questo dinamismo di trasformazione proprio del Battesimo ci aiuta a cogliere l’importanza del catecumenato, che oggi, anche nelle società di antiche radici cristiane, nelle quali un numero crescente di adulti si avvicina al sacramento battesimale, riveste un’importanza singolare per la nuova evangelizzazione. È la strada di preparazione al Battesimo, alla trasformazione dell’intera esistenza in Cristo.
Per comprendere la connessione tra Battesimo e fede, ci può essere di aiuto ricordare un testo del profeta Isaia, che è stato associato al Battesimo nell’antica letteratura cristiana: « Fortezze rocciose saranno il suo rifugio […] la sua acqua sarà assicurata » (Is 33,16).[37] Il battezzato, riscattato dall’acqua della morte, poteva ergersi in piedi sulla “roccia forte”, perché aveva trovato la saldezza cui affidarsi. Così, l’acqua di morte si è trasformata in acqua di vita. Il testo greco la descriveva come acqua pistós, acqua “fedele”. L’acqua del Battesimo è fedele perché ad essa ci si può affidare, perché la sua corrente immette nella dinamica di amore di Gesù, fonte di sicurezza per il nostro cammino nella vita.
43. La struttura del Battesimo, la sua configurazione come rinascita, in cui riceviamo un nuovo nome e una nuova vita, ci aiuta a capire il senso e l’importanza del Battesimo dei bambini. Il bambino non è capace di un atto libero che accolga la fede, non può confessarla ancora da solo, e proprio per questo essa è confessata dai suoi genitori e dai padrini in suo nome. La fede è vissuta all’interno della comunità della Chiesa, è inserita in un “noi” comune. Così, il bambino può essere sostenuto da altri, dai suoi genitori e padrini, e può essere accolto nella loro fede, che è la fede della Chiesa, simbolizzata dalla luce che il padre attinge dal cero nella liturgia battesimale. Questa struttura del Battesimo evidenzia l’importanza della sinergia tra la Chiesa e la famiglia nella trasmissione della fede. I genitori sono chiamati, secondo una parola di sant’Agostino, non solo a generare i figli alla vita, ma a portarli a Dio affinché, attraverso il Battesimo, siano rigenerati come figli di Dio, ricevano il dono della fede.[38] Così, insieme alla vita, viene dato loro l’orientamento fondamentale dell’esistenza e la sicurezza di un futuro buono, orientamento che verrà ulteriormente corroborato nel Sacramento della Confermazione con il sigillo dello Spirito Santo.
44. La natura sacramentale della fede trova la sua espressione massima nell’Eucaristia. Essa è nutrimento prezioso della fede, incontro con Cristo presente in modo reale con l’atto supremo di amore, il dono di Se stesso che genera vita.
Nell’Eucaristia troviamo l’incrocio dei due assi su cui la fede percorre il suo cammino. Da una parte, l’asse della storia: l’Eucaristia è atto di memoria, attualizzazione del mistero, in cui il passato, come evento di morte e risurrezione, mostra la sua capacità di aprire al futuro, di anticipare la pienezza finale. La liturgia ce lo ricorda con il suo hodie, l’”oggi” dei misteri della salvezza. D’altra parte, si trova qui anche l’asse che conduce dal mondo visibile verso l’invisibile. Nell’Eucaristia impariamo a vedere la profondità del reale. Il pane e il vino si trasformano nel corpo e sangue di Cristo, che si fa presente nel suo cammino pasquale verso il Padre: questo movimento ci introduce, corpo e anima, nel movimento di tutto il creato verso la sua pienezza in Dio.
45. Nella celebrazione dei Sacramenti, la Chiesa trasmette la sua memoria, in particolare, con la professione di fede. In essa, non si tratta tanto di prestare l’assenso a un insieme di verità astratte. Al contrario, nella confessione di fede tutta la vita entra in un cammino verso la comunione piena con il Dio vivente. Possiamo dire che nel Credo il credente viene invitato a entrare nel mistero che professa e a lasciarsi trasformare da ciò che professa. Per capire il senso di questa affermazione, pensiamo anzitutto al contenuto del Credo. Esso ha una struttura trinitaria: il Padre e il Figlio si uniscono nello Spirito di amore. Il credente afferma così che il centro dell’essere, il segreto più profondo di tutte le cose, è la comunione divina. Inoltre, il Credo contiene anche una confessione cristologica: si ripercorrono i misteri della vita di Gesù, fino alla sua Morte, Risurrezione e Ascensione al Cielo, nell’attesa della sua venuta finale nella gloria. Si dice, dunque, che questo Dio comunione, scambio di amore tra Padre e Figlio nello Spirito, è capace di abbracciare la storia dell’uomo, di introdurlo nel suo dinamismo di comunione, che ha nel Padre la sua origine e la sua mèta finale. Colui che confessa la fede, si vede coinvolto nella verità che confessa. Non può pronunciare con verità le parole del Credo, senza essere per ciò stesso trasformato, senza immettersi nella storia di amore che lo abbraccia, che dilata il suo essere rendendolo parte di una comunione grande, del soggetto ultimo che pronuncia il Credo e che è la Chiesa. Tutte le verità che si credono dicono il mistero della nuova vita della fede come cammino di comunione con il Dio vivente.
Fede, preghiera e Decalogo
46. Altri due elementi sono essenziali nella trasmissione fedele della memoria della Chiesa. In primo luogo, la preghiera del Signore, il Padre nostro. In essa il cristiano impara a condividere la stessa esperienza spirituale di Cristo e incomincia a vedere con gli occhi di Cristo. A partire da Colui che è Luce da Luce, dal Figlio Unigenito del Padre, conosciamo Dio anche noi e possiamo accendere in altri il desiderio di avvicinarsi a Lui.
È altrettanto importante, inoltre, la connessione tra la fede e il Decalogo. La fede, abbiamo detto, appare come un cammino, una strada da percorrere, aperta dall’incontro con il Dio vivente. Per questo, alla luce della fede, dell’affidamento totale al Dio che salva, il Decalogo acquista la sua verità più profonda, contenuta nelle parole che introducono i dieci comandamenti: « Io sono il tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto » (Es 20,2). Il Decalogo non è un insieme di precetti negativi, ma di indicazioni concrete per uscire dal deserto dell’ “io” autoreferenziale, chiuso in se stesso, ed entrare in dialogo con Dio, lasciandosi abbracciare dalla sua misericordia per portare la sua misericordia. La fede confessa così l’amore di Dio, origine e sostegno di tutto, si lascia muovere da questo amore per camminare verso la pienezza della comunione con Dio. Il Decalogo appare come il cammino della gratitudine, della risposta di amore, possibile perché, nella fede, ci siamo aperti all’esperienza dell’amore trasformante di Dio per noi. E questo cammino riceve una nuova luce da quanto Gesù insegna nel Discorso della Montagna (cfr Mt 5-7).
Ho toccato così i quattro elementi che riassumono il tesoro di memoria che la Chiesa trasmette: la Confessione di fede, la celebrazione dei Sacramenti, il cammino del Decalogo, la preghiera. La catechesi della Chiesa si è strutturata tradizionalmente attorno ad essi, incluso il Catechismo della Chiesa Cattolica, strumento fondamentale per quell’atto unitario con cui la Chiesa comunica il contenuto intero della fede, « tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede ».[39]
L’unità e l’integrità della fede
47. L’unità della Chiesa, nel tempo e nello spazio, è collegata all’unità della fede: « Un solo corpo e un solo spirito […] una sola fede » (Ef 4, 4-5).Oggi può sembrare realizzabile un’unione degli uomini in un impegno comune, nel volersi bene, nel condividere una stessa sorte, in una meta comune. Ma ci risulta molto difficile concepire un’unità nella stessa verità. Ci sembra che un’unione del genere si opponga alla libertà del pensiero e all’autonomia del soggetto. L’esperienza dell’amore ci dice invece che proprio nell’amore è possibile avere una visione comune, che in esso impariamo a vedere la realtà con gli occhi dell’altro, e che ciò non ci impoverisce, ma arricchisce il nostro sguardo. L’amore vero, a misura dell’amore divino, esige la verità e nello sguardo comune della verità, che è Gesù Cristo, diventa saldo e profondo. Questa è anche la gioia della fede, l’unità di visione in un solo corpo e in un solo spirito. In questo senso san Leone Magno poteva affermare: « Se la fede non è una, non è fede ».[40]
Qual è il segreto di questa unità? La fede è “una”, in primo luogo, per l’unità del Dio conosciuto e confessato. Tutti gli articoli di fede si riferiscono a Lui, sono vie per conoscere il suo essere e il suo agire, e per questo possiedono un’unità superiore a qualsiasi altra che possiamo costruire con il nostro pensiero, possiedono l’unità che ci arricchisce, perché si comunica a noi e ci rende “uno”.
La fede è una, inoltre, perché si rivolge all’unico Signore, alla vita di Gesù, alla sua storia concreta che condivide con noi. Sant’Ireneo di Lione l’ha chiarito in opposizione agli eretici gnostici. Costoro sostenevano l’esistenza di due tipi di fede, una fede rozza, la fede dei semplici, imperfetta, che si manteneva al livello della carne di Cristo e della contemplazione dei suoi misteri; e un altro tipo di fede più profondo e perfetto, la fede vera riservata a una piccola cerchia di iniziati che si elevava con l’intelletto al di là della carne di Gesù verso i misteri della divinità ignota. Davanti a questa pretesa, che continua ad avere il suo fascino e i suoi seguaci anche ai nostri giorni, sant’Ireneo ribadisce che la fede è una sola, perché passa sempre per il punto concreto dell’Incarnazione, senza superare mai la carne e la storia di Cristo, dal momento che Dio si è voluto rivelare pienamente in essa. È per questo che non c’è differenza nella fede tra “colui che è in grado di parlarne più a lungo” e “colui che ne parla poco”, tra colui che è superiore e chi è meno capace: né il primo può ampliare la fede, né il secondo diminuirla.[41]
Infine, la fede è una perché è condivisa da tutta la Chiesa, che è un solo corpo e un solo Spirito. Nella comunione dell’unico soggetto che è la Chiesa, riceviamo uno sguardo comune. Confessando la stessa fede poggiamo sulla stessa roccia, siamo trasformati dallo stesso Spirito d’amore, irradiamo un’unica luce e abbiamo un unico sguardo per penetrare la realtà.
48. Dato che la fede è una sola, deve essere confessata in tutta la sua purezza e integrità. Proprio perché tutti gli articoli di fede sono collegati in unità, negare uno di essi, anche di quelli che sembrerebbero meno importanti, equivale a danneggiare il tutto. Ogni epoca può trovare punti della fede più facili o difficili da accettare: per questo è importante vigilare perché si trasmetta tutto il deposito della fede (cfr 1 Tm 6,20), perché si insista opportunamente su tutti gli aspetti della confessione di fede. Infatti, in quanto l’unità della fede è l’unità della Chiesa, togliere qualcosa alla fede è togliere qualcosa alla verità della comunione. I Padri hanno descritto la fede come un corpo, il corpo della verità, con diverse membra, in analogia con il corpo di Cristo e con il suo prolungamento nella Chiesa.[42] L’integrità della fede è stata legata anche all’immagine della Chiesa vergine, alla sua fedeltà nell’amore sponsale per Cristo: danneggiare la fede significa danneggiare la comunione con il Signore.[43] L’unità della fede è dunque quella di un organismo vivente, come ha ben rilevato il beato John Henry Newman quando enumerava, tra le note caratteristiche per distinguere la continuità della dottrina nel tempo, il suo potere di assimilare in sé tutto ciò che trova, nei diversi ambiti in cui si fa presente, nelle diverse culture che incontra,[44] tutto purificando e portando alla sua migliore espressione. La fede si mostra così universale, cattolica, perché la sua luce cresce per illuminare tutto il cosmo e tutta la storia.
49. Come servizio all’unità della fede e alla sua trasmissione integra, il Signore ha dato alla Chiesa il dono della successione apostolica. Per suo tramite, risulta garantita la continuità della memoria della Chiesa ed è possibile attingere con certezza alla fonte pura da cui la fede sorge. La garanzia della connessione con l’origine è data dunque da persone vive, e ciò corrisponde alla fede viva che la Chiesa trasmette. Essa poggia sulla fedeltà dei testimoni che sono stati scelti dal Signore per tale compito. Per questo il Magistero parla sempre in obbedienza alla Parola originaria su cui si basa la fede ed è affidabile perché si affida alla Parola che ascolta, custodisce ed espone.[45] Nel discorso di addio agli anziani di Efeso, a Mileto, raccolto da san Luca negli Atti degli Apostoli, san Paolo testimonia di aver compiuto l’incarico affidatogli dal Signore di annunciare « tutta la volontà di Dio » (At 20,27). È grazie al Magistero della Chiesa che ci può arrivare integra questa volontà, e con essa la gioia di poterla compiere in pienezza.
CAPITOLO QUARTO
DIO PREPARA PER LORO UNA CITTÀ
(cfr Eb 11,16)
La fede e il bene comune
50. Nel presentare la storia dei Patriarchi e dei giusti dell’Antico Testamento, la Lettera agli Ebrei pone in rilievo un aspetto essenziale della loro fede. Essa non si configura solo come un cammino, ma anche come l’edificazione, la preparazione di un luogo nel quale l’uomo possa abitare insieme con gli altri. Il primo costruttore è Noè che, nell’arca, riesce a salvare la sua famiglia (cfr Eb 11,7). Appare poi Abramo, di cui si dice che, per fede, abitava in tende, aspettando la città dalle salde fondamenta (cfr Eb 11,9-10). Sorge, dunque, in rapporto alla fede, una nuova affidabilità, una nuova solidità, che solo Dio può donare. Se l’uomo di fede poggia sul Dio-Amen, sul Dio fedele (cfr Is 65,16), e così diventa egli stesso saldo, possiamo aggiungere che la saldezza della fede si riferisce anche alla città che Dio sta preparando per l’uomo. La fede rivela quanto possono essere saldi i vincoli tra gli uomini, quando Dio si rende presente in mezzo ad essi. Non evoca soltanto una solidità interiore, una convinzione stabile del credente; la fede illumina anche i rapporti tra gli uomini, perché nasce dall’amore e segue la dinamica dell’amore di Dio. Il Dio affidabile dona agli uomini una città affidabile.
51. Proprio grazie alla sua connessione con l’amore (cfr Gal 5,6), la luce della fede si pone al servizio concreto della giustizia, del diritto e della pace. La fede nasce dall’incontro con l’amore originario di Dio in cui appare il senso e la bontà della nostra vita; questa viene illuminata nella misura in cui entra nel dinamismo aperto da quest’amore, in quanto diventa cioè cammino e pratica verso la pienezza dell’amore. La luce della fede è in grado di valorizzare la ricchezza delle relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di essere affidabili, di arricchire la vita comune. La fede non allontana dal mondo e non risulta estranea all’impegno concreto dei nostri contemporanei. Senza un amore affidabile nulla potrebbe tenere veramente uniti gli uomini. L’unità tra loro sarebbe concepibile solo come fondata sull’utilità, sulla composizione degli interessi, sulla paura, ma non sulla bontà di vivere insieme, non sulla gioia che la semplice presenza dell’altro può suscitare. La fede fa comprendere l’architettura dei rapporti umani, perché ne coglie il fondamento ultimo e il destino definitivo in Dio, nel suo amore, e così illumina l’arte dell’edificazione, diventando un servizio al bene comune. Sì, la fede è un bene per tutti, è un bene comune, la sua luce non illumina solo l’interno della Chiesa, né serve unicamente a costruire una città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare le nostre società, in modo che camminino verso un futuro di speranza. La Lettera agli Ebrei offre un esempio al riguardo quando, tra gli uomini di fede, nomina Samuele e Davide, ai quali la fede permise di « esercitare la giustizia » (Eb 11,33). L’espressione si riferisce qui alla loro giustizia nel governare, a quella saggezza che porta la pace al popolo (cfr 1 Sam 12,3-5; 2 Sam 8,15). Le mani della fede si alzano verso il cielo, ma lo fanno mentre edificano, nella carità, una città costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento.
La fede e la famiglia
52. Nel cammino di Abramo verso la città futura, la Lettera agli Ebrei accenna alla benedizione che si trasmette dai genitori ai figli (cfr Eb 11, 20-21). Il primo ambito in cui la fede illumina la città degli uomini si trova nella famiglia. Penso anzitutto all’unione stabile dell’uomo e della donna nel matrimonio. Essa nasce dal loro amore, segno e presenza dell’amore di Dio, dal riconoscimento e dall’accettazione della bontà della differenza sessuale, per cui i coniugi possono unirsi in una sola carne (cfr Gen 2,24) e sono capaci di generare una nuova vita, manifestazione della bontà del Creatore, della sua saggezza e del suo disegno di amore. Fondati su quest’amore, uomo e donna possono promettersi l’amore mutuo con un gesto che coinvolge tutta la vita e che ricorda tanti tratti della fede. Promettere un amore che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona amata. La fede poi aiuta a cogliere in tutta la sua profondità e ricchezza la generazione dei figli, perché fa riconoscere in essa l’amore creatore che ci dona e ci affida il mistero di una nuova persona. È così che Sara, per la sua fede, è diventata madre, contando sulla fedeltà di Dio alla sua promessa (cfr Eb 11,11).
53. In famiglia, la fede accompagna tutte le età della vita, a cominciare dall’infanzia: i bambini imparano a fidarsi dell’amore dei loro genitori. Per questo è importante che i genitori coltivino pratiche comuni di fede nella famiglia, che accompagnino la maturazione della fede dei figli. Soprattutto i giovani, che attraversano un’età della vita così complessa, ricca e importante per la fede, devono sentire la vicinanza e l’attenzione della famiglia e della comunità ecclesiale nel loro cammino di crescita nella fede. Tutti abbiamo visto come, nelle Giornate Mondiali della Gioventù, i giovani mostrino la gioia della fede, l’impegno di vivere una fede sempre più salda e generosa. I giovani hanno il desiderio di una vita grande. L’incontro con Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore allarga l’orizzonte dell’esistenza, le dona una speranza solida che non delude. La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, la vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra fragilità.
Una luce per la vita in società
54. Assimilata e approfondita in famiglia, la fede diventa luce per illuminare tutti i rapporti sociali. Come esperienza della paternità di Dio e della misericordia di Dio, si dilata poi in cammino fraterno. Nella “modernità” si è cercato di costruire la fraternità universale tra gli uomini, fondandosi sulla loro uguaglianza. A poco a poco, però, abbiamo compreso che questa fraternità, privata del riferimento a un Padre comune quale suo fondamento ultimo, non riesce a sussistere. Occorre dunque tornare alla vera radice della fraternità. La storia di fede, fin dal suo inizio, è stata una storia di fraternità, anche se non priva di conflitti. Dio chiama Abramo ad uscire dalla sua terra e gli promette di fare di lui un’unica grande nazione, un grande popolo, sul quale riposa la Benedizione divina (cfr Gen 12,1-3). Nel procedere della storia della salvezza, l’uomo scopre che Dio vuol far partecipare tutti, come fratelli, all’unica benedizione, che trova la sua pienezza in Gesù, affinché tutti diventino uno. L’amore inesauribile del Padre ci viene comunicato, in Gesù, anche attraverso la presenza del fratello. La fede ci insegna a vedere che in ogni uomo c’è una benedizione per me, che la luce del volto di Dio mi illumina attraverso il volto del fratello. Quanti benefici ha portato lo sguardo della fede cristiana alla città degli uomini per la loro vita comune! Grazie alla fede abbiamo capito la dignità unica della singola persona, che non era così evidente nel mondo antico. Nel secondo secolo, il pagano Celso rimproverava ai cristiani quello che a lui pareva un’illusione e un inganno: pensare che Dio avesse creato il mondo per l’uomo, ponendolo al vertice di tutto il cosmo. Si chiedeva allora: « Perché pretendere che [l’erba] cresca per gli uomini, e non meglio per i più selvatici degli animali senza ragione? »,[46] « Se guardiamo la terra dall’alto del cielo, che differenza offrirebbero le nostre attività e quelle delle formiche e delle api? ».[47] Al centro della fede biblica, c’è l’amore di Dio, la sua cura concreta per ogni persona, il suo disegno di salvezza che abbraccia tutta l’umanità e l’intera creazione e che raggiunge il vertice nell’Incarnazione, Morte e Risurrezione di Gesù Cristo. Quando questa realtà viene oscurata, viene a mancare il criterio per distinguere ciò che rende preziosa e unica la vita dell’uomo. Egli perde il suo posto nell’universo, si smarrisce nella natura, rinunciando alla propria responsabilità morale, oppure pretende di essere arbitro assoluto, attribuendosi un potere di manipolazione senza limiti.
55. La fede, inoltre, nel rivelarci l’amore di Dio Creatore, ci fa rispettare maggiormente la natura, facendoci riconoscere in essa una grammatica da Lui scritta e una dimora a noi affidata perché sia coltivata e custodita; ci aiuta a trovare modelli di sviluppo che non si basino solo sull’utilità e sul profitto, ma che considerino il creato come dono, di cui tutti siamo debitori; ci insegna a individuare forme giuste di governo, riconoscendo che l’autorità viene da Dio per essere al servizio del bene comune. La fede afferma anche la possibilità del perdono, che necessita molte volte di tempo, di fatica, di pazienza e di impegno; perdono possibile se si scopre che il bene è sempre più originario e più forte del male, che la parola con cui Dio afferma la nostra vita è più profonda di tutte le nostre negazioni. Anche da un punto di vista semplicemente antropologico, d’altronde, l’unità è superiore al conflitto; dobbiamo farci carico anche del conflitto, ma il viverlo deve portarci a risolverlo, a superarlo, trasformandolo in un anello di una catena, in uno sviluppo verso l’unità.
Quando la fede viene meno, c’è il rischio che anche i fondamenti del vivere vengano meno, come ammoniva il poeta T. S. Eliot: « Avete forse bisogno che vi si dica che perfino quei modesti successi / che vi permettono di essere fieri di una società educata / difficilmente sopravviveranno alla fede a cui devono il loro significato? ».[48] Se togliamo la fede in Dio dalle nostre città, si affievolirà la fiducia tra di noi, ci terremmo uniti soltanto per paura, e la stabilità sarebbe minacciata. La Lettera agli Ebrei afferma: « Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città » (Eb 11,16). L’espressione “non vergognarsi” è associata a un riconoscimento pubblico. Si vuol dire che Dio confessa pubblicamente, con il suo agire concreto, la sua presenza tra noi, il suo desiderio di rendere saldi i rapporti tra gli uomini. Saremo forse noi a vergognarci di chiamare Dio il nostro Dio? Saremo noi a non confessarlo come tale nella nostra vita pubblica, a non proporre la grandezza della vita comune che Egli rende possibile? La fede illumina il vivere sociale; essa possiede una luce creativa per ogni momento nuovo della storia, perché colloca tutti gli eventi in rapporto con l’origine e il destino di tutto nel Padre che ci ama.
Una forza consolante nella sofferenza
56. San Paolo scrivendo ai cristiani di Corinto delle sue tribolazioni e delle sue sofferenze mette in relazione la sua fede con la predicazione del Vangelo. Dice, infatti che in lui si compie il passo della Scrittura: « Ho creduto, perciò ho parlato » (2 Cor 4,13). L’Apostolo si riferisce ad un’espressione del Salmo 116, in cui il Salmista esclama: « Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice » (v. 10). Parlare della fede spesso comporta parlare anche di prove dolorose, ma appunto in esse san Paolo vede l’annuncio più convincente del Vangelo, perché è nella debolezza e nella sofferenza che emerge e si scopre la potenza di Dio che supera la nostra debolezza e la nostra sofferenza. L’Apostolo stesso si trova in una situazione di morte, che diventerà vita per i cristiani (cfr 2 Cor 4,7-12). Nell’ora della prova, la fede ci illumina, e proprio nella sofferenza e nella debolezza si rende chiaro come « noi […] non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore » (2 Cor 4,5). Il capitolo 11 della Lettera agli Ebrei si conclude con il riferimento a coloro che hanno sofferto per la fede (cfr Eb 11, 35-38), tra i quali un posto particolare lo occupa Mosè, che ha preso su di sé l’oltraggio del Cristo (cfr v. 26). Il cristiano sa che la sofferenza non può essere eliminata, ma può ricevere un senso, può diventare atto di amore, affidamento alle mani di Dio che non ci abbandona e, in questo modo, essere una tappa di crescita della fede e dell’amore. Contemplando l’unione di Cristo con il Padre, anche nel momento della sofferenza più grande sulla croce (cfr Mc 15,34), il cristiano impara a partecipare allo sguardo stesso di Gesù. Perfino la morte risulta illuminata e può essere vissuta come l’ultima chiamata della fede, l’ultimo “Esci dalla tua terra” (Gen 12,1), l’ultimo “Vieni!” pronunciato dal Padre, cui ci consegniamo con la fiducia che Egli ci renderà saldi anche nel passo definitivo.
57. La luce della fede non ci fa dimenticare le sofferenze del mondo. Per quanti uomini e donne di fede i sofferenti sono stati mediatori di luce! Così per san Francesco d’Assisi il lebbroso, o per la Beata Madre Teresa di Calcutta i suoi poveri. Hanno capito il mistero che c’è in loro. Avvicinandosi ad essi non hanno certo cancellato tutte le loro sofferenze, né hanno potuto spiegare ogni male. La fede non è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma lampada che guida nella notte i nostri passi, e questo basta per il cammino. All’uomo che soffre, Dio non dona un ragionamento che spieghi tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una presenza che accompagna, di una storia di bene che si unisce ad ogni storia di sofferenza per aprire in essa un varco di luce. In Cristo, Dio stesso ha voluto condividere con noi questa strada e offrirci il suo sguardo per vedere in essa la luce. Cristo è colui che, avendo sopportato il dolore, « dà origine alla fede e la porta a compimento » (Eb 12,2).
La sofferenza ci ricorda che il servizio della fede al bene comune è sempre servizio di speranza, che guarda in avanti, sapendo che solo da Dio, dal futuro che viene da Gesù risorto, può trovare fondamenta solide e durature la nostra società. In questo senso, la fede è congiunta alla speranza perché, anche se la nostra dimora quaggiù si va distruggendo, c’è una dimora eterna che Dio ha ormai inaugurato in Cristo, nel suo corpo (cfr 2 Cor 4,16–5,5). Il dinamismo di fede, speranza e carità (cfr 1 Ts 1,3; 1 Cor 13,13) ci fa così abbracciare le preoccupazioni di tutti gli uomini, nel nostro cammino verso quella città, « il cui architetto e costruttore è Dio stesso » (Eb 11,10), perché « la speranza non delude » (Rm 5,5).
Nell’unità con la fede e la carità, la speranza ci proietta verso un futuro certo, che si colloca in una prospettiva diversa rispetto alle proposte illusorie degli idoli del mondo, ma che dona nuovo slancio e nuova forza al vivere quotidiano. Non facciamoci rubare la speranza, non permettiamo che sia vanificata con soluzioni e proposte immediate che ci bloccano nel cammino, che “frammentano” il tempo, trasformandolo in spazio. Il tempo è sempre superiore allo spazio. Lo spazio cristallizza i processi, il tempo proietta invece verso il futuro e spinge a camminare con speranza.
Beata colei che ha creduto (Lc 1,45)
58. Nella parabola del seminatore, san Luca riporta queste parole con cui Gesù spiega il significato del “terreno buono”: « Sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza » (Lc 8,15). Nel contesto del Vangelo di Luca, la menzione del cuore integro e buono, in riferimento alla Parola ascoltata e custodita, costituisce un ritratto implicito della fede della Vergine Maria. Lo stesso evangelista ci parla della memoria di Maria, di come conservava nel cuore tutto ciò che ascoltava e vedeva, in modo che la Parola portasse frutto nella sua vita. La Madre del Signore è icona perfetta della fede, come dirà santa Elisabetta: « Beata colei che ha creduto » (Lc 1,45).
In Maria, Figlia di Sion, si compie la lunga storia di fede dell’Antico Testamento, con il racconto di tante donne fedeli, a cominciare da Sara, donne che, accanto ai Patriarchi, erano il luogo in cui la promessa di Dio si compiva, e la vita nuova sbocciava. Nella pienezza dei tempi, la Parola di Dio si è rivolta a Maria, ed ella l’ha accolta con tutto il suo essere, nel suo cuore, perché in lei prendesse carne e nascesse come luce per gli uomini. San Giustino Martire, nel suo Dialogo con Trifone, ha una bella espressione in cui dice che Maria, nell’accettare il messaggio dell’Angelo, ha concepito “fede e gioia”.[49] Nella Madre di Gesù, infatti, la fede si è mostrata piena di frutto, e quando la nostra vita spirituale dà frutto, ci riem-piamo di gioia, che è il segno più chiaro della grandezza della fede. Nella sua vita, Maria ha compiuto il pellegrinaggio della fede, alla sequela di suo Figlio.[50] Così, in Maria, il cammino di fede dell’Antico Testamento è assunto nella sequela di Gesù e si lascia trasformare da Lui, entrando nello sguardo proprio del Figlio di Dio incarnato.
59. Possiamo dire che nella Beata Vergine Maria si avvera ciò su cui ho in precedenza insistito, vale a dire che il credente è coinvolto totalmente nella sua confessione di fede. Maria è strettamente associata, per il suo legame con Gesù, a ciò che crediamo. Nel concepimento verginale di Maria abbiamo un segno chiaro della filiazione divina di Cristo. L’origine eterna di Cristo è nel Padre, Egli è il Figlio in senso totale e unico; e per questo nasce nel tempo senza intervento di uomo. Essendo Figlio, Gesù può portare al mondo un nuovo inizio e una nuova luce, la pienezza dell’amore fedele di Dio che si consegna agli uomini. D’altra parte, la vera maternità di Maria ha assicurato per il Figlio di Dio una vera storia umana, una vera carne nella quale morirà sulla croce e risorgerà dai morti. Maria lo accompagnerà fino alla croce (cfr Gv 19,25), da dove la sua maternità si estenderà ad ogni discepolo del suo Figlio (cfr Gv 19,26-27). Sarà presente anche nel cenacolo, dopo la Risurrezione e l’Ascensione di Gesù, per implorare con gli Apostoli il dono dello Spirito Santo (cfr At 1,14). Il movimento di amore tra il Padre e il Figlio nello Spirito ha percorso la nostra storia; Cristo ci attira a Sé per poterci salvare (cfr Gv 12,32). Al centro della fede si trova la confessione di Gesù, Figlio di Dio, nato da donna, che ci introduce, per il dono dello Spirito Santo, nella figliolanza adottiva (cfr Gal 4,4-6).
60. A Maria, madre della Chiesa e madre della nostra fede, ci rivolgiamo in preghiera.
Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. E che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!
Dato a Roma, presso San Pietro, il 29 giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dell’anno 2013, primo di Pontificato.
FRANCISCUS
[1] Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 121, 2: PG 6, 758.
[2] Clemente Alessandrino, Protrepticus, IX: PG 8, 195.
[3] Brief an Elisabeth Nietzsche (11 giugno 1865), in: Werke in drei Bänden, München 1954, 953s.
[4] Paradiso XXIV, 145-147.
[5] Acta Sanctorum, Iunii, I, 21.
[6] “Se il Concilio non tratta espressamente della fede, ne parla ad ogni pagina, ne riconosce il carattere vitale e soprannaturale, la suppone integra e forte, e costruisce su di essa le sue dottrine. Basterebbe ricordare le affermazioni conciliari […] per rendersi conto dell’essenziale importanza che il Concilio, coerente con la tradizione dottrinale della Chiesa, attribuisce alla fede, alla vera fede, quella che ha per sorgente Cristo e per canale il magistero della Chiesa” (Paolo VI, Udienza generale [8 marzo 1967]: Insegnamenti V [1967], 705).
[7] Cfr ad es. Conc. Ecum. Vat. i, Cost dogm. sulla fede cattolica Dei Filius, cap. III: DS 3008-3020; Conc. Ecum. Vat. II, Cost dogm. sulla divina Rivelazione Dei Verbum, 5; Catechismo della Chiesa Cattolica, 153-165.
[8] Cfr Catechesis V, 1: PG 33, 505A.
[9] In Psal. 32, II, s. I, 9: PL 36, 284.
[10] M. Buber, Die Erzählungen der Chassidim, Zürich 1949, 793.
[11] Émile, Paris 1966, 387.
[12] Lettre à Christophe de Beaumont, Lausanne 1993, 110.
[13] Cfr In Ioh. Evang., 45, 9: PL 35, 1722-1723.
[14] Parte II, IV.
[15] De continentia, 4, 11: PL 40, 356.
[16] Vom Wesen katholischer Weltanschauung (1923), in: Unterscheidung des Christlichen. Gesammelte Studien 1923-1963, Mainz 1963, 24.
[17] XI, 30, 40: PL 32, 825.
[18] Cfr ibid., 825-826.
[19] Cfr Vermischte Bemerkungen / Culture and Value, G.H. von Wright (a cura di), Oxford 1991, 32-33; 61-64.
[20] Homiliae in Evangelia, II, 27, 4: PL 76, 1207.
[21] Cfr Expositio super Cantica Canticorum, XVIII, 88: CCL, Continuatio Mediaevalis 87, 67.
[22] Ibid., XIX, 90: CCL, Continuatio Mediaevalis 87, 69.
[23] « A Dio che rivela è dovuta “l’obbedienza della fede” (Rm 16,26; cfr Rm 1,5; 2 Cor 10,5-6), con la quale l’uomo gli si abbandona tutt’intero e liberamente prestandogli il pieno ossequio dell’intelletto e della volontà e assentendo volontariamente alla Rivelazione che egli fa. Perché si possa prestare questa fede, sono necessari la grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi dello spirito e dia a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità. Affinché poi l’intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito Santo perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni » (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla divina Rivelazione Dei Verbum, 5).
[24] Cfr H. Schlier, Meditationen über den Johanneischen Begriff der Wahrheit, in: Besinnung auf das Neue Testament. Exegetische Aufsätze und Vorträge 2, Freiburg, Basel, Wien 1959, 272.
[25] Cfr S. Th. III, q. 55, a. 2, ad 1.
[26] Sermo 229/L, 2: PLS 2, 576: “Tangere autem corde, hoc est credere“.
[27] Cfr Lett. enc. Fides et ratio (14 settembre 1998), 73: AAS (1999), 61-62.
[28] Cfr Confessiones, VIII, 12, 29: PL 32, 762.
[29] De Trinitate, XV, 11, 20: PL 42, 1071: “verbum quod intus lucet“.
[30] Cfr De civitate Dei, XXII, 30, 5: PL 41, 804.
[31] Cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Dominus Iesus (6 agosto 2000), 15: AAS 92 (2000), 756.
[32] Demonstratio apostolicae praedicationis, 24: SC 406, 117.
[33] Cfr Bonaventura, Breviloquium, prol.: Opera Omnia, V, Quaracchi 1891, p. 201; In I Sent., proem, q. 1, resp.: Opera Omnia, I, Quaracchi 1891, p. 7; Tommaso d’Aquino, S. Th. I, q. 1.
[34] Cfr De Baptismo, 20, 5: CCL 1, 295.
[35] Cost. dogm. sulla divina Rivelazione Dei Verbum, 8.
[36] Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, 59.
[37] Cfr Epistula Barnabae, 11, 5: SC 172, 162.
[38] Cfr De nuptiis et concupiscentia, I, 4, 5: PL 44, 413: “Habent quippe intentionem generandi regenerandos, ut qui ex eis saeculi filii nascuntur in Dei filios renascantur“.
[39] Conc. Ecum Vat. II, Cost. dogm. sulla divina Rivelazione Dei Verbum, 8.
[40] In nativitate Domini sermo 4, 6: SC 22, 110.
[41] Cfr Ireneo, Adversus haereses, I, 10, 2: SC 264, 160.
[42] Cfr ibid., II, 27, 1: SC 294, 264.
[43] Cfr Agostino, De sancta virginitate, 48, 48: PL 40,424-425: “Servatur et in fide inviolata quaedam castitas virginalis, qua Ecclesia uni viro virgo casta cooptatur“.
[44] Cfr An Essay on the Development of Christian Doctrine, Uniform Edition: Longmans, Green and Company, London, 1868-1881, 185-189.
[45] Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla divina Rivelazione Dei Verbum, 10.
[46] Origene, Contra Celsum, IV, 75: SC 136, 372.
[47] Ibid., 85: SC 136, 394.
[48] “Choruses from The Rock” in: The Collected Poems and Plays 1909-1950, New York 1980, 106.
[49] Cfr Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 100, 5: PG 6, 710.
[50] Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 58.