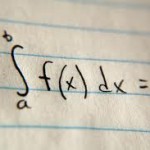Prima lettura: Apocalisse 7,2-4.9-14
|
Io, Giovanni, vidi salire dall’oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: «Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio». E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti da ogni tribù dei figli d’Israele. Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello». |
Davvero il santo è merce rara, come qualcuno va pessimisticamente dicendo? La prima lettura risponde abbattendo statistiche tendenti al ribasso.
Dopo la solenne scenografia celeste (cf. cap. 4) e la migliore comprensione del senso della vita e della storia grazie all’intervento dell’Agnello (cf. cap. 5), inizia la progressiva apertura dei sette sigilli che rendevano finora inaccessibile il libro (cf. cap. 6). La storia è striata di sangue e di sofferenza, ma non affidata ad un cieco destino di morte. Coloro che stanno dalla parte di Dio e dell’Agnello non sono risparmiati dalla sofferenza e neppure dalla morte fisica, sono però risparmiati dalla distruzione totale e dall’annientamento. La loro vita non cade nell’oblio, perché accolta e trasfigurata.
Tre tappe scandiscono il brano: il sigillo impresso al gruppo dei 144.000 (vv. 2-4), il gruppo internazionale dei salvati (vv. 9-12) e la loro identità (vv. 13-14). All’inizio viene ritardato l’intervento punitivo dei 4 angeli, per permettere a un quinto di segnare il numero degli eletti. Rielaborando una scena del profeta Ezechiele (cf. Ez 8-10), l’autore proclama la salvezza che raggiunge il resto di Israele, computato in 144.000, cioè 12.000 per tribù (elencate nei vv. 5-8, tralasciati dal testo liturgico). Il numero, più qualitativo che quantitativo, viene dal prodotto di 12 (numero delle tribù di Israele), per 12 (numero degli apostoli, continuatori dell’antico popolo ma anche fondamento del nuovo), per 1.000 (numero di grandezza divina); esso designa una grande quantità di salvati provenienti dal giudaismo. (Per alcuni autori — per esempio Prigent — si tratterebbe dei cristiani nella loro totalità; Ap 14,3 ripropone il numero e parla di «i redenti della terra»).
Distinto dal precedente si pone un altro gruppo, questa volta internazionale, impossibile a quantificarsi perché «moltitudine immensa, che nessuno poteva contare». Alcune precisazioni valgono per una loro prima identificazione (cf. v. 9: stanno in piedi, perché sono vivi come l’Agnello con il quale sono posti in relazione (gli stanno davanti), indossano vesti bianche (colore che li accomuna al mondo del divino e in modo particolare alla risurrezione di Cristo) e reggono delle palme (segno che condividono con Lui la vittoria sul male e godono della pienezza della vita); in seguito saranno identificati con maggior precisione. Di loro viene riferito il canto celebrativo che accomuna Dio e Agnello, segno evidente di una perfetta comunione esistente tra i due esseri, cui viene attribuito il merito della salvezza. Alla celebrazione si associa praticamente tutta la corte celeste in una dossologia che comprende 7 titoli (numero della pienezza). Infine, l’espediente della domanda del vegliardo, elemento tipico del genere letterario apocalittico, favorisce la piena decodificazione dei salvati: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello» (v. 14). I salvati sono pertanto coloro che traggono origine (ieri, oggi e sempre) dalla morte redentrice di Gesù (la «grande tribolazione»). Sono i santi che partecipano ora alla liturgia celeste, condividendo una vita di piena comunione, dopo aver partecipato, durante la vita mortale, alla passione di Cristo.
Seconda lettura: 1 Giovanni 3,1-3
|
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro. |
La santità è amore. La lettera che celebra l’amore di Dio e dell’uomo ci propone la fonte dell’amore e, di conseguenza, la fonte della santità.
I vv. 1-2 sono il canto entusiastico della comunità che si scopre già fin d’ora figlia del Padre che sta nei cieli: «quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!». Il testo non parla di Cristo, ma di lui hanno trattato i due capitoli precedenti e non si dà amore del Padre se non in Cristo. Il legame a lui stacca e isola la comunità dal mondo, qui inteso come la realtà negativa che si oppone a Dio; il mondo è principio di non-amore, di non-santità. Esiste quindi una incompatibilità radicale, perché i credenti sono abilitati ad una dignità di figli che li nobilita. L’amore divino è realtà che previene e che investe l’uomo, recandogli un dono inatteso e impensabile. Dio è sorgente dell’amore e quindi di ogni santità che è nell’uomo il riflesso di Dio. Se i vv. 1-2 suscitano e alimentano la nostalgia della santità, ad un impegno personalizzato sollecita il versetto successivo.
Infatti, proprio alla possibilità di rendere efficace tale riflesso, pensa il v. 3 che completa il quadro indicando l’impegno della comunità per rispondere al dono divino. Così dalla contemplazione stupita ed ammirata di quello che Dio è e fa, si passa alla collaborazione dell’uomo che accoglie responsabilmente il dono. Uno strumento privilegiato di accoglienza è la continua purificazione, atteggiamento di conversione necessario per lasciarsi invadere da Dio: «Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro» (v. 3). Al gloriarsi della propria dignità di figli ricevuta in dono, segue l’adeguamento che è lo sforzo continuo fatto di piccole trasformazioni. Conversione è l’imperativo affidato all’uomo, dopo che gli è stato comunicato l’indicativo (realtà) della sua condizione di figlio: «purificare se stesso» vuole dire rendersi pronti alla sequela di Cristo, andare con lui incontro al Padre. Adottato questo principio di vita, si capisce il seguito, non registrato dalla lettura odierna, del cristiano che non pecca, ovviamente perché si sviluppa in lui quel «germe divino» (v. 9) che è il principio di santità, la vita stessa di Dio, che lo rende figlio nel Figlio.
Vangelo: Matteo 5,1-12a
|
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». |
Esegesi
Il brano delle beatitudini elettrizza la odierna liturgia della parola. Esso inaugura il discorso del monte, il primo dei cinque grandi discorsi che strutturano il vangelo di Matteo. È la prima parte del primo discorso, cioè l’intonazione di tutte le parole di Gesù. Si comprende subito l’importanza attribuita dall’evangelista a questo proclama, chiamato senza troppa enfasi la magna charta, del cristianesimo. Lo potremmo quindi intendere come il suo manifesto, la sua carta costituzionale. E come in ogni stato la Costituzione è l’elemento sorgivo e strutturante delle varie componenti, una stella polare cui fare sempre riferimento, così il brano delle beatitudini caratterizza lo statuto cristiano. Il richiamo ad esso dovrà essere continuo e costante per non smarrire mai la bussola della propria identità. L’evangelista Matteo prepara il lettore con una concentrazione di particolari: è sulla montagna che Gesù presenta il suo pensiero, esattamente come Mosè aveva ricevuto le disposizioni divine sul monte Sinai; Gesù si pone a sedere assumendo l’atteggiamento dell’autorità che legifera; attorno sta il gruppo dei discepoli che non ricevono una informazione o una comunicazione, ma un insegnamento che dovrà poi trasformarsi in vita vissuta (cf. Mt 5,1.2).
Se già la presentazione era solenne, l’impressione di maestosa autorevolezza promana ora dal messaggio, ritmato da una serie di «beati». Il termine ‘felice’ ‘beato’ (makàrios in greco, da cui il nome proprio Macario e il termine ‘macarismo’ per indicare la beatitudine o
felicità) si trova 50 volte nel NT, ma collegato in forma litania compare solo nel nostro brano e nel passo parallelo di Luca che crea il contrasto tra 4 beatitudini e 4 guai (cf. Lc 6,20-26). Proclamando le beatitudini, Gesù riprende in parte lo stile dell’AT: sono dichiarati felici gli uomini che vivono secondo le regole dettate dalla sapienza (cf. Sir 25,7-10); nei salmi è proclamato beato l’uomo che teme (= ama) il Signore, dimostrando tale amore con l’osservanza della sua volontà espressa nella sua legge (cf. Sal 128,1; 1,1). Difficilmente si trovano due beatitudini insieme e mai sono ad esse associati i guai come nella combinazione di Luca.
Nel giudaismo di poco anteriore a Gesù è dato trovare, come nel nostro caso, la presenza di una sequenza di beatitudini e anche la loro combinazione con i ‘guai’: questi si spiegano forse per la viva speranza dei tempi ultimi. Sempre in tale contesto si incontra il discorso diretto («voi»), sconosciuto all’AT e presente in Mt 5,11. A differenza dell’AT, non ci sono frasi secondarie che specificano le beatitudini.
Pur con qualche somiglianza letteraria con l’AT e con il giudaismo, possiamo affermare l’originalità della presentazione di Matteo. Troviamo infatti due gruppi di quattro beatitudini che si corrispondono anche nel numero delle parole. Nel primo gruppo si presenta per lo più una condizione di sofferenza, nel secondo un determinato comportamento. I vv. 11-12 sono diversi: in essi compare il discorso diretto e forse sono una rielaborazione redazionale in forma di beatitudine di un detto di Gesù. Dobbiamo senz’altro riconoscere la novità assoluta e senza precedenti del contenuto. Diversamente dalla prospettiva della letteratura sapienziale che additava una salvezza futura e terrena. Gesù annuncia una salvezza presente e senza restrizioni: tutti hanno accesso alla felicità, a condizione che siano legati a lui. Sganciati da lui, le beatitudini non hanno senso. È lui ad inserire coloro che lo seguono nella condizione di cittadini del regno, di figli di Dio.
Le beatitudini sono piccole frasi che si intrecciano come una litania per proclamare una felicità davvero strana: «Beati i poveri in spirito… beati gli afflitti…». Dopo averle ascoltate, non sarà difficile essere presi da uno shock. Proclamare la felicità dei poveri, degli affamati, dei perseguitati sembra una evidente e sconcertante falsità che cozza contro la più elementare esperienza. Sarebbe come dichiarare che la loro disgrazia vale una benedizione: da qui alla mistificazione il passo è breve, perché sembra una buona soluzione per mantenere le cose allo stato di fissità, senza tentarne un miglioramento. L’accusa di conservatorismo arriva subito e facilmente. Si potrebbe aggiungere pure la volontà di sottrarre l’uomo alle responsabilità e agli impegni che lo ancorano al presente. Così, ad una prima reazione, il proclama delle beatitudini diventa il manifesto di una mortificante sclerosi che certo non onora Dio e che impoverisce l’uomo. Sotto la bandiera di un sublime ideale si fa passare un ordine invertito di valori umani.
Che cosa possiamo rispondere?
Le beatitudini sono proclamate da Gesù che annuncia solo quello che vive. Sarebbe sorprendente che un uomo che tutti riconoscono di una inimitabile coerenza abbia iniziato la sua predicazione (così in Matteo) con un clamoroso bluff. Le beatitudini sono il prisma che rinfrange non solo l’attitudine, ma anche i veri atteggiamenti di Lui.
La prima cosa da sapere e da imparare consiste nella convinzione che la felicità attinge al mondo interiore. La felicità nasce dall’anima stessa; non si trova per strada, non si compra né si vende. Essa è un’attitudine interiore che risveglia un comportamento visibile. Le beatitudini sono un appello a cambiare vita e prima ancora a modificare sensibilmente la propria mentalità. E questo avviene orientandosi verso Dio: ecco la realtà del «regno dei cieli» che apre la prima e la più importante delle beatitudini; ecco il passivo divino «saranno consolati» che andrebbe reso meglio «Dio li consolerà», mostrando anche nella traduzione che la fonte della consolazione è Dio stesso. Così di seguito, tutto rimanda a Dio.
La forza sta tutta qui: Gesù annuncia quello che egli vive. In lui si riscontra identità tra messaggio e messaggero, tra il dire, l’agire e l’essere. Il segreto dell’efficacia della sua missione sta nella totale identificazione col messaggio che annuncia: egli proclama la ‘buona novella’ non solo con quello che dice o fa, ma con quello che è. Ed egli è in perfetta comunione con il Padre, di cui esegue pienamente la volontà. Allora anche le difficoltà (o disgrazie) che accompagnano e segnano inesorabilmente la vita di ogni uomo, assumono un significato diverso prendono senso perché integrate in una vita che parte da Dio e che a Lui arriva. Questa è la santità.
Meditazione
Nella celebrazione di tutti i santi la Chiesa ascolta la promessa di Dio che la chiama a partecipare della sua stessa santità, e ricorda, che tale è la vocazione di ogni battezzato. Se la liturgia ci fa fare oggi memoria di tutti i santi nel loro insieme, non è tanto per la preoccupazione di dimenticarne qualcuno, o per integrare il numero di coloro che vengono ricordati nelle singole celebrazioni durante l’anno liturgico, quanto per affermare il carattere universale della chiamata alla santità. I santi sono come «primizie per Dio e per l’Agnello» (Ap 14,4): in essi è già santificato l’intero genere umano insieme a tutta la creazione. Il brano dell’Apocalisse che oggi viene proclamato, tratto dal capitolo settimo, afferma che il loro numero è sterminato: secondo la simbologia biblica centoquarantaquattromila non in-dica un limite, ma una pienezza e una totalità. Finché il sigillo di Dio non è impresso sulla loro fronte la terra e il mare non possono essere devastati, come a indicare che la loro vita diviene sacramento di salvezza e di redenzione per il cosmo intero.
Se la liturgia ci offre di contemplare la loro vita e il loro destino, non è tanto per offrirci dei modelli da imitare, quanto per condurci a riconoscere la multiforme grazia con cui Dio visita e trasfigura la nostra storia. «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all’Agnello» (Ap 7,10), grida la moltitudine immensa. La santità dei redenti è testimonianza non delle loro virtù o delle loro qualità, ma dell’essere stati salvati dall’amore di Dio, che ci rende realmente suoi figli chiamandoci sin d’ora a quella somiglianza con il suo volto che si attuerà in modo pieno e definitivo quando «egli si sarà manifestato e noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è» (cfr. 1Gv 3,1-2). Nella loro esemplarità, i santi non esigono una memoria ripetitiva di ciò che hanno fatto e vissuto, che spesso
è inimitabile avendo il sapore dell’unicità, o comunque rimane legato a contesti storici ed ecclesiali che non sono più i nostri; piuttosto la loro testimonianza deve suscitare nei credenti lo stupore e la gratitudine per quanto il Signore ha compiuto nel passato, e l’attesa confidente che torni a operarlo nell’oggi della vita personale e della storia del mondo, per condurli a un futuro di compimento.
Anche il brano evangelico mette in luce come sia l’agire di Dio a rivelarsi nel volto dei beati. Le beatitudini, prima ancora che essere descrizione di un modo di essere dell’uomo davanti a Dio, sono rivelazione di come Dio si rapporti con gli uomini e manifesti in loro la bellezza della sua opera. Il genere letterario della beatitudine non è esclusivo del Nuovo Testamento; è molto frequente nel Primo Testamento, in particolare la letteratura sapienziale è zeppa di beatitudini. Tuttavia, nella maggior parte dei casi le beatitudini che leggiamo nelle Scritture sante sono articolate in due parti; c’è dapprima l’annuncio della gioia, espressa con il termine «beato/beati», al quale segue una seconda parte che descrive la situazione o l’atteggiamento che vengono proclamati tali. Invece, le beatitudini che Gesù proclama dall’alto del monte non sono in due, ma in tre parti. Dopo l’annuncio della beatitudine, vengono descritti i suoi destinatari – i poveri, gli afflitti, i miti, gli affamati di giustizia… -; infine c’è una terza parte, quella fondamentale, nella quale Gesù mostra su cosa si fonda la loro gioia. E questa terza parte, introdotta da un perché, fa sempre riferimento a un’azione di Dio, che viene promessa ed è certa, perché Dio sicuramente la compirà. Dietro tutti i passivi che ritmano il testo possiamo facilmente intravedere come sia Dio il soggetto di ogni azione: beati i poveri in spirito, perché a loro Dio donerà il suo regno; beati gli afflitti, perché Dio li consolerà; beati i miti, perché proprio a costoro Dio lascerà in eredità la terra; beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché Dio li sazierà… Appare evidente che la ragione della beatitudine non riposa nelle condizioni esistenziali che l’uomo vive, o nei possibili atteggiamenti che è invitato ad assumere. Anzi, queste situazioni sono tutt’altro che benedette; sono condizioni di povertà, di indigenza, addirittura di persecuzione. La motivazione della gioia sta nel fatto che Dio si colloca dalla loro parte, prende le loro difese, custodirà e riscatterà il loro diritto ingiustamente offeso; agirà, anzi già agisce in loro favore. Le beatitudini di Gesù sono quindi anzitutto una rivelazione di Dio, narrano il suo modo di agire nella storia, proclamano un amore che, per quanto universale, è comunque attraversato da una predilezione, che raggiunge tutti coloro che hanno bisogno di qualcuno che si curvi sul loro bisogno, prenda le loro difese, si faccia carico del loro diritto ingiustamente offeso, sazi il loro giusto desiderio di vita. Di costoro è il regno dei cieli, e il regno è questo curvarsi di Dio sul bisogno dell’uomo.
La gioia si fonda dunque sul terzo elemento, che descrive ciò che Dio certamente farà. Si ancora a questa speranza, che è tale perché ha la forza di trasformare anche il nostro presente consentendoci di rileggerlo nella luce del futuro di Dio. Infatti, questo ‘beati’ proclamato da Gesù non è un semplice augurio, o una benedizione per il futuro, neppure semplicemente una promessa. È piuttosto una constatazione nel presente: siete beati ora, nell’oggi della vostra vita, anche se il fondamento di questa felicità riposa nel futuro, ma si tratta del futuro di Dio, non del futuro dell’uomo. Affermare che è il futuro di Dio non significa solo riconoscere che è un futuro certo, perché Dio è fedele alla sua parola e attua la sua promessa; significa anche riconoscere che è un futuro capace di dare un significato diverso a ciò che ora sto vivendo. È un futuro indisponibile per la mia libertà e per la mia possibilità, non sono io a poterlo progettare o costruire con le mie mani o con la mia fantasia, ma viene da Dio, mi è donato, ed è pertanto in grado di dare un senso diverso al mio presente. Benedetto XVI afferma nella sua enciclica Spes salvi che il messaggio cristiano non è solo ‘informativo’, ma ‘performativo’. Ciò significa – spiega il papa – che «il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; gli è stata donata una vita nuova» (n. 3). I santi sono coloro che hanno saputo scommettere tutta la propria esistenza su questo futuro di Dio e nella speranza hanno ricevuto il dono di una vita nuova, che la loro libertà ha saputo accogliere e far fruttificare.
Le beatitudini che proclama Gesù sono otto, ma esse non delineano otto figure diverse di uomini e di donne, ma disegnano un’unica figura, una sola personalità spirituale, un unico modo di essere e di agire. Potremmo dire che questa unica personalità è Gesù Cristo, al quale il discepolo del Regno deve diventare sempre più simile. Il vero uomo delle beatitudini è Gesù Cristo. Ciò significa anche che l’unica personalità o figura spirituale che le beatitudini ci descrivono è quella del povero in spirito, di cui ci parla la prima beatitudine. È la prima non perché all’inizio di una serie, ma perché è la beatitudine fondamentale, e tutte le altre che seguono esplicitano vari aspetti in cui l’essere poveri in spirito si manifesta più concretamente. I poveri in spirito sono poveri davanti a Dio, vivendo la loro povertà nella dipendenza da Dio, attendendo tutto dalle sue mani e dal suo dono. Non sperano solo qualcosa, ma sperano Lui. Povero in spirito è Gesù che nell’evangelo di Matteo può dire: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio» (11,27). Povero è chi sa di dover ricevere tutto dalle mani di Dio e riconosce che la propria vita dipende dalle relazione con il Padre. Il santo «è colui che ha misurato nella povertà sua la smisurata distanza che lo separa dalla santità di Dio. E di fronte ad essa sente la propria indigenza, il proprio limite e tende sempre la mano vuota affinché Dio, come cantiamo a proposito di Maria, la riempia dei suoi beni» (C. Massa).
Preghiere e racconti
La santità della Iglesia militante
Cari «Io vedo la santità — prosegue il Papa — nel popolo di Dio paziente: una donna che fa crescere i figli, un uomo che lavora per portare a casa il pane, gli ammalati, i preti anziani che hanno tante ferite ma che hanno il sorriso perché hanno servito il Signore, le suore che lavorano tanto e che vivono una santità nascosta. Questa per me è la santità comune. La santità io la associo spesso alla pazienza: non solo la pazienza come hypomoné, il farsi carico degli avvenimenti e delle circostanze della vita, ma anche come costanza nell’andare avanti, giorno per giorno. Questa è la santità della Iglesia militante di cui parla anche sant’Ignazio. Questa è stata la santità dei miei genitori: di mio papà, di mia mamma, di mia nonna Rosa che mi ha fatto tanto bene. Nel breviario io ho il testamento di mia nonna Rosa, e lo leggo spesso: per me è come una preghiera. Lei è una santa che ha tanto sofferto, anche moralmente, ed è sempre andata avanti con coraggio».
(Intervista del Direttore a Papa Francesco, in «Civiltà Cattolica» 164 (2013) 3918, 449-477).
La santità è sempre giovane
« Cari amici, la Chiesa oggi guarda a voi con fiducia e attende che diventiate il popolo delle beatitudini”. “Beati voi, afferma il papa, se sarete come Gesù poveri in spirito, buoni e misericordiosi; se saprete cercare ciò che è giusto e retto; se sarete puri di cuore, operatori di pace, amanti e servitori dei poveri. Beati voi!”. E’ questo il cammino percorrendo il quale, dice il papa vecchio ma ancora giovane, si può conquistare la gioia, “quella vera!”, e trovare la felicità. Un cammino da percorrere ora, subito, con tutto l’entusiasmo che è tipico degli anni giovanili: “Non aspettate di avere più anni per avventurarvi sulla via della santità! La santità è sempre giovane, così come eterna è la giovinezza di Dio. Comunicate a tutti la bellezza dell’incontro con Dio che dà senso alla vostra vita. Nella ricerca della giustizia, nella promozione della pace, nell’impegno di fratellanza e di solidarietà non siate secondi a nessuno!”.
“Quello che voi erediterete”, continua il papa in quelle che sono parole sempre attuali, “è un mondo che ha un disperato bisogno di un rinnovato senso di fratellanza e di solidarietà umana. È un mondo che necessita di essere toccato e guarito dalla bellezza e dalla ricchezza dell’amore di Dio. Il mondo odierno ha bisogno di testimoni di quell’amore. Ha bisogno che voi siate il sale della terra e la luce del mondo. (…) Nei momenti difficili della storia della Chiesa il dovere della santità diviene ancor più urgente. E la santità non è questione di età. La santità è vivere nello Spirito Santo”.
Una scelta di vita, una scelta che dà senso, una scelta per vivere e testimoniare ciò che ogni cristiano sa: “Solo Cristo è la ‘pietra angolare’ su cui è possibile costruire saldamente l’edificio della propria esistenza. Solo Cristo, conosciuto, contemplato e amato, è l’amico fedele che non delude”.
(Giovanni Paolo II, a Toronto, nella la GMG 2002).
Ciò che ho scritto di noi
Ciò che ho scritto di noi è tutta una bugia
è la mia nostalgia cresciuta sul ramo inaccessibile
è la mia sete tirata su dal pozzo dei miei sogni
è il disegno tracciato su un raggio di sole
ciò che ho scritto di noi è tutta verità
è la tua grazia
cesta colma di frutti rovesciata sull’erba
è la tua assenza
quando divento l’ultima luce all’ultimo angolo della via
è la mia gelosia
quando corro di notte fra i treni con gli occhi bendati
è la mia felicità
fiume soleggiato che irrompe sulle dighe
ciò che ho scritto di noi
è tutta una bugia
ciò che ho scritto di noi è tutta verità.
(Nazim Hikmet)
Le beatitudini bibliche
Fra i dieci gruppi in cui si possono distribuire e raccogliere le diverse beatitudini bibliche, uno solo riguarda il possesso dei beni materiali. È la beatitudine di un padre che, per merito della fecondità della moglie, si trova provvisto di un certo numero di figli, sani e robusti, e che, perciò, passa onorato e riverito tra la gente della sua città. Ma altre beatitudini di ordine materiale non esistono. Né i ricchi, né i potenti, dominatori, eroi, né, molto meno, i gaudenti, fecero parte, direttamente, per le beatitudini bibliche, del numero dei beati. Anche la ricchezza, certamente, rientrò nella visione biblica antico-testamentaria, tra i beni desiderabili per la vita di ogni uomo. La povertà e l’indigenza non ebbero mai buona accoglienza. A differenza, però, delle beatitudini sia egiziane che greche, le beatitudini bibliche non credettero mai che la ricchezza, da sola, bastasse a dare felicità. E neppure, quindi, la gloria, la potenza, il prestigio.
Anche questi, certamente, apparvero e furono stimati beni altamente desiderabili. Ma non vennero ritenuti affatto costitutivi della felicità umana. Furono cioè dei beni integrativi, ma non costitutivi.
Servendoci, quindi, di questa distinzione fra beni costitutivi e beni integrativi, l’unico grande bene costitutivo non fu, in realtà, secondo nove dei dieci gruppi di beatitudini, che Dio; ovvero, meglio, il possesso, da parte dell’uomo, di tutti gli atteggiamenti più genuini e autentici verso la realtà divina: la fede in un unico Dio (gruppo I); piena confidenza e speranza nella sua azione salvifica (II); rispetto profondo, timore e amore (III); umile confessione delle proprie colpe e desiderio di perdono (IV); stima e attiva partecipazione all’incremento del culto e la liturgia del tempio (V); attento sguardo sapienziale e attento ascolto alla presenza di Dio nel mondo e nella storia (VI); stima della Legge come riflesso e testimonianza della manifestazione dell’azione salvifica di Dio (VII); rispettoso comportamento verso l’ordine della giustizia (VIII); e, infine, umile accettazione anche di una qualche menomazione fisica, di uno stato di sofferenza (X).
Siamo, quindi, come si vede, di fronte a un complesso di atteggiamenti religiosi, per i quali l’uomo, consapevole delle sue incapacità, limitatezze, non si chiude orgogliosamente in se stesso, ma riconosce che solo in Dio trova la sua completezza.
(A. MATTIOLI, Beatitudini e felicità nella Bibbia d’Israele, Prato, 1992, 542s.).
Il paese della felicità
Se la felicità si trovasse anche solo nel paese più lontano e il viaggio per raggiungerlo comportasse i più grandi rischi e potesse essere intrapreso solo a prezzo dei peggiori sacrifici, partiremmo comunque subito.
Perché sarebbe in ogni caso più facile raggiungerla là che non nell’unico posto dove si trova davvero, il posto che è più vicino del paese più vicino eppure è più lontano del paese più lontano, perché questo posto non si trova fuori, ma dentro di noi.
(Thorkild Hansen)
Perché dovrei aiutare soprattutto i deboli?
Friedrich Nietzsche ha rimproverato al cristianesimo di glorificare la dimensione della debolezza e di condannare la dimensione della forza. Il cristianesimo sarebbe diventato, quindi, una religione dei gretti, nella quale la forza non ha posto e dalla quale le personalità forti si sentono respinte. Anche se Nietzsche esagera nella sua critica al cristianesimo, ha sottolineato tuttavia un aspetto importante: il cristianesimo non può diventare una religione della debolezza, altrimenti alla lunga non può dispiegare nessuna forza in questo mondo.
San Benedetto lo sapeva. Ammonisce l’abate a trattare i confratelli in modo tale che i forti vengano sollecitati e i deboli non vengano umiliati. Questa è per me una regola fondamentale e saggia. I forti hanno bisogno di una sfida per crescere e mettere i loro punti forti al servizio della comunità. Una comunità che glorifichi i deboli può togliere il respiro anche ai forti. In questo modo danneggerebbe se stessa. C’è bisogno di un buon equilibrio fra forti e deboli. Entrambi dovrebbero essere sfidati e dovrebbero poter vivere nella comunità in modo tale da crescere in essa.
(Anselm GRÜN, Il libro delle risposte, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2008, 145).
Posso vivere basandomi sui valori e tuttavia avere successo?
I valori ci conferiscono valore e dignità. La vita di chi fa attenzione ai valori nella sua sfera personale acquisterà valore. Chi non si orienta più ai valori perde il rispetto per se stesso e per gli altri. La sua vita avrà sempre meno valore. Lo tirerà giù. La parola “valore” viene dal latino valere, che significa “essere forte e sano”. I valori ci danno, quindi, una forza interiore. Rendono sana la nostra vita. Se costruisco sui valori, quello che creo con la mia vita avrà un fondamento solido. Non crollerà con facilità, come si può osservare con le persone che costruiscono la loro casa di vita sulla sabbia delle loro illusioni o delle immagini ingannevoli. Alla lunga può resistere solo chi costruisce la sua casa su un terreno solido. E tale terreno solido sono i valori o gli atteggiamenti fondati sui valori, le virtù note fin dall’antichità: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, e gli atteggiamenti cristiani come la fede, la speranza e la carità. Solo che rende giustizia alla propria essenza e chi rimane fedele con coraggio a quello che è importante per lui, chi accetta la propria dimensione e non segue continuamente esigenze smisurate, solo chi è saggio e valuta correttamente la situazione concreta, potrà vivere bene a lungo. E a lungo termine avrà anche successo nella vita.
(Anselm GRÜN, Il libro delle risposte, San paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2008, 149).
Preghiera
Signore Gesù Cristo,
custodisci questi giovani nel tuo amore.
Fa’ che odano la tua voce
e credano a ciò che tu dici,
poiché tu solo hai parole di vita eterna.
Insegna loro come professare la propria fede,
come donare il proprio amore,
come comunicare la propria speranza agli altri.
Rendili testimoni convincenti del tuo Vangelo,
in un mondo che ha tanto bisogno
della tua grazia che salva.
Fa’ di loro il nuovo popolo delle Beatitudini,
perché siano sale della terra e luce del mondo
all’inizio del terzo millennio cristiano.
Maria, Madre della Chiesa, proteggi e guida
questi giovani uomini e giovani donne
del ventunesimo secolo.
Tienili tutti stretti al tuo materno cuore. Amen.
(Preghiera del Papa, al termine della Giornata della Gioventù di Toronto).
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana.
– Messalino festivo dell’assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
———
– M. FERRARI, monaco di Camaldoli, «Oggi si è adempiuta questa scrittura», Milano, Vita e Pensiero, 2013.
– COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade, Milano, Vita e Pensiero, 2008-2009.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Seconda parte: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla Risurrezione, Città del Vaticano, Liberia Editrice Vaticana, 2011.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
– Intervista del Direttore a Papa Francesco, in «Civiltà Cattolica» 164 (2013) 3918, 449-477.
PER APPROFONDIMENTO: