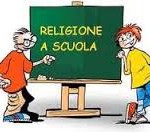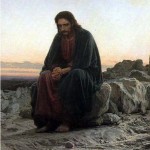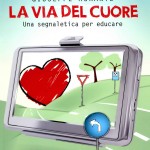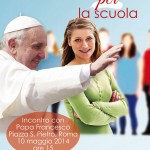Prima lettura: 1 Samuele 16,1.4.6-7.10-13
|
In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re». Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore». Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Alzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. |
Se la domanda centrale del Vangelo di oggi è: «Chi è Gesù?», questo brano di 1Samuele ne preannuncia già la risposta. Egli è il discendente di Davide, il germoglio che spunta dal tronco di Iesse, su cui, secondo Isaia, si posa lo Spirito del Signore (Is 11,2).
Sappiamo che l’istituzione della regalità fu molto contrastata in Israele, perché sembrava contrapporsi alla fede del popolo eletto in JHWH come unico re e guida, che l’aveva liberato dalla schiavitù d’Egitto.
Dio non si lascia condizionare dalle apparenze. Per la scelta di Saul erano state importanti alcune qualità: era «alto e bello; non c’era nessuno più bello di lui tra gli Israeliti; superava dalla spalla in su chiunque altro del popolo» (1Sam 9,2). Davide invece era il più piccolo di otto fratelli. Dio sceglie la piccolezza, per fare cose grandi, «perché nessuno», dirà poi Paolo, «possa gloriarsi davanti a Dio» (1Cor 1,28).
Seconda lettura: Efesini 5,8-14
|
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto [da coloro che disobbediscono a Dio] è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: «Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà». |
Il brano della lettera proposto dalla liturgia è preso dalla sua seconda parte parenetica, che segue la prima parte dottrinale interamente centrata sulla polarità Cristo-capo e chiesa suo corpo. Paolo propone un progetto di vita cristiana, conseguente all’inserimento del credente nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. È all’uomo nuovo, la cui vita è fondata in Cristo risorto, che sono rivolte le parole di questa esortazione. E verso questo uomo nuovo, mentre usciva rinnovato dalle acque del battesimo, si dirigevano le parole di un inno battesimale citate da Paolo: «Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà» (v. 14). Il passaggio dall’incoscienza del sonno allo stato di veglia indica la trasformazione che il sacramento produce.
Questo uomo nuovo ora è in grado non solo di dissociarsi dalle opere infruttuose delle tenebre, ma anche di smascherarle, perché ha discernimento, essendo illuminato dalla luce di Cristo, e a condannarle apertamente, perché è un uomo liberato dalla sua morte e risurrezione.
Vangelo: Giovanni 9,1-41
|
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e lavati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». |
Esegesi
Questo è il sesto miracolo narrato da Giovanni e appartiene al cosiddetto «libro dei segni» (Gv 1-12). La domanda che l’evangelista pone alla sua comunità e ai suoi avversari, i giudei della sinagoga della fine del primo secolo, è questa: «Chi è Gesù». Il contesto in cui avviene il miracolo è la festa ebraica delle Capanne, che cadeva tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre. Era una festa in cui venivano richiamati i motivi dell’acqua e della luce. Siamo probabilmente nell’anno 29.
L’episodio inizia con una domanda dei discepoli: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Nella risposta data da Gesù troviamo che non c’è consequenzialità tra malattia e peccato. Nella malattia, come sarà poi nella croce di Gesù, si manifesterà la gloria di Dio. Si tratta di un cieco nato, che mai aveva visto la luce, la cui vita era ristretta nel chiedere l’elemosina: dipendeva esclusivamente dalla compassione del prossimo. Gesù non gli da un’elemosina più abbondante del solito. Inizialmente sembra fare qualcosa di offensivo alla cecità del povero uomo: gli spalma sugli occhi del fango (anticamente si attribuiva alla saliva soprattutto se mescolata con la terra, una virtù terapeutica). Il cieco si sente sporco ed è costretto dai fatti e dalla parole di Gesù a scendere a lavarsi alla piscina di Siloe. Si lavò e riebbe la vista.
Entrano allora in scena i farisei che negano risolutamente il miracolo, perché Gesù facendo del fango in giorno di sabato aveva violato il comando divino del riposo, dunque non poteva venire da Dio. Il comportamento poi dei genitori appare reticente, ma esprime bene la tensione tra i cristiani e la sinagoga alla fine del secolo I. Negli anni 80 d.C. si decretò infatti la scomunica per i giudeo-cristiani.
Il guarito, scacciato dalla sinagoga e accolto da Gesù, lo riconosce come Figlio dell’uomo, cioè giudice escatologico del mondo e come Signore, cioè come Figlio di Dio. Gesù non gli restituisce solo la luce degli occhi ma anche quella della fede. I farisei, invece, sicuri di possedere la verità rifiutano di vedere fuori di sé per non porre in dubbio le proprie certezze. Nella loro scelta consapevole di scegliere le tenebre anziché la luce, si attua il giudizio di Dio, che li esclude dalla salvezza.
Meditazione
Al centro della quarta domenica di Quaresima vi è il tema dell’illuminazione, del passaggio dalle tenebre alla luce espresso nel vangelo dal racconto della guarigione dell’uomo cieco dalla nascita che acquista il senso di una pedagogia verso la fede cristologica. Nella seconda lettura il tema riveste valenza battesimale ed è colto nelle sue implicazioni etiche: l’illuminazione battesimale impegna a una vita di conversione («Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce»: Ef 5,8). In parallelo con questo annuncio la prima lettura presenta l’unzione regale di David da parte di Samuele: il gesto e le parole del profeta che consacrano il messia rinviano alle parole e ai gesti di Gesù, «luce del mondo» (Gv 9,5), che dona luce a chi è nelle tenebre con gesti e parole che evocano la dinamica sacramentale.
Le tre letture pongono il problema del discernimento. Si tratta del difficile discernimento di Samuele per scegliere colui che Dio ha eletto tra i figli di Iesse. Per discernere occorre guardare come Dio stesso guarda, nella coscienza che se «l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore» (1 Sam 16,7), o, come recita l’antica versione siriaca: «l’uomo guarda con gli occhi, il Signore guarda con il cuore». Nella seconda lettura il discernimento è richiesto al battezzato che, nella situazione in cui è «luce nel Signore», è chiamato a discernere ciò che è gradito a Dio (Ef 5,10-11). Il brano evangelico si apre con il diverso sguardo di Gesù e dei discepoli su un cieco, e prosegue con il percorso che porta il cieco guarito a discernere la vera qualità di Gesù e a confessare la fede in lui, mentre altri protagonisti dell’episodio si chiudono a tale discernimento e restano nella cecità spirituale (cfr. Gv 9,39-41).
Nel vangelo, Gesù e i discepoli incontrano un uomo cieco, ma lo guardano con occhi molto diversi. Accecati da un assioma teologico che lega in modo automatico la malattia al peccato i discepoli vedono in lui un peccatore, mentre Gesù vede nella malattia di quell’uomo l’occasione del manifestarsi dell’azione di Dio. Stessa persona, sguardo diametralmente opposto. Chi vediamo vedendo un malato? Che cosa vediamo nella sofferenza dell’altro? Lo sguardo colpevolizzante dei discepoli si oppone allo sguardo di solidarietà di Gesù.
Il testo si presenta come una iniziazione in cui l’uomo che era cieco ottiene la vista e giunge alla conoscenza dell’identità profonda di Gesù, una conoscenza che è anche una co-nascenza, una rinascita, la nascita a una vita completamente rinnovata dall’incontro con Gesù ed espressa dalla lapidaria confessione di fede: «Io credo, Signore» (Gv 9,38).
Il gesto terapeutico attuato da Gesù sul cieco quando ha impastato del fango e l’ha spalmato sugli occhi dell’uomo (Gv 9,7), ricorda il gesto con cui Dio ha creato Adamo plasmandolo con polvere del suolo (Gen 2,7). La ri-creazione non ha nulla di magico o spiritualistico, ma ha una valenza umanissima e conduce colui che era solo oggetto di parole e giudizi altrui a divenire soggetto, ad assumere la propria vita, a prendere la parola e a rivendicare la propria identità: «Sono io» (Gv 9,9). Quel «sono io» è essenziale per poter giungere a proclamare nella libertà e con convinzione: «Io credo!». Divenire credenti non esime dal divenire uomini. Anzi, lo esige.
Di fronte al cieco guarito una prima reazione è quella dei conoscenti che pongono domande, interrogano, ma non si interrogano, non pongono mai in questione se stessi e così restano alla superficie dell’evento (vv. 8-12). Vi è poi l’atteggiamento dei genitori che per paura non vanno oltre una banale e distaccata constatazione del fatto (vv. 18-23). Vi è il sapere teologico dei farisei, un sapere autosufficiente e impermeabile che diviene ottusità portandoli ad accusare Gesù (vv. 13-17) e lo stesso cieco guarito di essere peccatori (vv. 24-34) pur di non lasciarsi interpellare dall’evento straordinario. Chi è cieco e chi vede? Questa la domanda che il testo suscita. E questa la risposta: vede chi sa vedere la propria cecità e aprirsi all’azione sanante e illuminante di Cristo.
Preghiere e racconti
Domenica «Laetare»
L’itinerario quaresimale che stiamo vivendo è un particolare tempo di grazia, durante il quale possiamo sperimentare il dono della benevolenza del Signore nei nostri confronti. La liturgia di questa domenica, denominata “Laetare”, invita a rallegrarci, a gioire, così come proclama l’antifona d’ingresso della celebrazione eucaristica: “Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza: saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione” (cfr Is 66,10-11). Qual è la ragione profonda di questa gioia? Ce lo dice il Vangelo odierno, nel quale Gesù guarisce un uomo cieco dalla nascita. La domanda che il Signore Gesù rivolge a colui che era stato cieco costituisce il culmine del racconto: “Tu credi nel Figlio dell’uomo?” (Gv 9,35). Quell’uomo riconosce il segno operato da Gesù e passa dalla luce degli occhi alla luce della fede: “Credo, Signore!” (Gv 9,38). È da evidenziare come una persona semplice e sincera, in modo graduale, compie un cammino di fede: in un primo momento incontra Gesù come un “uomo” tra gli altri, poi lo considera un “profeta”, infine i suoi occhi si aprono e lo proclama “Signore”. In opposizione alla fede del cieco guarito vi è l’indurimento del cuore dei farisei che non vogliono accettare il miracolo, perché si rifiutano di accogliere Gesù come il Messia. La folla, invece, si sofferma a discutere sull’accaduto e resta distante e indifferente. Gli stessi genitori del cieco sono vinti dalla paura del giudizio degli altri. E noi, quale atteggiamento assumiamo di fronte a Gesù? Anche noi a causa del peccato di Adamo siamo nati “ciechi”, ma nel fonte battesimale siamo stati illuminati dalla grazia di Cristo. Il peccato aveva ferito l’umanità destinandola all’oscurità della morte, ma in Cristo risplende la novità della vita e la meta alla quale siamo chiamati. In Lui, rinvigoriti dallo Spirito Santo, riceviamo la forza per vincere il male e operare il bene. Infatti la vita cristiana è una continua conformazione a Cristo, immagine dell’uomo nuovo, per giungere alla piena comunione con Dio. Il Signore Gesù è “la luce del mondo” (Gv 8,12), perché in Lui “risplende la conoscenza della gloria di Dio” (2 Cor 4,6) che continua a rivelare nella complessa trama della storia quale sia il senso dell’esistenza umana. Nel rito del Battesimo, la consegna della candela, accesa al grande cero pasquale simbolo di Cristo Risorto, è un segno che aiuta a cogliere ciò che avviene nel Sacramento. Quando la nostra vita si lascia illuminare dal mistero di Cristo, sperimenta la gioia di essere liberata da tutto ciò che ne minaccia la piena realizzazione. In questi giorni che ci preparano alla Pasqua ravviviamo in noi il dono ricevuto nel Battesimo, quella fiamma che a volte rischia di essere soffocata. Alimentiamola con la preghiera e la carità verso il prossimo.
(LE PAROLE DEL PAPA BENEDETTO XVI ALLA RECITA DELL’ANGELUS, 03.04.2011).
«Io sono la luce del mondo»
Nostro Signore ha detto: «Io sono la luce del mondo» […]. «Abbandona la tua luce che è in verità una tenebra, di fronte alla mia luce, ed è a me contraria; poiché Io sono la vera Luce, voglio darti, al posto delle tue tenebre, la mia luce eterna, affinché sia tua come mia; e con la mia luce ti darò il mio essere, la mia vita, la mia beatitudine e la mia gioia» […].
È da notare il modo e la via per giungere alla vera luce. È una vera rinunzia dell’uomo a se stesso e una pura, profonda ed esclusiva intenzione di amare Dio e non ciò che è proprio: desiderare unicamente l’onore e la gloria di Dio e riferire immediatamente a Dio tutte le cose, da qualunque parte provengano, e a lui riportarle senza alcun rigiro e mediazione; questa è la vera e retta via. Egli è la vera Luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Questa luce risplende nelle tenebre ma le tenebre non ricevettero la luce. Questa luce non la riceve nessuno, tranne i poveri in spirito e della propria volontà. Carissimi figli, mettete in opera tutto ciò che potete fare, spiritualmente e naturalmente, perché questa vera luce risplenda in voi e possiate gustarla. Chiedete agli amici di Dio che vi aiutino; attaccatevi a coloro che aderiscono a Dio, affinché vi attirino con loro a Dio.
Che ciò tocchi a tutti noi. Ci aiuti in ciò l’amabile Dio. Amen.
(GIOVANNI TAULERO, Sermone dal Vangelo di Giovanni per il lunedì prima della vigilia delle Palme, in Il fondo dell’anima, Casale Monf. 1997, 102-108, passim).
Il cieco nato
In questo luogo elevato del corpo, l’anima si sveglia
ecco il cieco nato che mi meraviglia
II giardino chiuso davanti a lui si è aperto
un ritmo nuovo si impone all’universo
Ristabiliamo gli esseri e le cose
nel loro candore nativo.
Propongo che camminiamo insieme sulle acque
che abbiamo l’ardire degli uccelli
che il nostro soffio sposando la terra
accenda un fuoco nuovo nelle nostre arterie
Non c’è nulla da temere Tutto è bello Aspetto
l’eternità promessa per l’istante
l’immensità appresa nei miei limiti
So il peso del mondo Gravito
attorno all’asse dove mi voleva la sorte
Sono appena nato Mi cerco ancora
ma sono al mio posto sovrano
Di un mondo nuovo di cui ho preso le redini.
(L. Wouters)
L’uomo guarda l’apparenza, il Signore guarda il cuore (1 Sam 16,7)
La secolarità è il modo di essere dipendenti dalle reazioni del nostro ambiente. L’io secolare, il falso-io, è quello fabbricato – come dice Thomas Merton – dalle costrizioni sociali. ‘Costrittivo’ è certamente il migliore aggettivo per dire il falso io. Esso indica la necessità di continua e crescente affermazione. Chi sono io? Sono uno che piace, è lodato, ammirato, o che non piace, è odiato, disprezzato… La costrizione si manifesta nell’inconscia paura di fallire e nell’ossessivo desiderio di impedirlo, accumulando sempre di più le stesse cose: più lavoro, più denaro, più amici.
Queste costrizioni stanno alla base di due dei principali nemici della vita spirituale: la collera e la cupidigia. Esse sono il lato interiore della vita secolare, i frutti acidi delle nostre dipendenze dal mondo.
(J.M. Nouwen, La via del cuore, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003, 93).
Primavera
Un giorno,un uomo non vedente stava seduto sui gradini di un edificio con un cappello ai suoi piedi ed un cartello recante la scritta:”Sono cieco, aiutatemi per favore”. Un pubblicitario che passeggiava lì vicino si fermò e notò che aveva solo pochi centesimi nel suo cappello. Si chinò e versò altre monete. Poi, senza chiedere il permesso dell’uomo, prese il cartello, lo girò e scrisse un’altra frase. Quello stesso pomeriggio il pubblicitario tornò dal non vedente e notò che il suo cappello era pieno di monete e banconote. Il non vedente riconobbe il passo dell’uomo: chiese se non fosse stato lui ad aver riscritto il suo cartello e cosa avesse scritto. Il pubblicitario rispose “Niente che non fosse vero – ho solo scritto il tuo cartello in maniera diversa”, sorrise e andò via. Il non vedente non seppe mai che sul suo cartello c’era scritto: “Oggi è primavera…ed io non la posso vedere”.
«Io credo, Signore!»
Eccoci, Signore Gesù, radiosa luce della gloria del Padre, ai tuoi piedi come ciechi ignari della loro infermità.
Guardaci, figlio di Davide, come hai guardato i tuoi, oppressi dal sonno, nella luce del Tabor.
Svegliaci, Signore Gesù, vero sole che mai tramonta, illuminaci e noi saremo raggianti.
Curaci, Signore Gesù con il tocco lieve del dito di Dio e con la Parola che apre occhi e cuore alla luce.
Mandaci, Signore Gesù, alla piscina perenne del lavacro di vita nuova.
Donaci tua Madre, Signore Gesù, la brocca d’oro per attingere acqua viva dalla fonte perenne del tuo cuore trafitto per noi sulla croce.
Custodiscici premuroso, Gesù, nella prova della fede che non risparmia nessuno, perché non ha risparmiato nemmeno Te, il Signore.
Rivelati, Signore Gesù, luce gioiosa dell’eterno giorno, mettendo sulle nostre labbra il grido del cieco sanato: «Io credo, Signore!».
Miracolo del cieco nato
Finché vivi sulla terra sei come uno con gli occhi bendati. Solo per la fede, sotto l’influsso del mio Spirito, puoi essere sensibile alla mia presenza, alla mia voce, al mio amore. Agisci come se mi vedessi, bello, affettuoso, amorevole come sono, eppure così mal compreso, così isolato e trascurato da molti esseri ai quali ho tanto donato e tanto sono disposto a perdonare. Ho un così grande rispetto delle vostre persone! Non voglio rovinare nulla. Per questo sono tanto paziente, pur essendo attento e sensibile al più piccolo gesto d’amore e di attenzione.
(G. Courtois, Quando il Maestro parla al cuore).
Settimana Santa
Signore Gesù Cristo, nell’oscurità della morte
Tu hai fatto che sorgesse una luce;
nell’abisso della solitudine più profonda
abita ormai per sempre la protezione potente
del tuo amore;
in mezzo al tuo nascondimento
possiamo cantare l’Alleluia dei salvati.
Concedici l’umile semplicità della fede,
che non si lascia fuorviare
quando tu chiami nelle ore del buio, dell’abbandono,
quando tutto sembra apparire problematico;
concedi in questo tempo nel quale attorno a te si combatte una lotta mortale,
luce sufficiente per non perderti;
luce sufficiente perché noi possiamo darne
a quanti ne hanno ancora più bisogno.
Fai brillare il mistero della tua gioia pasquale,
come aurora del mattino, nei nostri giorni,
concedici di poter essere veramente uomini pasquali
in mezzo al sabato della storia.
Concedici che attraverso i giorni luminosi ed oscuri
di questo tempo
possiamo sempre con animo lieto
trovarci in cammino verso la Tua gloria futura.
Amen
(J. Ratzinger).
Finché sono nel mondo, sono luce di questo mondo
Quanto sono sciocchi quei giudei che chiedono: «È lui che ha peccato o i suoi genitori?» (Gv 9,2) riconducendo le infermità del corpo alla responsabilità delle colpe. E perciò il Signore dice: «Non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma ciò è accaduto perché in lui si manifestassero le opere di Dio» (Gv 9,3). Spetta infatti al Creatore, che è autore della natura, ridare forma a ciò che mancava alla natura. Perciò aggiunse: «Finché sono nel mondo, sono luce di questo mondo» ( Gv 9,5), cioè tutti quelli che sono ciechi possono vedere se mi chiedono la luce.
Accostatevi anche voi e ricevete la luce per poter vedere. […] Quanto al fatto che il Signore fece del fango e lo spalmò sugli occhi del cieco, che altro significa se non che si comportò così perché tu comprendessi che egli restituì la salute a quell’uomo spalmando del fango come aveva formato l’uomo dal fango e che la carne del nostro fango riceve la luce della vita eterna mediante i sacramenti del battesimo? Va’ anche tu alla piscina di Siloe, cioè a colui che è stato inviato dal Padre, come trovi scritto: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha inviato» (Gv 7,16). Cristo ti lavi perché tu possa vedere. Vieni al battesimo, ormai il tempo è vicino. Vieni subito per poter dire anche tu: «Sono andato, mi sono lavato e ho cominciato a vedere» (Gv 9,11), per poter dire, come disse costui dopo che gli fu ridata la vista: «La notte è avanzata, il giorno è vicino» (Rm 13,12). La cecità era notte. Era notte quando Giuda prese il boccone da Gesù e in lui entrò Satana. Era notte per Giuda dentro il quale vi era il diavolo. Era giorno per Giovanni che riposava sul petto di Gesù (cfr. Gv 13,21-30). Era giorno anche per Pietro quando vedeva la luce di Cristo sul monte (cfr. Mt 17,1-8); per gli altri era notte, ma per Pietro era giorno. Ma anche per Pietro era notte quando negava Cristo; il gallo cantò ed egli si mise a piangere (cfr. Mt 26,74-75) per emendare il suo errore. Infatti, ormai il giorno era vicino.
(AMBROGIO, Lettere 67,3.6-7, Opera omnia di sant’Ambrogio, pp. 190-192).
Chi aprirà i nostri occhi?
Chi aprirà i nostri occhi
ostinatamente chiusi
per evitare di vedere
la miseria agitarsi alla nostra porta?
Chi aprirà i nostri occhi
ostinatamente tappati
per evitare di guardare faccia a faccia
il prossimo che ci viene incontro?
Chi aprirà i nostri occhi
ostinatamente velati
per evitare di essere abbagliati
dalla presenza di Cristo
con il suo vangelo esigente?
Chi aprirà i nostri occhi
per riconoscere lo Spirito di Dio
all’opera sui molteplici cantieri
dove l’umanità si rinnova?
Chi aprirà i nostri occhi
per riconoscere il seme
che, con ostinazione, germoglia dall’arida terra screpolata?
Preghiera
Dio onnipotente
la tua eterna parola è la vera luce
che illumina ogni uomo.
Guarisci la cecità dei nostri cuori,
perché possiamo discernere
che cosa è giusto
e amarti sinceramente.
(H.J.M. Nouwen, Preghiere dal silenzio, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003, 95).
Alle storie dell’Antico Testamento corrispondono quelle del Nuovo e in particolare le scene riguardanti i miracoli compiuti da Gesù durante il suo ministero pubblico. Il riquadro in cui è affrescato l’episodio della guarigione del cieco nato alla piscina di Siloe è suddiviso in due fotogrammi senza soluzione di continuità: da una parte troviamo Gesù seguito da due discepoli mentre con la mano destra tocca gli occhi del cieco appoggiato a un bastone. Gesù, “via, verità e vita”, “rivelatore del Padre”, “Sapienza eterna di Dio” e suo “esegeta”, tiene nella mano sinistra un rotolo e si protende verso il cieco perché possa ricevere il dono della luce della verità divina: Dio, infatti, nessuno lo ha mai visto, ma proprio il Figlio unigenito, che è Dio e che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato (cf. Gv 1,18). Gesù è la luce del mondo, quella luce che brilla nelle tenebre (cf. Gv 1,5), chi segue lui non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita (cf. Gv 8,12).
Nella seconda parte della scena il cieco è presentato da solo mentre si lava alla piscina di Siloe raffigurata come una sorta di vasca battesimale su cui viene riversata dell’acqua viva da una sorgente posta in alto. Il significato della scena in cui si illustra l’itinerario battesimale di chi è chiamato a seguire Cristo sembra essere chiaro: il cieco è simbolo di chi è nel peccato e l’acqua rimanda al battesimo che è il sacramento che libera dalle tenebre del peccato e dell’ignoranza e rigenera a vita nuova rivelando la verità del vangelo e della salvezza.
«Ecco quindi il significato immediato del miracolo operato da Gesù: Egli è veramente Dio, il quale come può immediatamente dare la vista ad un cieco, così tanto più può dare la vista all’anima, può aprire gli occhi interiori perché conoscano le Verità supreme che riguardano la natura di Dio e il destino dell’uomo. Perciò la guarigione fisica del cieco, che è causa poi della sua fede, diventa un simbolo della conversione spirituale» (Giovanni Paolo II, 29-3-1981).
Lungo il cammino della Quaresima che conduce alla celebrazione della Pasqua di risurrezione, il credente è chiamato a riscoprire il proprio battesimo, a fare ritorno alla sorgente della luce e della vita nuova, tenendo bene in mente l’esortazione dell’apostolo: «Un tempo eravate tenebra ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce» (Ef 5,8). Vivere come “figli della luce” vuol dire non partecipare alle «opere infruttuose delle tenebre» (Ef 5,11) e cercare quanto è gradito al Signore (cf. Ef 5,10). Nella figura del cieco nato l’umanità intera riconosce se stessa nella sua ricerca della luce e della verità, come ci ricorda tra S. Agostino: «L’illuminazione del cieco è molto significativa. Il cieco nato rappresenta il genere umano, che fu colto dalla cecità nel primo uomo quando peccò. Come la cecità ebbe origine dall’infedeltà, così l’illuminazione nasce dalla fede» (Commento al Vangelo di Giovanni, 44).
l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004;2007-.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– Comunità domenicana di Santa Maria delle Grazie, La grazia della predicazione. Tempo di Quaresima e Tempo di Pasqua, in «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 95 (2014) 2, pp.67.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Tempo ordinario anno A, Milano, vita e Pensiero, 2010.
– J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
– F. ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità. Anno A, Padova, Messaggero, 2001.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.
– UFFICIO LITURGICO NAZIONALE (CEI), Svuotò se stesso… Da ricco che era si è fatto povero per voi. Sussidio CEI quaresima-pasqua 2014.
PER L’APPROFONDIMENTO: