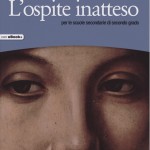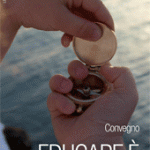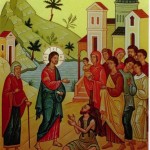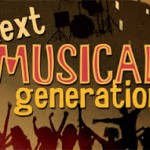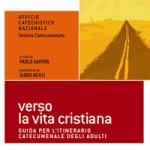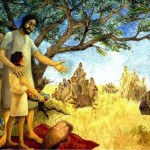
Prima lettura: Isaia 55,1-3
|
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide». |
Questo oracolo del secondo Isaia è rivolto ai deportati a Babilonia, nella prospettiva del ritorno in patria e della ricostruzione, grazie alle concessioni del re persiano Ciro, intorno al 538 a.C. I capitoli attribuiti a questo profeta (Is 40,55) incominciano proponendo gli intensi e molteplici richiami della parola di Dio, che annuncia e prepara il cambiamento della situazione (Is 40,1-11). Poi si diffondono sull’opera militare e politica di Ciro e su quella profondamente spirituale del Servo di JHWH. Adesso con la conclusione costituita dal capitolo 55, sollecitano tutti a dare ascolto e collaborazione attiva alla parola di Dio, sicuri dei suoi splendidi frutti. I tre versetti del brano liturgico sintetizzano questa sollecitazione, con paragoni facili e incisivi.
— Il versetto 1 invita a procurarsi i beni materiali, da quelli necessari di acqua e grano a quelli sovrabbondanti di vino e latte, pur senza denaro e senza spese. Con espressioni simili, la Sapienza invita ad ascoltare la parola di Dio, saggia e feconda di vita (Pr 9,5.11). Il profeta intende la stessa cosa. Ma sembra anche imitare le grida dei venditori per reclamizzare la loro merce, che stanno all’origine del paragone. Ciò gli permette di evidenziare i benefici anche materiali, che per i deportati erano il ritorno in patria e la ricostruzione, e di polemizzare con gli spacciatori di merci false.
— Il versetto 2 riferisce esplicitamente il paragone degli acquisti all’impegno di ascoltare la parola di Dio. Lo fa prima mettendo in guardia dallo spendere per ciò che non è pane e che non sazia e poi con l’invito «ascoltatemi», per avere le cose buone e i cibi succulenti. Le allusioni sono a predicatori di altri messaggi, magari di pessimismo e di rassegna-zione alla deportazione, comunque in contrasto con quello del profeta.
— Il versetto 3, ormai fuori dai paragoni, insiste sul rapporto tra parola di Dio e vita. Ripete per tre volte: «Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete». E assicura le conseguenze concrete: «Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide». Questo rapporto avvicina l’oracolo all’invito di Gesù: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,33). Lo pone in linea col messaggio della moltiplicazione dei pani e dei pesci (Vangelo). Ed esclude l’interpretazione spiritualista data da qualcuno al versetto precedente, quasi escludesse la ricerca del pane materiale per dedicarsi solo al cibo spirituale. Per Isaia, come per Gesù, la parola di Dio è fonte di vita piena, per lo spirito e per il corpo.
Seconda lettura: Romani 8,35.37-39
|
Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. |
Qui è proposta la parte finale dell’inno di lode all’amore di Dio che conclude il capitolo ottavo della lettera ai Romani, tutto dedicato alla trasformazione dell’uomo e del creato grazie alla redenzione operata da Cristo. In riferimento al suo contesto, si può trovare in essa un collegamento con la tematica principale delle altre letture, sotto due aspetti.
Da una parte l’inno esprime la più completa ed entusiasta fiducia nell’amore che Dio ha per noi. Tale senso ha la domanda iniziale: «Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo?». Assolutamente niente può intaccare la fedeltà di Dio che ha impegnato verso di noi la sua paterna misericordia, manifestata nel dono supremo di Cristo e della sua opera. Paolo fa un dettagliato elenco degli ostacoli possibili, dal nostro punto di vista: vanno dalle sofferenze personali, interne ed esterne, alle catastrofi di flagelli naturali, come la fame e la nudità, e della cattiveria umana, come la persecuzione e le violenze, fino alle opposizioni di potenze superiori che agiscono nel cosmo e nella storia. Nessuna creatura può prevalere su Dio. All’elenco possiamo certamente aggiungere le difficoltà a costruire, ieri e oggi, un mondo riconciliato, quale è prospettato nel contesto di questi versetti, e una comunità umana nella solidarietà e nella condivisione, come propongono la prima lettura e il Vangelo. Anche di queste difficoltà è più forte l’amore col quale Dio ci ama.
Dall’altra parte l’inno esprime il nostro impegno a corrispondere: «in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati ». L’apostolo è ottimista ed entusiasta anche sotto quest’aspetto. Ma sa bene, e lo ha detto altrove pure in questa lettera, che gli ostacoli all’amore di Dio vengono proprio da noi. Per questo prospetta il nostro impegno quasi come una sfida. Bisogna lasciarsi amare da Dio, in ogni circostanza, e avere il coraggio, con la sua grazia, di affrontare qualsiasi situazione per quanto difficile. Con questi atteggiamenti, i cristiani del tempo di Paolo hanno fermentato e trasformato la società pagana. Solo con essi è possibile liberare anche la società attuale dalle presunzioni dei vari ateismi e dalle catastrofi provocate dagli egoismi, dalle violenze e dalle sopraffazioni reciproche. I cristiani ne dovrebbero essere convinti per primi e impegnarsi a darne testimonianza dentro alla vita sociale, sebbene tanto complessa e difficile.
Vangelo: Matteo 14,13-21
|
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. |
Esegesi
La moltiplicazione dei pani e dei pesci è l’unico miracolo raccontato da tutti e quattro gli evangelisti. Il motivo è perché ha prefigurato e preparato l’istituzione dell’Eucaristia. E l’Eucaristia, bisogna aggiungere, è il primo germoglio che nasce dalla seminagione della parola, per organizzare la vita umana secondo il regno di Dio e la sua giustizia. Matteo fa risaltare questo, raccontando il prodigio al centro del Vangelo, dopo i discorsi in parabole (Mt 13), missionario (Mt 10) e della montagna (Mt 5-7), quando Gesù provoca i suoi discepoli e le folle a passare dalle parole ai fatti, in forza della fede. Riferisce prima la situazione, poi il dialogo per affrontarla e infine il miracolo.
La situazione (vv. 13-14). Gesù è in pericolo di vita, dopo che Erode ha ucciso il Battista, e per sottrarsi si apparta in un luogo deserto. Là trova una grande folla, affamata del nutrimento dello spirito e anche del corpo, per la quale prova una «compassione viscerale», cioè profondamente partecipata, come verso quelle che in precedenza gli erano apparse «stanche e sfinite, come pecore senza pastore» (Mt 9,36). Allora aveva provveduto formando il gruppo dei dodici apostoli, collaboratori della sua opera. Adesso guarisce i malati e si fa aiutare a procurare anche il cibo materiale. In questa viva partecipazione di Gesù, Matteo vede gli atteggiamenti del Messia liberatore dall’oppressione e dalle deportazioni (Mt 4 14-16), che si addossa le nostre miserie di ogni genere (Mt 8,17), per guarirle alla maniera misericordiosa e delicata del Servo di JHWH (Mt 12,17-21).
Il dialogo (vv. 15-18). Affronta decisamente la necessità del cibo materiale. Focalizza lo scopo del miracolo ed è la chiave per intenderne il significato e i successivi sviluppi. I discepoli propongono in sostanza a Gesù il disimpegno: «congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Gesù, al contrario domanda anche a loro un impegno a prima vista impossibile: «voi stessi date loro da mangiare». Hanno solo cinque pani e due pesci. Ma, proprio perché discepoli, hanno qualcos’altro di fondamentale da donare a questa folla e al mondo, nel procurarsi il cibo e il vestito: la fiducia in Dio Padre e il senso della condivisione nel suo nome. Con l’ordine: «Portatemeli qui», chiede i pani e i pesci, ma insieme anche la loro presenza e partecipazione. Non intende affatto uno sbrigativo e miracolistico: lasciate fare a me!
Il miracolo (vv. 19-21). Effettivamente poi Gesù intreccia il suo operato con la richiesta di collaborazione a tutti, nel più profondo affidamento a Dio. Ai discepoli, avute le risorse disponibili, domanda di darsi da fare personalmente con lui nel servire la gente. Alla folla ordina di sedersi sull’erba, «a gruppi», specifica Marco (Mc 6,39), perché non ha da starsene soltanto passiva. In quella posizione, infatti, realizza un minimo di ordine che consente di seguire quello che fa lui e di accorgersi di chi è vicino nella stessa necessità, per incominciare a solidarizzare. Nel provvedere convenientemente al cibo e alle necessità materiali, bisogna sempre prima di tutto uscire dalla confusione e dalle chiusure nelle preoccupazioni egoistiche. Da questo inizio si può seguire Gesù in tutti i suoi gesti che l’evangelista scandisce come lo saranno poi nell’Eucaristia: alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. In questo modo quel miracolo è stato la preparazione di quello permanente dell’Eucaristia, con il quale i cristiani sono chiamati a contribuire per rendere sempre possibile il miracolo, universalmente e perennemente urgente, della solidarietà e dello sviluppo nella pace.
Meditazione
La comunione e l’alleanza sono sancite da un banchetto, segno di convivialità e di celebrazione della vita. La promessa di Dio dell’«alleanza eterna» (Is 55,3) è accostata all’invito a partecipare al banchetto che suggella il sacrificio di comunione che normalmente accompagna la stipulazione dell’alleanza (prima lettura). Gesù dona cibo abbondante e sazia una folla numerosa condividendo il poco a disposizione (vangelo).
La gratuità del cibo, sottolineata nella prima lettura («comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte»: Is 55,1) come nel vangelo, dove il banchetto imbandito da Gesù è frutto di condivisione e si oppone alla richiesta dei discepoli di congedare le folle perché possano andare a comprarsi da mangiare (Mt 14,15), rientra nella dimensione escatologica che il banchetto riveste ed è espressione di un’istanza di giustizia e fratellanza da cui nessuno può restare escluso. Riprendendo le espressioni di Ap 21,4, che evocano la situazione della Gerusalemme celeste istituendo un confronto con la condizione storica e terrena e delineandola come situazione in cui non vi sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, noi potremmo aggiungere anche: «non ci sarà più fame». Ma sperare un mondo dove non esista più la piaga della fame e dove non si muoia più per fame, ha il prezzo dell’impegno quotidiano, qui e ora, per dar da mangiare agli affamati, per debellare le cause strutturali che riducono alla fame intere popolazioni.
Prima di aver a che fare con l’eucaristia, i nostri testi hanno a che fare con l’umanissimo atto di mangiare. Mangiare è un’arte. «Gli animali si pascono; l’uomo mangia; solo l’uomo intelligente sa mangiare» (Anthelme Brillat-Savarin). Il testo di Isaia inizia con un invito: a mangiare si è chiamati. È il nostro corpo che ci chiama a mangiare. Ma poi, giacché gli uomini mangiano insieme, il banchetto è segnato da un invito che altri ci ri-volgono. E mangiare significa anche attendersi e condividere (ciò a cui Paolo richiama i cristiani di Corinto: 1 Cor 1,21-22.33-34).
Il cibo che sfama non è solo quello costituito da «grasse vivande e vini eccellenti» (Is 25,6), ma quello delle relazioni umane. Relazioni evocate negli imperativi di Is 55,2-3: «Porgete l’orecchio e venite a me».
La pericope evangelica inizia con l’annotazione che Gesù parte su una barca e si ritira in disparte, in un luogo deserto, dopo aver appreso la notizia della morte di Giovanni Battista (Mt 14,13). Gesù cerca la solitudine per prendere una distanza dall’evento dell’esecuzione del Battista e poter così leggere la propria responsabilità di fronte al vuoto lasciato da Giovanni. E gli eventi, ovvero le folle che lo seguono a piedi dalle città e si presentano a lui quando sbarca a riva, gli suggeriscono la risposta: «egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati» (Mt 14,14). Dalla sua sofferenza per la morte del Battista Gesù passa a vedere la sofferenza delle folle e soprattutto dei malati e degli infermi. E se ne prende cura. Entrato in contatto con la sua sofferenza, Gesù sa vedere la sofferenza delle folle e la sua compassione diviene cura, azione terapeutica. Diviene risposta umile e fattiva al male del mondo.
La sua assunzione di responsabilità nei confronti delle folle contrasta apertamente con l’atteggiamento dei discepoli che vorrebbero che Gesù licenziasse la gente per consentire loro di andare ad acquistarsi viveri (Mt 14,15). Gesù dice: «voi stessi date loro da mangiare» e il comando contesta la deresposabilizzazione verso il bisognoso e suscita l’obiezione dei discepoli che vedono nella loro povertà l’impedimento ad assolverlo (Mt 14,17: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!»). Questa la reazione scandalizzata dei discepoli – e di noi con loro – in nome del buon senso, della razionalità e dell’efficienza. Nella risposta di Gesù (Mt 14,18) la povertà non solo non è un impedimento, ma è la condizione che manifesta la potenza della condivisione e dell’azione di Dio. La povertà della chiesa è la condizione della sua efficacia evangelica: essa svela la sua fede che consente alla potenza di Dio di agire.
Preghiere e racconti
L’aiuto verso i nostri fratelli
“Un uomo bussò alla porta di un amico per chiedergli un favore: ‘Puoi prestarmi quarantamila denari? Devo saldare un debito’.
L’altro chiese alla moglie di prendere tutti i loro risparmi e gli oggetti di valore: il piccolo tesoro, però, si rivelò insufficiente. Chiesero aiuto ai vicini e, alla fine, fu raccolta la somma necessaria.
Quando l’uomo se ne fu andato, la donna notò che il marito stava piangendo.
‘Perché sei triste?’ Gli domandò. ‘Per il fatto che ci siamo indebitati con i vicini e non sai se saremo in grado di onorare il nostro debito?’.
‘No, affatto. Piango perché nutro un grande affetto per quell’amico, eppure non mi sono mai preoccupato per lui. Mi è ritornato alla mente soltanto quando si è presentato alla nostra porta per chiedere un prestito’.
Andate, dunque, e raccontate la storia di ciò che è accaduto questo pomeriggio. E ricordate che dobbiamo aiutare i nostri fratelli ancor prima che ce lo chiedano.”
(Paulo COELHO, Il manoscritto ritrovato ad Accra, Bompiani, Milano, 2012, 174-175)
Il pane
Il pane gioca tanti ruoli! Nel pane abbiamo imparato a riconoscere un mezzo di comunione fra gli uomini, a causa del pane da spezzare insieme. Nel pane abbiamo imparato a riconoscere l’immagine della grandezza del lavoro, a causa del pane da guadagnare con il sudore della fronte. Nel pane abbiamo imparato a riconoscere il veicolo essenziale della pietà, a causa del pane che si distribuisce nell’ora della miseria. Il sapore del pane condiviso non ha uguale.
(A. de Saint-Exupéry, Pilota di guerra)
Dare
Date poca cosa se date le vostre ricchezze.
È quando date voi stessi che date veramente.
Che cosa sono le vostre ricchezze se non ciò che custodite e nascondete nel timore del domani?
E domani, che cosa porterà il domani al cane troppo previdente che sotterra l’osso nella sabbia senza traccia, mentre segue i pellegrini alla città santa?
E che cos’è la paura del bisogno se non bisogno esso stesso?
Non è forse sete insaziabile il terrore della sete quando il pozzo è colmo?
Vi sono quelli che danno poco del molto che possiedono, e per avere riconoscimento, e questo segreto desiderio contamina il loro dono.
E vi sono quelli che danno tutto il poco che hanno.
Essi hanno fede nella vita e nella sua munificenza, e la loro borsa non è mai vuota.
Vi sono quelli che danno con gioia e questa è la loro ricompensa.
Vi sono quelli che danno con rimpianto e questo rimpianto è il loro sacramento.
E vi sono quelli che danno senza rimpianto né gioia e senza curarsi del merito.
Essi sono come il mirto che laggiù nella valle effonde nell’aria la sua fragranza.
Attraverso le loro mani Dio parla, e attraverso i loro occhi sorride alla terra.
È bene dare quando ci chiedono, ma meglio è comprendere e dare quando niente ci viene chiesto.
(K. GIBRAN, Il profeta).
Una compassione immensa
Gesù si ritira, ma le folle non si allontanano da lui neppure in questa circostanza. Lo seguono, attaccate a lui, e non sono spaventate neppure da quel che è successo a Giovanni. Così grande è il loro affetto, così grande il loro amore che vince ogni cosa e rimuove ogni difficoltà. Perciò ricevettero subito la ricompensa. Dice il vangelo: «Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla e provò compassione per loro e guarì i loro malati» (Mt 14,14). Anche se grande era il loro attaccamento a lui, tuttavia quello che egli faceva oltrepassava la ricompensa meritata da un qualunque zelo. Perciò l’evangelista indica come causa di simili guarigioni la compassione, una compassione immensa. Gesù guarisce tutti. E non chiede fede in questo caso, perché venendo a lui, abbandonando le città, cercandolo con cura e rimanendo con lui nonostante la fame, mostrano la loro fede. […] Anche se il luogo è deserto, è presente colui che nutre il mondo; anche se il tempo è passato, parla con voi colui che non è sottomesso al tempo. […] Gesù ordina che le folle si stendano sull’erba per insegnare loro ad amare la sapienza. Non voleva infatti nutrire soltanto i corpi, ma anche educare l’anima. Per mezzo di quel luogo, col fatto che non dava loro nient’altro se non pane e pesce, metteva davanti a tutti le stesse cose, le faceva diventare comuni e non offriva all’uno niente di più che all’altro, insegnava l’umiltà, il dominio di sé, l’amore, e ammoniva ad avere la stessa disposizione d’animo gli uni verso gli altri e a considerare tutto comune. […] Impariamo dunque anche noi a stare vicini a Gesù, ma non perché ci ha dato doni materiali, per non essere rimproverati come i giudei. Infatti dice il Signore: «Mi cercate non perché avete visto dei prodigi, ma perché avete mangiato i pani e vi siete saziati» (Gv 6,26). Per questo non compie continuamente questo prodigio, ma soltanto due volte, in modo che siano ammaestrati a non essere schiavi del ventre, ma a cercare sempre i beni spirituali. A questi beni teniamoci sempre stretti anche noi e cerchiamo il pane celeste e, ricevutolo, scacciamo ogni preoccupazione materiale. Se quelli, infatti, lasciarono casa, città, parenti e ogni altra cosa e rimanevano nel deserto, nonostante la fame, senza allontanarsi quanto più noi accostandoci a tale mensa mostriamo una maggior sapienza e amiamo i beni spirituali cercando poi quelli materiali.
(GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Matteo, om. 49,1-3, PG 58,497-500).
Il povero acrobata
La Madonna, con il Bambino Gesù fra le braccia, aveva deciso di scendere in Terra per visitare un monastero. Orgogliosi, tutti i monaci si misero in una lunga fila, presentandosi ciascuno davanti alla Vergine per renderle omaggio. Uno declamò alcune poesie, un altro le mostrò le miniature che aveva preparato per la Bibbia e un terzo recitò i nomi di tutti i santi. E così via, un monaco dopo l’altro, tutti resero omaggio alla Madonna e al Bambino.
All’ultimo posto della fila ne rimase uno, il monaco più umile del convento, che non aveva mai studiato i sacri testi dell’epoca. I suoi genitori erano persone semplici, che lavoravano in un vecchio circo dei dintorni, e gli avevano insegnato soltanto a far volteggiare le palline in aria.
Quando giunse il suo turno, gli altri monaci volevano concludere l’omaggio perché il povero acrobata non aveva nulla di importante da dire e avrebbe potuto sminuire l’immagine del convento. Ma anche lui, nel profondo del proprio cuore, sentiva un bisogno immenso di offrire qualcosa a Gesù e alla Vergine.
Pieno di vergogna, sentendosi oggetto degli sguardi di riprovazione dei confratelli, tirò fuori dalla tasca alcune arance e cominciò a farle volteggiare: perché era l’unica cosa che egli sapesse fare.
Fu solo in quell’istante che Gesù Bambino sorrise e cominciò a battere le mani in braccio alla Madonna. E fu verso quel monaco che la Vergine tese le braccia, lasciandogli tenere per un po’ il bambinello.
(Paulo Coelho, L’alchimista, prefazione).
La tavola del Signore
Nel suo essere frutto della terra e del lavoro dell’uomo, della natura e della cultura, il pane esprime il bisogno, ciò che davvero è necessario per vivere. Non a caso la parola «pane» indica cibo essenziale e non superfluo: quando diciamo che «non c’è pane», evochiamo fame e carestia, cosi come del fenomeno migratorio non c’è spiegazione più tragicamente semplice dell’evidenza che sempre gli affamati corrono verso il pane perché il pane non corre dove c’è la fame. Una corsa, quella cui assistiamo oggi – dalle sponde meridionali a quelle settentrionali del Mediterraneo – che segue il percorso compiuto proprio dalla cultura del pane quasi cinquemila anni fa. Pane, allora, anche come cifra della nostra capacità di condivisione, della nostra disponibilità o meno a spezzarlo perché tutti ne possano avere, pane che, secondo i racconti evangelici, basta per tutti solo quando è spezzato e condiviso.
E la civiltà del Mediterraneo ha sempre accostato al pane un altro frutto della terra e del lavoro umano: il vino. Anche qui, il gratuito accanto all’essenziale, il dono accanto al necessario, la gioia accanto alla sostanza: il pane fa vivere, il vino dà gusto alla vita; il pane ritempra le forze, il vino rallegra il cuore; il pane fa corpo con il lavoro, il vino ne addolcisce le fatiche. Pane e vino sulla tavola sono lì a ricordarci la grandezza dell’uomo e a interpellare la nostra sensibilità: quanta fatica e quanta speranza sono raccolti in quei due semplici alimenti, quanti volti appaiono dietro di loro! Il contadino e il mugnaio, il fornaio e il vignaiolo, e poi il bottaio e il mercante, le loro famiglie e i loro bambini, le ansie e le speranze di un anno, le grida della vendemmia e i canti della mietitura, il silenzio delle cantine e dei granai, il rumore della mola e il pigiare nei tini … E ora sono lì, raccolti sulla nostra tavola, a narrarci la qualità della nostra umanizzazione, a interpellarci su chi siamo e su come desideriamo che sia il nostro mondo.
Forse anche per questo, come ha giustamente osservato Predrag Matvejevié, «la storia della fede e quella del pane hanno spesso strade parallele o contigue o simili». Non a caso nell’ebraismo e nel cristianesimo il pane e il vino sono elementi essenziali della liturgia per eccellenza, il memoriale della Pasqua.
Anche se ormai pochi ci fanno caso, ogni volta che le comunità cristiane si riuniscono per celebrare il grande mistero della loro fede lo fanno con il pane e il vino disposti su una mensa che i cristiani chiamano la «tavola del Signore». È cosi che mettono davanti a Dio tutta la creazione, tutto l’universo fisico, sintesi di ciò che vive, e insieme il lavoro dell’uomo, sintesi della fatica, della tecnica, della scienza, della capacità di abitare il mondo. E con spirito di profezia compiono sul pane e sul vino il gesto compiuto da Gesù, promessa di trasfigurazione di questo mondo e delle loro vite nella vita del loro Signore: al cuore della vita spirituale più intensa, il pane con la sua materialità e il suo significato appare come la realtà, il cibo capace di narrare il più grande mistero cristiano.
(Enzo BIANCHI, Il Pane di ieri, Einaudi, Torino, 2008, 42-44).
Signore, non sono capace…
Credo, Signore, che sarei capace di compiere una volta,
qualche atto straordinario. Un’azione che impegnerebbe tutto me stesso,
se fossi sconvolto da una sventura, colpito da un’ingiustizia,
se uno dei mie cari fosse in pericolo…
Ma ciò che mi umilia e spesso mi scoraggia,
è che non sono capace di donare la mia vita pezzo a pezzo,
giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto,
donare, sempre donare… e darmi!
Questo non posso farlo e tuttavia
è certamente ciò che tu mi chiedi…
Ogni giorno mille frammenti di vita da donare,
in mille possibili gesti d’amore,
che più non si vedono tanto sono abituali,
e più non si notano tanto sono banali,
ma di cui tu mi dici di aver bisogno per mettere insieme un’offerta
e perché un giorno io possa dire in verità:
Ai miei fratelli io ho donato tutta la mia vita.
E ciò che desideri, Signore, ma non ne sono non posso farlo, lo so, ed ho paura.
Figliolo, io non ti chiedo di riuscire sempre, ma di provarci sempre.
E soprattutto ascoltami, ti chiedo di accettare i tuoi limiti,
di riconoscere la tua povertà e di farmene dono,
perché donare la propria vita non vuol dire donare soltanto le proprie ricchezze,
ma anche la propria povertà, i propri peccati.
Fa’ questo, figliolo, e con i pezzi di vita sciupata,
da te sottratti a tutti coloro che aspettano,
colmerò i vuoti, dandoti in cambio la durata,
perché nelle mie mani la tua povertà offerta,
diventerà ricchezza per l’eternità.
(Michel Quoist)
La tavola dell’umanizzazione
Allora come oggi, se è degna di tal nome, la tavola si accende quando ci sono invitati. Invitare qualcuno parenti, amici, conoscenti… è un atto di grande fede, di profonda fiducia nell’altro: significa infatti chiamarlo, eleggerlo, distinguerlo tra gli altri conoscenti; significa confessare il desiderio di stare insieme, di ascoltarsi, di conoscersi maggiormente. Chi non pratica questa ospitalità vive in angustie, vive “poco”, mi verrebbe da dire. Non conosce la gioia che è maggiore nell’invitare che nell’essere invitati. Occorrerebbe saper invitare senza mai pensare alla reciprocità: l’atto in sé è ricompensa. Non è un caso che anche nel Vangelo, uno degli insegnamenti di Gesù che ridimensiona l’assoluto della reciprocità oggi tanto di moda quando ci fa comodo riguarda proprio l’invito a tavola: “Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né ricchi vicini, perché anch’essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio”.
Poter dire in verità “la mia casa è aperta, la mia tavola non è solo per me e per i miei” significa aprirsi agli altri, dar loro fiducia, disporsi a lasciarsi arricchire dalla loro presenza, a nutrirsi di sapienza e di amicizia, a veder dischiudersi nuovi orizzonti. Non si tratta di fare della propria tavola un “salotto” che esibisca lo status raggiunto, bensì di saper vivere la fraternità, lo stare insieme, l’amicizia gratuita. Quando c’è un ospite a tavola cresce la capacità di benedizione e di gratitudine, così che quando giunge il momento dei saluti alla fine del pasto ci si apre a una promessa orientata al futuro: ci sarà ancora un domani per ritrovarci, avremo ancora nuove possibilità di incontro…
Chi mi ha educato mi diceva sempre che è la tavola il luogo in cui ci esercitiamo a vivere la fede, la speranza, l’amore. La tavola è il luogo della fiducia nell’altro, dello sperare insieme qualcosa di comune per il futuro, dell’amore nello scegliere, preparare, offrire e servire il cibo agli altri. In questa scuola di umanizzazione tre elementi legano il pasto dall’inizio alla fine: il pane, le bevande e la parola. Ma è la parola che costituisce il legame più profondo fra tutti gli attori del pasto: è la parola che narra gli alimenti diversi che giungono in tavola, è la parola che unisce i presenti e gli assenti, i commensali e gli altri, è la parola che mette in relazione il passato con il presente, aprendoli al futuro. La parola a tavola può essere davvero strumento di comunione, mezzo privilegiato per conferire senso al pasto, per valorizzare il gusto degli alimenti, per suscitare l’arte dell’incontro.
Stare a tavola insieme è un linguaggio universale tra i più determinanti e decisivi per l’umanizzazione di ciascuno di noi. A tavola, piccoli e grandi, vecchi e giovani, genitori e figli, siamo tutti commensali, tutti con lo stesso diritto di parola e con lo stesso diritto al cibo che arricchisce la tavola. Davvero stare a tavola è molto più che saper nutrirsi: è saper vivere.
(Enzo BIANCHI, Ogni cosa alla sua stagione, Einaudi, Torino, 2010, 45-47).
Preghiera
Con i tuoi segni, Gesù, vuoi farmi conoscere la tua identità di Figlio di Dio e introdurmi nel mistero della tua persona e della tua missione.
Perdona il mio pragmatismo che si ferma all’interesse immediato, alla superficie della realtà. Non so darti il poco che possiedo; ma poi, quando con quel poco tu operi grandi cose, vi resto abbarbicato e non vado più in profondità, dove tu mi vuoi condurre. Un Dio che risolve i problemi contingenti della vita mi va bene, ma un Dio che mi propone di essere sempre dono totale e gratuito per gli altri mi scandalizza. Tu mi ripeti, Gesù, che proprio questa, invece, è la mia vocazione di figlio del Padre.
Ancora una volta, alla tua scuola, che io impari ad amare.
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
– Temi di predicazione. Omelie. Ciclo A, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2004;2007-.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– Comunità domenicana di Santa Maria delle Grazie, La grazia della predicazione. Tempo ordinario – Parte prima, in «Allegato redazionale alla Rivista del Clero Italiano» 95 (2014) 5, pp. 36.
– C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.
– E. BIANCHI et al., Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche. Tempo ordinario anno A, Milano, vita e Pensiero, 2010.
– F. ARMELLI, Ascoltarti è una festa. Le letture domenicali spiegate alla comunità. Anno A, Padova, Messaggero, 2001.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, L’infanzia di Gesù, Milano/Città del Vaticano, Rizzoli/Libreria Editrice Vaticana, 2012.
– J. RATZINGER/BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Milano, Rizzoli, 2007.