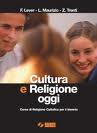L’esposizione del crocefisso nella aule scolastiche non ha influenza sugli alunni
L’ottimismo che trapelava alla vigilia della sentenza sul crocifisso nelle scuole in seno al governo ha avuto conferma: la Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo riunitasi a Strasburgo ha assolto l’Italia dall’accusa di violazione dei diritti umani per l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche.
La decisione della Corte è stata approvata con 15 voti favorevoli e due contrari. I giudici hanno accettato la tesi in base alla quale non sussistono elementi che provino l’eventuale influenza sugli alunni dell’esposizione del crocefisso nella aule scolastiche.
In questa maniera, la Corte scrive la parola fine sul dossier del caso ‘Lautsi contro Italia’. Un procedimento approdato a Strasburgo il 27 luglio del 2006. Allora l’avvocato Nicolò Paoletti presentò il ricorso con cui Sonia Lautsi, cittadina italiana nata finlandese, lamentò la presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dai figli, ritenendo che si trattasse di un’ingerenza incompatibile con la libertà di pensiero e il diritto ad un’educazione e ad un insegnamento conformi alle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.
La prima sentenza della Corte (9 novembre 2009) diede sostanzialmente ragione alla signora Lautsi, affermando la violazione da parte dell’Italia di norme fondamentali sulla libertà di pensiero, convinzione e religione. Il Governo italiano, a quel punto, domandò il rinvio alla Grande Chambre della Corte, ritenendo la sentenza 2009 lesiva della libertà religiosa individuale e collettiva come riconosciuta dallo Stato italiano.
 Sentenza sul crocifisso, ecco le motivazioni
Sentenza sul crocifisso, ecco le motivazioni
Per la Corte, “un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose”
“Se è vero che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non sussistono tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l’eventuale influenza che l’esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni“. è un passo delle motivazione della sentenza della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo che, a grande maggioranza (15 giudici contro 2) ha dato ragione all’Italia nella causa “Lautsi e altri contro Italia” sulla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche stabilendo che nell’esposizione del simbolo religioso non c’è violazione dei diritti dell’uomo.
Secondo la ricorrente Soile Lautsi, cittadina italiana di origini finlandesi, la presenza del crocifisso costituiva un’ingerenza incompatibile con libertà di pensiero, convinzione e di religione (art.9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950) così come del diritto all’istruzione, in particolare, il diritto ad un’educazione ed insegnamento conformi alle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori (art.2 del Protocollo n.1).
Nella motivazione della sentenza, in merito proprio all’articolo 2 del protocollo 1 sul diritto all’istruzione, si legge che “dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’obbligo degli Stati membri del Consiglio d’ Europa di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non riguarda solo il contenuto dell’istruzione e le modalità in cui viene essa dispensata: tale obbligo compete loro nell’esercizio dell’insieme delle ‘funzioni’ che gli Stati si assumono in materia di educazione e di insegnamento“.
Ciò “comprende l’allestimento degli ambienti scolastici qualora il diritto interno preveda che questa funzione incomba alle autorità pubbliche. Poiché la decisione riguardante la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche attiene alle funzioni assunte dallo stato italiano, essa rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del protocollo 1“.
Questa disposizione, si legge ancora, “attribuisce allo Stato l’obbligo di rispettare, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d’insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un’educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche“.
La Corte “constata che nel rendere obbligatoria la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la normativa italiana attribuisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico” e sottolinea altresì che “un crocifisso apposto su un muro è un simbolo essenzialmente passivo, la cui influenza sugli alunni non può essere paragonata a un discorso didattico o alla partecipazione ad attività religiose“. Infine, la Corte osserva che “il diritto della ricorrente, in quanto genitrice, di spiegare e consigliare i suoi figli e orientarli verso una direzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche è rimasto intatto“. La Corte conclude dunque che “decidendo di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai bambini della ricorrente, le autorità hanno agito entro i limiti dei poteri di cui dispone l’Italia nel quadro del suo obbligo di rispettare, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d’insegnamento, il diritto dei genitori di garantire tale istruzione secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche“. La Grande Camera della Corte è stata presieduta da Jean-Paul Costa (Francia), il giudice Giorgio Malinverni (Svizzera) ha espresso un’opinione dissenziente, condivisa dalla giudice Zdravka Kalaydjieva (Bulgaria).
 Il crocifisso a scuola negli altri paesi europei
Il crocifisso a scuola negli altri paesi europei
Subito dopo l’uscita della sentenza della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo che ha assolto l’Italia dall’accusa di violazione dei diritti umani per l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, l’agenzia Asca ha pubblicato una breve scheda che raccoglie la disciplina della materia nelle aule scolastiche di altri paesi europei.
AUSTRIA. La presenza del crocifisso è garantita da una legge del 1949, confermata dal Concordato del 1962, in tutte le aule scolastiche nelle quali oltre metà degli alunni appartenga a una delle confessioni cristiane.
FRANCIA. In Francia l’articolo 28 della legge 9 dicembre 1905 vieta espressamente l’esposizione di simboli o emblemi religiosi su monumenti o in spazi pubblici, a eccezione dei luoghi di culto, dei campi di sepoltura, dei musei e delle mostre. Nel 2004, l’articolo 1 della legge n.228 del 15 marzo, chiamata “legge anti-velo” e approvata dal parlamento francese, precisa il divieto, nelle scuole primarie e secondarie, di indossare simboli o indumenti che ostentino l’appartenenza religiosa.
GERMANIA. Solo in Baviera il crocifisso è di norma esposto nelle aule delle scuole elementari, dato che il Land è storicamente cattolico. Se alcuni studenti obiettano che questo lede la loro libertà di coscienza, le autorità scolastiche aprono un procedimento di conciliazione, che può condurre alla rimozione. Una sentenza della Corte Costituzionale del 1995 ha sancito l’incostituzionalità della presenza dei simboli religiosi nelle aule scolastiche.
ROMANIA. In Romania, la decisione 323/2006 del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Discriminazione ha stabilito che il ministero dell’Educazione deve “rispettare il carattere secolare dello stato e l’autonomia della religione“, e che “simboli religiosi devono essere mostrati solo durante le ore di religione o in aree dedicate esclusivamente all’educazione religiosa“. Il caso nasceva dal ricorso di Emil Moise, maestro e genitore della contea di Buzau, che contestava come l’esposizione pubblica di icone ortodosse costituisse una rottura della separazione tra Stato e Chiesa in Romania, e come ciò costituisse una discriminazione contro atei, agnostici e non religiosi.
SPAGNA. Il crocifisso è affisso nelle aule scolastiche in Spagna dal 1930 ed è tuttora presente, nonostante la costituzione aconfessionale dello Stato entrata in vigore nel 1978. Nel 2009 il governo guidato da Zapatero ha messo a punto un disegno di legge per togliere ogni simbolo religioso dalla scuola pubblica. Il dibattito era già nato poco prima che un giudice di Valladolid aveva deciso di “far ritirare i simboli religiosi dalle classi e dagli spazi comuni” in una scuola di Valladolid dopo che alcuni genitori nel 2005 ne avevano chiesto la rimozione.
SVIZZERA. In Svizzera il comune ticinese di Cadro decise di mettere il crocifisso in tutte le aule scolastiche, ma nel 1990 il Tribunale Federale si pronunciò contro l’esposizione dei crocifissi e per la loro rimozione con la motivazione che “lo Stato ha il dovere di assicurare la neutralità in ambito filosofico-religioso della sua scuola e non può identificarsi con una confessione o religione. Deve evitare che studenti e studentesse siano offesi nelle loro convinzioni religiose dalla continua presenza del simbolo di una religione a cui non appartengono”.
Sentenza sul crocifisso, soddisfazione diffusa
Sono quasi tutti positivi i primi commenti alla sentenza della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell’uomo che ha assolto l’Italia dall’accusa di violazione dei diritti umani per l’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche.
Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Mariastella Gelmini in particolare esprime in una nota “profonda soddisfazione per la sentenza della Corte di Strasburgo, un pronunciamento nel quale si riconosce la gran parte del popolo italiano. Si tratta di una grande vittoria per la difesa di un simbolo irrinunciabile della storia e dell’identità culturale del nostro Paese”.”Il Crocifisso – continua il ministro – sintetizza i valori del Cristianesimo, i principi sui cui poggia la cultura europea e la stessa civiltà occidentale: il rispetto della dignità della persona umana e della sua libertà”. “E’ un simbolo dunque – conclude – che non divide ma unisce e la sua presenza, anche nelle aule scolastiche, non rappresenta una minaccia né alla laicità dello Stato, né alla libertà religiosa. Oggi è un giorno importante per l’Europa e le sue istituzioni che finalmente, grazie a questa sentenza, si riavvicinano alle idee e alla sensibilità più profonda dei cittadini”.
Quella sul crocifisso in classe è una “vittoria” anche per la Radio Vaticana, vittoria che “non è solo dell’Italia ma anche di questi Paesi e di tutti coloro che ritenevano assurdo imporre la rimozione del Crocifisso dalle aule scolastiche“. La Radio Vaticana ha anche ricordato che la posizione italiana nella vicenda “ha trovato l’appoggio formale, davanti alla Corte, di San Marino, Malta, Lituania, Romania, Bulgaria, Principato di Monaco, Federazione Russa, Cipro, Grecia e Armenia“.
La soddisfazione della Santa Sede trapela anche nel primo commento del portavoce vaticano, p. Federico Lombardi: “La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sull’esposizione obbligatoria del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane e’ accolta con soddisfazione da parte della Santa Sede”.
Soddisfazione è espressa anche da esponenti di tutti i partiti politici, sia di centro-destra che di centro-sinistra, come pure dalla gran parte del mondo dell’associazionismo, non solo cattolico.
Ad uscire del coro è comprensibilmente il ricorrente Massimo Albertin, il medico di Abano Terme che otto anni fa aveva iniziato con la moglie finlandese, Solile Lautsi, una battaglia legale contro il crocifisso nella scuola frequentata dai figli, che dichiara: “Il pronunciamento di Strasburgo mi delude, molto, perché la prima sentenza su questa vicenda era clamorosamente chiara. Pare – dice il medico padovano – che sia tutto legato al “margine di apprezzamento” sull’applicazione dei diritti umani, per cui la Corte può decidere su determinate materie di lasciare più margine ai singoli Stati. Ma se ci sono dei diritti da far rispettare, non si capisce perché questi in Italia possano essere diversi da quello che sono in Francia o in altri Paesi dell’Unione”.
Critiche alla sentenza anche dal rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni: “La sentenza esprime una delle opinioni contrapposte in questa discussione. Nello specifico, ho sempre sostenuto una tesi differente da questa. La mia opinione personale è che nell’edificio pubblico ci deve essere spazio solo per simboli condivisi e non di una parte, anche se è rispettabile e di maggioranza. Ciò premesso, mi rendo conto della durezza polemica della questione e delle tradizioni e sensibilità della maggioranza cristiana del nostro Paese, e non ho voluto mai farne una guerra di religione”. Quanto alla tesi sostenuta dal governo italiano nel suo ricorso, per Di Segni, “dire che il crocifisso è simbolo culturale è, a mio parere, mancargli di rispetto. E non mi ci riconosco come simbolo culturale”.
tuttoscuola.com venerdì 18 marzo 2011
– I COMMENTI L’Europa salva le sue radici
– INTERVISTA Cardia: il più bel regalo per i 150 anni della nazione
– VAI AL DOSSIER»
- I valori della persona nel simbolo del crocifisso di Bruno Forte in Il Sole 24 Ore del 20 marzo 2011
- “Riconosciuto il valore universale di un simbolo religioso” intervista a Camillo Ruini a cura di Giacomo Galeazzi in La Stampa del 19 marzo 2011
- Fisichella: «Impensabile uno spazio pubblico senza quel simbolo» intervista a Rino Fisichella a cura di Gian Guido Vecchi in Corriere della Sera del 19 marzo 2011
- La forza del simbolo Il crocifisso e la religione prevalente intervista a Sergio Luzzatto a cura di Andrea Fabozzi in il manifesto del 20 marzo 2011
- Il crocifisso non può essere imposto di Gian Mario Gillio in l’Unità del 20 marzo 2011
- Uno stato laico non offende nessuno di andrea Satta in l’Unità del 20 marzo 2011
Sentenza del 2009
La sentenza del 2011