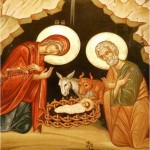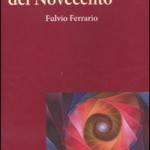Lectio – Anno B
Prima lettura: Genesi 15,1-6; 21,1-3
|
In quei giorni, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito.
|
La prima lettura mostra come già l’AT aveva preparato una mentalità che il Vangelo ha poi sviluppato al massimo: i figli sono dono di Dio. Di conseguenza, i genitori devono conservare viva la coscienza che non sono loro proprietà, ma li hanno «in gestione». La vicenda di Gesù, dono di Dio a Maria per opera dello Spirito Santo e affidato alle cure di Giuseppe, ha un suo prologo nella storia di Abramo ed Isacco. Costui nasce in modo insolito, fuori cioè dalle normali leggi biologiche (Abramo e Sara sono anziani) e apparterrà a Dio in modo peculiare, quasi sottratto al padre che dovrà essere pronto a «restituirlo» a Dio, quando e come Egli vorrà. L’episodio del cap. 22, chiamato spesso Il sacrificio di Isacco, è prima di tutto il riconoscimento del primato di Dio: la vita è suo dono e gli appartiene, sempre e comunque. Sia Abramo, sia Isacco, sono pronti a riconoscere tale primato divino.
La prima lettura si colloca in questo contesto, anche se il suo raggio di azione è limitato a due punti: il credito dato da Abramo alla promessa divina, secondo cui un suo diretto erede sarà il primo anello di una lunga discendenza (15,1-6), e, secondo punto, la nascita di Isacco che conferma la validità della promessa (21,1-3). Il brano liturgico, composto dai due spezzoni appena individuati, si colora teologicamente, soprattutto dopo aver conosciuto la storia di Gesù.
La prima parte ribadisce da parte di Dio l’impegno, precedentemente preso (cf. Gn 12,2.7; 13,14-17), di assicurare al patriarca Abramo una numerosa discendenza. Data l’età di Abramo e della moglie, non è umanamente ipotizzabile un discendente diretto e si pensa quindi ad una linea «laterale». Dio corregge l’interpretazione di Abramo, troppo umana, e garantisce uno del suo sangue.
Dio è sempre al superlativo: la vita di cui lui è la fonte, sgorgherà in modo abbondante, affidata alla suggestiva immagine di una discendenza più numerosa delle stelle del cielo (cf. v. 5). Noi oggi siamo in grado di azzardare dei numeri, ovviamente molto approssimativi: nella nostra galassia sono presenti non meno di cento miliardi di stelle; nel firmamento, poi, sono presenti milioni di galassie… i numeri diventano veramente «astronomici». Ad occhio nudo, in buone condizioni, si arriva a contare circa seimila stelle… Gli antichi non erano informati come noi, usavano però l’espressione per indicare una quantità incommensurabile. La metafora, letta dalla prospettiva di Abramo, intende dire la quantità smisurata della sua discendenza, letta dalla prospettiva di Dio, lo rende veramente «signore della vita».
Abramo non dubita della promessa, non avanza sospetti o riserve. La sua incondizionata accoglienza, gli diventa titolo di credito per un rapporto preferenziale con Dio. È, in parte, quanto significa l’enigmatico, ma sostanzioso, detto del v. 6: «Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia». Paolo lo renderà il cuore della sua dottrina sulla giustificazione, com’è dato vedere in Gal 3,6 e soprattutto in Rm 4,3.
La seconda parte mostra la realizzazione della promessa divina. La Parola di Dio produce quanto annuncia, esattamente come la parola creatrice di Genesi, 1. L’espressione «Il Signore visitò Sarà» ribadisce, semmai sussistessero delle perplessità, che la nascita di Isacco è dono di Dio. A maggior ragione, Isacco gli appartiene. Lo si capirà meglio nella storia che segue, quando Dio avanzerà delle pretese che umanamente parlando, risultano illogiche e assurde. Ma anche in quel caso, a trionfare, sarà il concetto di un Dio, Signore della vita.
Seconda lettura: Ebrei 11,8.11-12.17-19
|
Fratelli, per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare.
Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo.
|
Un ulteriore apporto al tema familiare viene dalla Lettera agli Ebrei che al cap. 11 offre una lunga meditazione sulla fede, passando in rassegna quadri e personaggi della storia di Israele. È la fede l’elemento che determina l’essere e l’agire del vero fedele, prendendolo e penetrandolo tutto quanto.
Il nostro brano isola le due figure di Abramo e Sara, una coppia di sposi, chiamata a generare in modo del tutto speciale. Questo tema è stato scelto, perché, ovviamente, si iscrive bene nella festa liturgica odierna. È altresì una nuova, complementare visione, della tematica trattata nelle letture precedenti. Così i testi liturgici rispondono ad un tema organico ed unitario.
Si parte dalla chiamata di Abramo, elemento primitivo e fondante, che mostra un uomo disposto ad andare dove Dio vuole, ignaro della meta (v. 8). Poi il discorso si fa più preciso, parlando di Abramo e Sara come genitori: lo sono non per legge naturale, ma in base alla promessa divina, che permette una realizzazione superlativa: essi stanno all’origine di una moltitudine incommensurabile (vv. 11-12). È come riconoscere, che Dio è sempre «esagerato», mai uno «dalle mezze misure». Quando da lui sprizza la vita, questa diventa sorgente che zampilla in continuazione.
La vita di Isacco, sorta improvvisamente dalla misericordia di Dio, è chiesta da Dio stesso (vv. 17-19). Per due volte si dice che «Abramo offrì» la vita del figlio, per sottolineare la disponibilità del genitore a riconoscere la vera «paternità» di Isacco, quella divina. Potremmo azzardare il verbo «restituire»: Abramo è cosciente di non poter possedere il figlio Isacco come si possiede un oggetto, e quindi non ne vuole disporre a piacimento. Nel verbo «offrì» leggiamo tutta la disponibilità di Abramo a riconoscere la suprema e sovrana volontà divina.
L’anonimo Autore della Lettera fa compiere un progresso interpretativo al racconto di Gn 22, perché aggiunge, parlando di Abramo: «Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo» (v. 19). Il testo biblico di Genesi è molto più laconico e non individua né, tanto meno, esplicita i sentimenti di Abramo. L’Autore di Ebrei, invece, nel suo contesto di presentazione della fede, non trova strano attribuire al patriarca tale convinzione, evidentemente evincendola dal suo atteggiamento di fede incondizionata, che lo porta a seguire in tutto la volontà divina, anche quando l’intelligenza umana o il comune buon senso suggerirebbero il contrario.
Così facendo, Abramo dimostra di non esercitare alcun possesso nei confronti del figlio, e, positivamente, di rispettare al massimo la volontà divina, anche quando il fiat può costare sangue che gronda dal cuore ferito di padre. Davvero una fede genuina, scintillante, che realizza quanto l’Autore aveva espresso all’inizio del capitolo: «La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Per mezzo di questa fede gli antichi ricevettero buona testimonianza» (11,1-2)
Vangelo: Luca 2,22-40
|
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
|
Esegesi
Nel contesto del Vangelo dell’infanzia, Luca ci regala questo stupendo quadro familiare: Giuseppe, Maria e Gesù. La cronaca di un fatto si riveste di smagliante colore teologico che impreziosisce e conferisce il massimo splendore all’evento. È l’occasione per parlare di Gesù che viene presentato al tempio. È lui il vero protagonista di questi fatti.
Egli è il centro letterario e teologico. Letterario perché un esplicito riferimento a Lui apre e chiude il brano: «Portarono il bambino a Gerusalemme» (v. 22); «Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui» (v. 40). Ma è anche il centro teologico, già emerso nelle due citazioni appena riportate: Egli è per la prima volta a Gerusalemme, la città che sarà, più tardi, testimone della sua morte e risurrezione. Inoltre, la conclusione allude alla sua pienezza di sapienza, nonché alla grazia con la quale egli mostra un’affinità singolare. E «grazia» richiama, lo sappiamo, un dono divino, anzi, qualcosa di esclusivamente divino.
All’inizio è ricordata la legge sui primogeniti: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» (v. 23: cf. Es 13,2.11). Siamo rimandati all’intervento liberatorio di Dio in Egitto al tempo dell’esodo. I primogeniti, a perenne riconoscenza di tale liberazione, diventavano come proprietà di Dio. Detto in linguaggio più teologico, gli erano consacrati. Per poter riappropriarsi del figlio, i genitori compivano un gesto ricco di simbolismo, offrendo qualcosa a Dio in cambio del figlio che riportavano a casa. L’offerta di Gesù era il primo atto che i genitori dovevano compiere. Doveva seguire il secondo, il riscatto, come prescrive Es 13,13. Questo non avviene o, per essere più precisi, non è detto esplicitamente dal testo.
Possiamo tentare di capire la portata teologica del fatto. Gesù, portato al tempio e qui consacrato a Dio, non può essere riscattato, perché è e rimane reale «proprietà» di Dio e non potrà mai essere proprietà dei suoi genitori. L’episodio di Gesù dodicenne che si ferma al tempio, dimostra che là Gesù si trova bene, a suo agio, nella casa di «suo padre».
D’altra parte, come poteva Luca presentare come riscatto (= redento) colui che è il Redentore (cf. v. 32) di Israele e che era venuto per «riscattare coloro che erano sotto la legge» (Gal 4,5)? Qui è il Gesù pasquale, morto e risorto, che emerge tra le righe. Se Gesù si sottomette in parte alla legislazione ebraica di cui è figlio, mostra anche di essere Signore della medesima.
Gesù non compie l’offerta di se stesso perché è piccolo e perciò sono necessari i genitori. Tale offerta la farà da sé, da adulto, sulla croce. Nel frattempo sono i genitori, nel ruolo di ministri, di vicari, a compiere tale gesto.
Simeone e Anna aiutano a penetrare nella comprensione profonda dell’evento. Le parole esplicite del primo e quelle implicite di Anna garantiscono al racconto un succoso significato teologico.
L’incontro con Simeone è registrato nei vv. 25-35. I pittori pongono di solito Simeone al centro della composizione e lo rappresentano, vecchio, nell’atto di offrire il bambino. Il testo evangelico non dice però che fu Simeone ad offrire il bambino, ma solo che «lo accolse tra le braccia» (v. 28). Chi presentò il bambino furono i genitori, come Luca mette ben in evidenza: «portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore» (v. 23). Simeone c’è, ma non è indispensabile per il fatto, sarà invece molto utile per il significato. Saranno le sue parole, in parte enigmatiche, a colorire in modo pasquale l’avvenimento.
Nell’abituale traduzione «Ora puoi lasciare» sembra quasi che Simeone chieda qualcosa. In realtà il verbo greco è all’indicativo e va quindi tradotto «ora tu stai sciogliendo». Nelle sue parole si coglie la gioia di aver contemplato una gloria che è destinata a tutti. È già un’anticipazione della pienezza cristiana dopo la risurrezione. Infatti il discorso di Simeone ha sempre come centro Gesù, chiamato «salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». L’idea di salvezza e la prospettiva universale (tutti i popoli, le genti) non può che fare riferimento al mistero pasquale, al momento in cui tutti gli uomini indistintamente sono compresi nell’amore redentivo di Gesù.
Simeone con le sue parole profetiche sa cogliere la portata teologica, pasquale, del gesto. Così Maria e Giuseppe sono aiutati a entrare nel mistero di Gesù. Per questo il sentimento che li accompagna è la meraviglia per quello che si dice del bambino (cf. v. 33).
Infine compare anche Anna, una profetessa (vv. 36-38). Di lei l’evangelista offre alcuni particolari circa l’età, la sua condizione e soprattutto la sua presentazione di donna di fede che sa scorgere nel bambino molto più di quello che la vista permette. Infatti ella «si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme» (v. 38). Il termine «redenzione» (lytrosis) potrebbe suonare come semplice riscatto dalla schiavitù o dall’oppressione dello straniero, soprattutto nel contesto di una lettura veterotestamentaria (cf. l’uso del verbo sulla bocca dei discepoli di Emmaus, ancora irretiti in una logica nazionalista, Lc 24,21). Ma in contesto cristiano, la redenzione rimanda all’opera di Cristo morto per i peccati degli uomini. È un raggio di luce pasquale che si infila e trasfigura il significato.
Un’ulteriore conferma della lettura pasquale di questo brano viene dal riferimento di Simeone a Maria: Ella sarà attraversata dalla spada di dolore che è partecipazione alla passione del figlio. È Lui la persona determinante, colui che è causa di «caduta e la risurrezione» (v. 34). La madre che lo ha generato le sarà vicina sempre, anche nel momento del più buio dolore. Per questo potrà essere a pieno titolo Madre, Redemptoris Mater, madre del Cristo pasquale, cioè, quello morto e risorto per i peccati di tutti gli uomini.
Alla fine, la santa famiglia ritorna in Galilea, a Nazaret, quasi a riprendere i ruoli quotidiani, dopo l’esaltante esperienza nella città santa (vv. 39-40). Un misto di normalità e di straordinario conclude l’episodio. Gesù ritorna a Nazaret con Maria e Giuseppe, dopo aver ottemperato i dettami della Legge del Signore. C’è una fedeltà alla legge divina che vale come espressione di un’attenzione «scrupolosa» alla volontà divina. La crescita è umana e divina, grazie a quello sviluppo che interessa il corpo e lo spirito. Potremmo dire che Luca adotta un criterio di «straordinaria normalità» per parlare di Gesù. Non il miracolo facile, talora perfino «sciocco», dei testi apocrifi, non le manifestazioni di un enfant prodige, ma una normalità esteriore, con tocchi di straordinarietà interiore, è il messaggio sostanzioso che Luca lascia al lettore.
La santa famiglia è tutta qui: un rispetto reciproco, ognuno al proprio posto, nello svolgimento fedele del proprio ruolo, realizzando la propria vocazione e obbedendo nel massimo grado alla volontà divina.
Meditazione
Nel mistero dell’incarnazione il Figlio di Dio assume realmente la condizione umana, condividendone i ritmi di crescita nell’ordinarietà di una vita familiare, in una nascosta e poco rinomata borgata della Galilea: «Fecero ritorno … alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui» (Lc 1,39-40). Oltre a farsi obbediente alle dinamiche umane, Gesù entra nell’obbedienza alla Legge e alla tradizione religiosa del suo popolo. Maria e Giuseppe fanno tutto secondo la Legge di Mosè, come Luca ricorda con insistenza più volte (vv. 22.23.24.27.39).
La Legge è data da Dio perché il popolo possa custodire il dono dell’Alleanza. Osservando i suoi precetti, Israele cammina in quella libertà che Dio gli ha gratuitamente donato attraverso l’Esodo. L’atteggiamento del cuore che consente di vivere bene il rapporto con la Legge è la fede: attraverso l’obbedienza ai comandamenti il popolo di Dio non deve presumere di potersi salvare da solo, in forza della propria osservanza, ma può giungere a conoscere e a rimanere in una relazione fedele con Colui che lo ha liberato e continuerà a farlo.
La liturgia della Parola in questa festa insiste anzitutto nel mostrarci la fede di Abramo, al centro tanto della prima quanto della seconda lettura. Abramo crede e Dio glielo accredita come giustizia (cfr. Gen 15,6). È questa la prima volta che nella Genesi si parla della fede di Abramo. Finora egli ha ascoltato la parola di Dio, le ha obbedito, ora il suo cammino giunge a una nuova tappa: perviene a credere al Signore, o meglio, come si dovrebbe tradurre, «nel Signore». Abramo in questo momento accetta di camminare non solo verso una terra, ma verso un incontro personale con il Signore, un andare in lui. Entra nella relazione misteriosa con qualcuno che lo chiama, gli parla, lo guida, per poi dirgli: non devi avere altra garanzia che me, non devi avere altro desiderio che me, o meglio, potrai desiderare ogni altra cosa – una terra, un figlio, un erede – ma «in me». Abramo deve credere lasciandosi condurre fuori, nella notte, perché solo in questo modo potrà fare l’esperienza sorprendente di un cielo stellato che debolmente illumina le tenebre e permette un orientamento persino nel buio dell’incertezza. Solo chi sa rimanere nella notte può percepire la bellezza e la consolazione di un cielo stellato, offerto come segno della promessa di Dio. Abramo tuttavia non può contare le stelle: dovrà fidarsi del segno senza poterlo dominare o farne un suo possesso.
La lettera agli Ebrei ci ricorda fin dove giunge questa fede di Abramo: «Messo alla prova, offrì Isacco… il suo unigenito figlio… Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo» (Eb 11,17-19). Nel momento in cui non lo trattiene per sé, come sua proprietà, ma lo ridona a Dio, davvero Abramo accoglie Isacco come dono, simbolo di quell’alleanza fedele e di quella promessa di Dio che lo vuole rendere non solo padre di Isacco, ma di una moltitudine incalcolabile di credenti. Abramo diviene ora padre nella fede e dalla sua discendenza nascerà Gesù, il vero Isacco di Dio, in cui tutte le promesse si compiono e la definitiva alleanza viene stipulata. Offrendo il loro «maschio primogenito» al Signore nel tempio di Gerusalemme, Maria e Giuseppe non solo obbediscono alla Legge, ma più profondamente accolgono la stessa logica di Abramo, che è la logica della vera fede. Quello che anche per loro è stato il dono gratuito di Dio, anzi il dono per eccellenza – il dono che il Padre stesso fa del proprio Figlio unigenito – non lo trattengono per sé, lo ridonano al Signore, e in questo modo lo consegnano agli uomini tutti che attendono la salvezza. Luca nell’evangelo la definisce con i nomi tipici della tradizione biblica: «La consolazione di Israele» (v. 25) e la «redenzione di Gerusalemme» (v. 38). Il vecchio Simeone e la profetessa Anna sono i rappresentanti di questa umanità che attende consolazione, redenzione, salvezza e nella fede sa riconoscerla in questo neonato, condotto al tempio anch’egli sulle braccia della fede dei suoi genitori.
Insieme alla fede di Giuseppe e di Maria, di Simeone e di Anna, il racconto evangelico sottolinea la docilità allo Spirito Santo. Lo Spirito suscita il desiderio e sostiene l’attesa. Sia Simeone sia Anna sono anziani, al tramonto della loro vita, eppure sono rimasti abbastanza giovani da attendere ancora. Nella loro vita niente è stato tanto bello da riempirla completamente così da impedire loro di attendere; d’altra parte nulla è stato così doloroso da impedire di continuare a sperare. Hanno vissuto non accontentandosi di niente di meno del Signore e della sua consolazione.
In secondo luogo, lo Spirito aveva preannunciato a Simeone «che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore» (v. 26). Egli ha sempre creduto che la sua vita era stata fatta per essere salvata. Per lui la vita e la fede coincidono. Vivere significa vedere la salvezza del Signore. Non meno di questo. Allora tutta l’esistenza acquista senso se viene giocata in questa attesa. Perché non attendere la salvezza equivale a morire. Al contrario, vedere la salvezza non conduce alla morte, ma nella pace. Credere significa anche questo: sapere che nonostante tutte le difficoltà della vita, persino se, come accade ad Anna, ti muore un marito quando ti sei appena affacciata all’amore, nonostante tutto la vita è fatta per essere salvata. È fatta per vedere Dio. Null’altro che sia meno di Dio ne potrà placare il gemito o colmare la sete.
In questa festa la parola di Dio ci ricorda in questo modo almeno due tratti, tra molti altri, che possono rendere una famiglia luogo in cui crescere tutti, genitori e figli, nella sapienza e nella grazia: la fede che nutre l’attesa, la docilità allo Spirito che ne riconosce i segni.
Preghiere e Racconti
La santa Famiglia
Al centro di questa icona. Gesù è al tempo stesso punto focale e motivo di unione tra Maria e Giuseppe. Egli, seduto su un trono regale, è rivestito dell’abito che rivela la sua onnipotente e mite regalità; con un gesto ampio e carico di dolcezza, benedice i genitori e noi che contempliamo l’icona.
Sul capo del Figlio scende un raggio con la simbologia delle altre due Persone della divina Trinità: del Padre, a cui allude la mano creatrice, e dello Spirito Santo, nel simbolo della bianca colomba. Con il gesto indicativo delle mani, Maria e Giuseppe mostrano e porgono alla nostra fede la pienezza del Mistero della Santissima Trinità che dimora nella loro vita. Tale Mistero, che riempie e che dona armonia alla vita, è qui unito da un raggio di luce che raffigura il legame d’amore che ogni famiglia tenta di esprimere nell’umile quotidianità della vita e che la santa Famiglia di Nazaret ha vissuto in maniera compiuta.
… E tu,
Madre,
cui era stata predetta una spada nell’anima,
ogni giorno trepidante
segui la vita di un figlio che non è tuo…
Non sono nostri i figli,
Maria!
Sono i figli e le figlie della vita.
Hanno un percorso da compiere,
una gioia da realizzare,
un amore da costruire.
Come frecce scoccate lontano
i nostri figli se ne vanno…
Custodiscili tu,
o Madre,
e prega
per tutti i figli e le figlie dell’umanità
lacerata da discordie
e violenze.
Consola il nostro cuore,
come il tuo attraversato da una spada,
e sia data a tutti
benedizione e pace.
Lo stupore del Natale di Cristo
Da duemila anni, credenti, atei, santi o peccatori, ci volgiamo all’umile giaciglio su cui riposa quel Bimbo, circondato dall’affetto premuroso di Maria e di Giuseppe e riscaldato da povera paglia, dal calore del bue e dell’asinello. Il mondo si ferma, almeno per qualche istante, e trattiene il respiro dinanzi al mistero del Presepe. Ma poi riprende il suo abituale cammino, la sua danza, la sua triste “via crucis” quotidiana. La cronaca non risparmia, neppure il 25 dicembre, violenza, conflitti e tensioni. Alla fragile tregua di un momento, subentra la realtà fatta di mille incertezze, di piccole o grandi angosce e dei soliti problemi, personali o sociali, da affrontare ogni giorno.
Noi, devoti di Maria Santissima, non possiamo accontentarci appena di una tappa fugace a Betlemme. Dalla Madre del Signore vorremmo piuttosto imparare a sostare lungamente, con il cuore, e trattenerci in adorazione dinanzi al miracolo di Gesù, vivo e presente in mezzo a noi. Non perché siamo “i primi della classe”. Anzi, proprio perché, immancabilmente, ci troviamo ancora tanto indietro, nelle retrovie – consci delle miserie che ci devastano e delle insufficienze che ci opprimono – vogliamo fermarci a pregare, a meditare, a contemplare quella povera mangiatoia, altare e trono per il Re dei Re, anticipo di quella Gloria che poi rifulgerà per sempre sulla Croce. Vogliamo, ancora una volta, apprendere la lezione della infinita tenerezza di Dio per l’uomo, della misericordia che si fa carne e della maestà eccelsa che saprà abbassarsi fino alla umiliazione del Golgota. Desideriamo lasciarci attraversare da quella grazia che, sola, ridona speranza e conforta, e infonde l’infantile entusiasmo di ripartire, ridando gusto e sapore alla vita.
Il vero Tempio, lo sappiamo, è Cristo stesso, la sua umanità, unico e autentico Santuario, ricolmo dello splendore della sua Divinità. Ma è anche il nostro cuore: il Signore cerca e predilige tale umilissima dimora. Lui, che il Cielo e l’Universo intero non possono contenere, proprio lì vuole penetrare, con la luce e con la forza del suo Amore. La “Terra Santa” è il nostro spirito, dove Dio eleva la sua tenda. Anche noi, allora, per vivere lo stupore del Natale, abbiamo da scacciare dal nostro Tempio ogni giorno qualcosa: la folla di pensieri inutili e di suggestioni, che distraggono e confondono, allontanandoci da Dio e rendendoci sempre più schiavi delle creature; l’egoismo, l’attaccamento a noi stessi, l’infedeltà, l’orgoglio, l’ipocrisia, l’impurità, la maldicenza. Quante terribili radici vanno strappate ancora; quanti ospiti indesiderati occorre spingere fuori, per liberare il campo e restituire, ai suoi “legittimi proprietari”, la nostra Casa! Abbiamo il dovere di custodirla e di adornarla con le opere buone “che dobbiamo e vogliamo fare”, come suggeriva il catechismo; abbiamo la responsabilità di renderla sempre più gradita al Signore e amabile agli occhi degli uomini.
Anche in questa epoca, devastata, sazia, incerta, ricca e disperata, il Regno di Dio continua a operare. Quel celeste Bambino sorride, anche oggi, nel cuore di chi vive nella sua Grazia. Dal Cielo continua a intercedere per noi presso il Padre ed effonde i suoi favori: come fece a Fatima, visibilmente, il 13 di ottobre del lontano 1917, quando la Sacra Famiglia levò la mano benedicente sul mondo.
San Paolo, nella lettera ai Galati (4,21 ss), parla di due donne, una schiava e l’altra libera. Di chi vogliamo essere figli? Paradossalmente, possiamo scegliere la nostra ascendenza, risalire ai nostri genitori. Figli della schiava, oppure della libera, cioè della Chiesa dei Santi e dei Martiri, degli educatori, dei missionari del Vangelo, degli eroi della carità. Di peccatori, certo, ma fiduciosamente aperti alla Grazia, che oggi ancora ci è data.
Come è bella la Chiesa, quando è una vera “Casa di preghiera”! Come è bella la Chiesa, nel maestoso silenzio di arcate millenarie o nella multiforme assemblea che si raduna in festa, per celebrare i misteri della vita, della morte e della gloria del suo Signore! Come è bella la Chiesa, famiglia dei credenti, che professano la loro fede e sanno portare ancora al mondo la “santa poesia” del Natale e la luce del Cristo Risorto!
La nostra vera gloria è la povertà e la essenzialità di Betlemme, l’umiltà e il silenzio di Nazaret, il solenne trionfo della Croce. La vera gloria sono le nostre pene, offerte con amore; è la fatica di pregare, quando incombono lo scoraggiamento, la tiepidezza e la stanchezza. La vera gloria è la fatica di perdonare; la vera regalità è il dominio di se stessi, è servizio, è pazienza, è mitezza, è misericordia. Sia tutto questo – e tanto di più ancora – il Santo Natale del 2011.
Sia questo l’augurio più bello, sgorgato dal cuore in festa, perché abitato dalla Grazia. Sia questo il cammino che prosegue, ogni giorno, con fatica ma con santa pazienza e con cristiana speranza, sorretto dalla “compagnia” della Chiesa, dalla intercessione dei Santi, verso la Gerusalemme del Cielo.
(Tratto da Maria di Fatima, mensile del Movimento Famiglia del Cuore Immacolato di Maria).
La presentazione al Tempio
Certo le porte al vostro incedere
si sono aperte vibrando da sole
e strana luce si accese sugli archi:
il tempio stesso pareva più grande!
Quando si mise a cantare il vegliardo,
a salutare felice la vita,
la lunga vita che ardeva in attesa;
e anche la donna più annosa cantava!
Erano l’anima stessa di Sion
del giusto Israele mai stanco di attendere.
E lui beato che ha visto la luce
se pure in lotta già contro le tenebre.
Oh, le parole che disse, o Madre,
solo a te il profeta le disse!
Così ti chiese il cielo impaziente
pure la gioia di essergli madre.
Nemmeno tu puoi svelare, Maria,
cosa portavi nel puro tuo grembo:
or la Scrittura comincia a svelarsi
e a prender forma la storia del mondo.
(David Maria Turoldo)
I vostri figli
I vostri figli non sono i vostri figli.
Essi sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di se stessa.
Essi arrivano grazie a voi, ma non da voi, e sebbene siano con voi, non vi appartengono affatto.
Potete donare loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri.
Perché essi posseggono i loro pensieri.
Potete dare una casa ai loro corpi ma non alle loro anime, perché le loro anime hanno dimora nella casa del domani, che voi nemmeno in sogno potete visitare.
Potete sforzarvi di farvi simili a loro, ma non pretendete di renderli simili a voi.
Poiché la vita non va all’indietro né indugia su ciò che è stato.
(Kahlil Gibran)
* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:
o serviti di:
– Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 2002-2003; 2005-2006.
– G. TURANI, Avvento e natale 2011. Sarà chiamato Dio con noi. Sussidio liturgico-pastorale, San Paolo, 2011.
– Messalino festivo dell’Assemblea, Bologna, EDB, 2007.
– Eucaristia e Parola. Testi per le celebrazioni eucaristiche di Avvento e Natale, a cura di Enzo Bianchi et al., Milano, Vita e Pensiero, 2005.
– La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.
– J.B. METZ, Avvento-Natale, Brescia, Queriniana, 1974.
– E. BIANCHI, Le parole della spiritualità. Per un lessico della vita interiore, Milano, Rizzoli, 21999.
– T. BELLO, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007.